E’ difficile circoscrivere l’opera di Hermann Broch con parole più precise di quelle utilizzate da Elias Canetti nel 1936 a proposito del grande capolavoro narrativo, la trilogia I sonnambuli, pubblicata tra il 1931 e il 1932. Ma in ultima analisi sono parole che Canetti avrebbe potuto utilizzare per circoscrivere anche il proprio capolavoro narrativo, Auto da fé, scritto nello stesso periodo e pubblicato nel 1935. Uno scrittore, ha osservato infatti Canetti parlando di Broch, è un “autentico” scrittore soltanto se nella sua opera è possibile ravvisare un aspetto fondamentale e dirimente: «La ferma volontà di dare una visione del suo tempo, una spinta all’universalità che non arretra spaventata di fronte a nessuna incombenza singola, che non elude, non dimentica, non trascura nulla, e che in nessun caso cerca facili scorciatoie». La trilogia de I sonnambuli, nello specifico, costituisce secondo Canetti «la realizzazione poetica della filosofia della storia di Hermann Broch, sia pure circoscritta alla propria epoca. La “disgregazione dei valori” vi è raffigurata in personaggi vividi e altamente poetici». Tutto verissimo.
Nato il 1° novembre 1886 a Vienna e morto esule a New Haven negli Stati Uniti il 30 maggio 1951, Hermann Broch proveniva da una famiglia di origini ebraiche. Fino ai quarant’anni si era occupato esclusivamente dell’azienda del padre, una manifattura tessile, e solo in seguito, nella seconda metà degli anni Venti, aveva cominciato a dedicarsi alla scrittura. La sua trilogia narrativa, che per mole, complessità stilistica (soprattutto per l’utilizzo del “flusso di coscienza” e del monologo interiore) e non da ultimo per l’intrinseca qualità di scrittura costituisce uno dei più grandi esordi dell’intero Novecento letterario (insieme ad Auto da fé di Canetti, non a caso), ripercorre e reinventa trent’anni di storia tedesca nell’ultimo scorcio dell’epoca guglielmina, dal 1888 al 1918, soffermandosi soprattutto sull’insorgere di nuove forme di vita sociale e sul torbido rimescolio dei ruoli e delle classi: il “romantico” Pasenow e l’“anarchico” Esch, protagonisti del primo e del secondo pannello, sono il lungo preludio alla cinica e irresistibile ascesa del “realista” Huguenau, protagonista del terzo e ultimo pannello.
Huguenau è l’individuo dei tempi nuovi, modello socio-antropologico di un’umanità di sonnambuli che si perderà poi negli orrori della barbarie nazista e infine nei perversi meccanismi di una società apparentemente libera, ma in realtà totalmente disumanizzata e disumanizzante. Ma a ben vedere -ed è questa l’incommensurabile e vertiginosa grandezza della trilogia- tutti i tre protagonisti sono “sonnambuli”, ognuno a suo modo: lo junker prussiano Pasenow con la sua anacronistica utopia romantica, l’impiegato Esch col suo sterile individualismo e l’uomo nuovo Huguenau col suo realismo che ormai non rimanda più ad alcuna “realtà”.
Il protagonista del secondo pannello, l’anarchico August Esch, trentenne impiegato di commercio che ha molte affinità col personaggio di Johannes Pinneberg nel quasi coevo E adesso, pover’uomo? di Hans Fallada, si situa esattamente a mezza via tra il l’astratto romanticismo di Pasenow e il non meno astratto realismo di Huguenau, con una sostanziale differenza: nel suo caso, infatti, l’anarchia non è un’astrazione, non è soltanto un connotato interiore oppure un modo di rapportarsi alla realtà, ma è la realtà stessa che lo soffoca e opprime. Molto simile anche a Ulrich de L’uomo senza qualità di Robert Musil, Esch conduce una strana e paradossale esistenza nella quale coesistono, elidendosi e insieme integrandosi vicendevolmente, «un’integerrima contabilità dell’anima» e «una peccaminosa condotta di vita». E’ infatti circondato da «un mondo in preda all’anarchia, in cui nessuno sa più se sta a destra o a sinistra, sopra o sotto», che lo porta a covare una rabbia sterile e impotente contro gli affaristi e i demagoghi di ogni tipo. Dal suo fallimento prenderà infine forma il “realista” senza realtà Huguenau, per il quale la disgregazione dei valori e l’assenza di un significato costituiranno l’unico orizzonte possibile.
https://rsi.cue.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/geronimo/Storia/Austria-Ungheria-un-impero-si-dissolve--1779854.html
Il narratore che più di ogni altro, per qualità di scrittura e spessore filosofico, ha individuato il tratto simbolico e paradigmatico del finis Austriae e del crollo della civiltà austroungarica è stato con ogni evidenza Robert Musil, che è riuscito a fondere nella propria opera, a partire da I turbamenti del giovane Törless fino al monumentale L’uomo senza qualità, i due aspetti sostanziali della grande cultura austriaca: l’“anima” e l’“esattezza”. Non è ovviamente questione di classifiche e graduatorie, anche perché i nomi sono tantissimi (Schnitzler, Roth, Hofmannsthal, Kraus, Zweig, solo per citarne alcuni, ma non bisogna dimenticare i presunti “minori” come Lernet-Holenia, Polgar e Altenberg) e si cadrebbe nell’imbarazzo della scelta. Tuttavia, se proprio si dovesse individuare il narratore che si è maggiormente avvicinato agli apici raggiunti da Musil, la scelta non potrebbe che cadere su Hermann Broch.
Esattamente come in Musil, infatti, anche in Broch l’“anima” coincide con l’utilizzo della reinvenzione letteraria per scendere in quei fondali melmosi dell’io che proprio in quel periodo, e nello stesso luogo, venivano scandagliati dalla psicanalisi di Freud. L’“esattezza” è invece riconducibile al nitore del dettato, più in generale alla precisione matematica -simile talvolta a quella di una partitura musicale, come sarà in seguito nei romanzi di Thomas Bernhard- con la quale vengono descritti il declino e il senso della fine. Non è un caso, del resto, che Musil e Broch, più ancora di Thomas Mann, siano stati i due narratori di lingua tedesca che nel corso del Novecento si sono maggiormente avvicinati -senza raggiungerla, perché irraggiungibile- alla dimensione utopica del “romanzo totale”, che avrebbe dovuto risolvere nella ferrea e coerente unità della struttura romanzesca la multiforme e sfuggente complessità del reale.
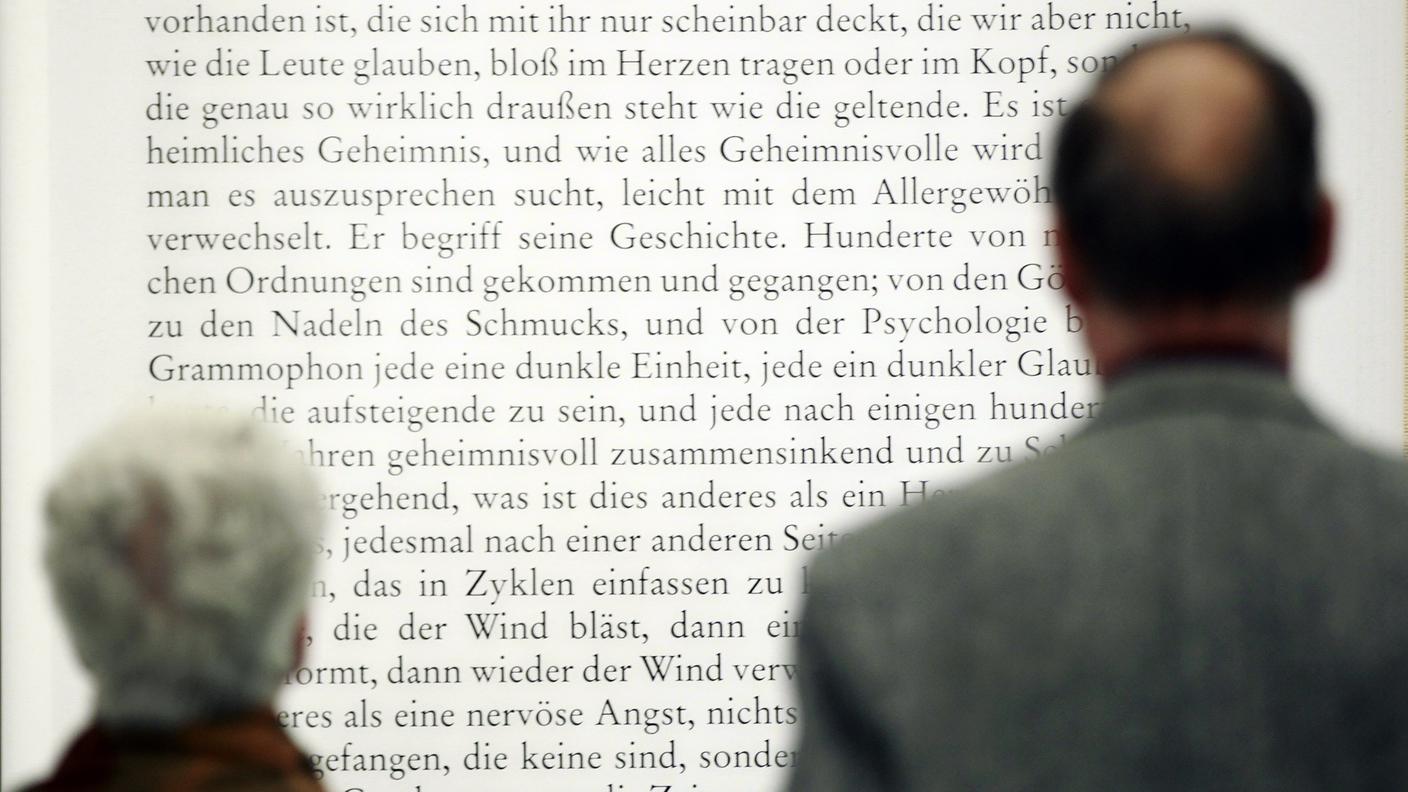
L’Uomo Senza Qualità di Robert Musil
Laser 27.08.2014, 13:45
Contenuto audio
Il sogno e l’utopia del “romanzo totale” percorrono come un leitmotiv non solo I sonnambuli, ma anche i tardi e possenti La morte di Virgilio (1945) e Gli incolpevoli (1950), due romanzi-fiume nei quali il sogno utopico diventa quasi un’ossessione -declinata soprattutto in lunghe digressioni di carattere filosofico e mistico- e sfocia nella constatazione della propria inconsistenza. Lo stesso Broch, peraltro, ha sintetizzato l’impossibilità del “romanzo totale” nella suggestiva metafora del “palco vuoto”, che in ogni teatro di ogni città dell’Impero Austroungarico veniva riservato all’Imperatore.
Quel palco -che naturalmente restava quasi sempre vuoto, perché l’Imperatore non poteva essere ovunque nello stesso momento- costituiva per Broch il simbolo di una “realtà” disgregata e perfino irreale, popolata di “sonnambuli” che non sanno di esserlo e presunti “incolpevoli” gravati di una colpa più o meno ancestrale e più o meno inconsapevole. Il “romanzo totale” era precisamente il tentativo, meraviglioso nel suo fallimento, di riempire quel palco fatalmente destinato a rimanere vuoto e di trovare la “parola” in grado di dire la “realtà”. Come dice il meraviglioso finale de La morte di Virgilio, «la parola si librava al di sopra del tutto, al di là dell’esprimibile e dell’inesprimibile», simile a «un mare sospeso, un fuoco sospeso, con la pesantezza del mare, con la leggerezza del mare, e tuttavia sempre parola». Una parola, però, «incomprensibilmente ineffabile, perché era al di là del linguaggio».
L’eco de La lettera di Lord Chandos di Hofmannstahl («l’indecenza dei segni») e della settima proposizione del Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein («Di tutto ciò di cui non si è in grado di parlare, si deve tacere») è ben più che avvertibile nel finale de La morte di Virgilio, che racchiude un po’ tutta l’eredità della grande cultura del finis Austriae. Il linguaggio non è soltanto incapace di restituire la realtà, ma è anche un ostacolo nella ricerca della realtà stessa, perché costituisce una strettoia tra i pensieri e le cose, con una duplice conseguenza: in primo luogo, le parole che vogliono dire le cose dicono qualcos’altro; in secondo luogo, la verità intesa nel senso di “realtà”, se anche esistesse, sarebbe indicibile, perché si situa oltre l’orizzonte del linguaggio dentro il quale si trovano gli esseri umani. Si racconta quindi l’impossibilità di raccontare, ma l’impossibilità, in virtù di un singolare quanto disperante paradosso, diventa essa stessa racconto.
L’universo poetico di Broch non si limita (si fa per dire) a I sonnambuli, La morte di Virgilio e Gli incolpevoli, che secondo Milan Kundera hanno «aperto una nuova strada alla forma romanzesca». Il compianto Italo Alighiero Chiusano, che si spese moltissimo per introdurre i lettori italofoni al mondo poetico di Broch, non privo di tratti estremamente impervi, ha più volte sottolineato l’importanza e il valore delle opere meno note e ingiustamente considerate minori rispetto alle grandi e complesse costruzioni narrative.
E’ un discorso che vale senza dubbio per Il racconto della serva Zerlina (1949), una libera variazione sul Don Giovanni che impressionò profondamente una lettrice di spicco come Hannah Arendt («Forse la più bella storia d’amore della letteratura tedesca»), ma vale soprattutto per i due romanzi L’incognita (1933) e Il sortilegio (1935), perché la connotazione “minori” può forse riferirsi al numero delle pagine e alla sostanziale linearità (o minore complessità) dell’intreccio narrativo, ma per il resto L’incognita e Il sortilegio possono tranquillamente competere coi tre “romanzi totali”.
Il già ricordato Chiusano ha perfino avanzato l’ipotesi -del tutto condivisibile- secondo la quale il meglio di Broch sarebbe da rinvenirsi proprio nelle pagine di questi due romanzi, in particolare per la «stupenda concretezza ambientale e umana» e la capacità di articolare «un messaggio che sopravvive al tempo», perché «si incarna in un fantasma artistico di prepotente, palpabile, allucinata presenza sensoria». Chiusano si riferiva in particolare a Il sortilegio, ma le sue considerazioni sono molto utili anche per circoscrivere L’incognita, che insieme al Törless di Musil è il romanzo austriaco maggiormente orchestrato sulla dialettica di “anima” ed “esattezza”.
Sullo sfondo di una Vienna plumbea e claustrofobica, che fa davvero pensare alla “stazione meteorologica della fine del mondo” evocata da Karl Kraus e anticipa certe atmosfere poi ricreate da Bernhard, un giovane matematico si aggrappa alla scienza, e quindi a tutto quanto è tangibile e misurabile, come ultimo baluardo contro una realtà sempre più frantumata e tentata dal demone dell’irrazionale. Ma la sua impresa, abbastanza simile a quella del “romanzo totale”, è destinata al fallimento e si perde in una passività riconducibile a quella di Ulrich ne L’uomo senza qualità.
L’“incognita” del titolo è precisamente la grandezza che in un problema fisico e matematico non è nota a priori, e quindi può essere determinata soltanto a partire da grandezze e numeri noti. Ma nel garbuglio dell’esistenza (nell’«infinito e inesauribile catasto del frammentario», secondo la celebre definizione di Musil) esistono simili grandezze e simili numeri? La scienza può davvero penetrare il mistero della vita e risolvere la sua equazione tanto complessa e sfuggente? E’ la vecchia questione dello “scarto irrazionale” ne L’uomo del sottosuolo di Dostoevskij, che Broch rilegge e ripropone in chiave novecentesca -si vorrebbe quasi dire “secolarizzata”, libera da ipoteche teologiche- e in un perfetto equilibrio, tipicamente austriaco, di “anima” ed “esattezza”.
Il sortilegio costituisce invece un lucidissimo e impietoso affondo nel cuore di tenebra del “secolo breve” e in un certi nativi quanto fanghigliosi recessi dell’animo umano. L’arrivo di un forestiero in un remoto e apparentemente tranquillo villaggio alpino scatena negli abitanti del luogo paure e istinti animaleschi. Il forestiero raccoglie attorno a sé un gruppo di fedelissimi, infiammati dai suoi discorsi e pronti a seguirlo. Pagina dopo pagina, come per effetto di un mostruoso sortilegio, la vita del tranquillo villaggio si trasforma in un sabba infernale, una specie di notte di Valpurga che coinvolge quasi tutti, e dalla quale nessuno esce totalmente indenne (si tratta, in sintesi, dell’assunto poi ampiamente svolto ne Gli incolpevoli). Il pensiero corre inevitabilmente all’ambiguo personaggio di Cipolla in Mario e il mago di Thomas Mann, ma Broch si spinge ancora più a fondo, anticipando temi e riflessioni che verranno sviluppati sul piano teorico da Canetti in Massa e potere.
Scritto due anni dopo l’avvento al potere dalla canaglia hitleriana, il romanzo si addentra infatti con matematica “esattezza”, ma anche con la poetica eleganza e raffinatezza dell’“anima” austriaca, nei subdoli meccanismi e automatismi psicologici che portano alla dittatura e al potere assoluto. La sua sinistra e perturbante attualità è ben più che evidente, a dimostrazione del fatto, come scriverà qualche anno dopo Bertolt Brecht ne La resistibile ascesa di Arturo Ui, che «sempre fecondo è l’immondo grembo» dal quale nascono dittature e totalitarismi. Tutto questo fa di Hermann Broch una coordinata letteraria più che mai imprescindibile, soprattutto per l’insistenza sul senso del declino e della fine (La morte di Virgilio, da questo punto di vista, è un romanzo davvero esemplare).
Thomas Mann diceva che ci sono uomini e destini “disperatamente tedeschi”. «Essere uomini è uno sbaglio», afferma invece un aforisma “disperatamente viennese” di Karl Kraus, che ha il retrogusto della condanna ed esprime anche il mondo e la “realtà” di Broch. Non deve quindi sorprendere che un suo fratello spirituale come Michelangelo Antonioni gli abbia reso omaggio in una scena fortemente simbolica del film La notte, uscito nel 1961, un anno dopo la prima edizione italiana de I sonnambuli pubblicata da Einaudi. «E’ anche una bella ragazza a leggerlo», dice Jeanne Moreau (che un quarto di secolo dopo sarà una straordinaria Zerlina sul palcoscenico del Théâtre des Bouffes du Nord di Parigi) a Marcello Mastroianni, riferendosi alla giovane Valentina, interpretata da Monica Vitti, che se ne sta in disparte e «si diverte da sola» leggendo il capolavoro di Broch, in mezzo al frastuono di una volgare e tristissima festa frequentata da un’accolta di “sonnambuli”. Forse “incolpevoli”, sicuramente sazi, disperati, profondamente inutili e pronti ad essere soggiogati dall’ennesimo sortilegio.





