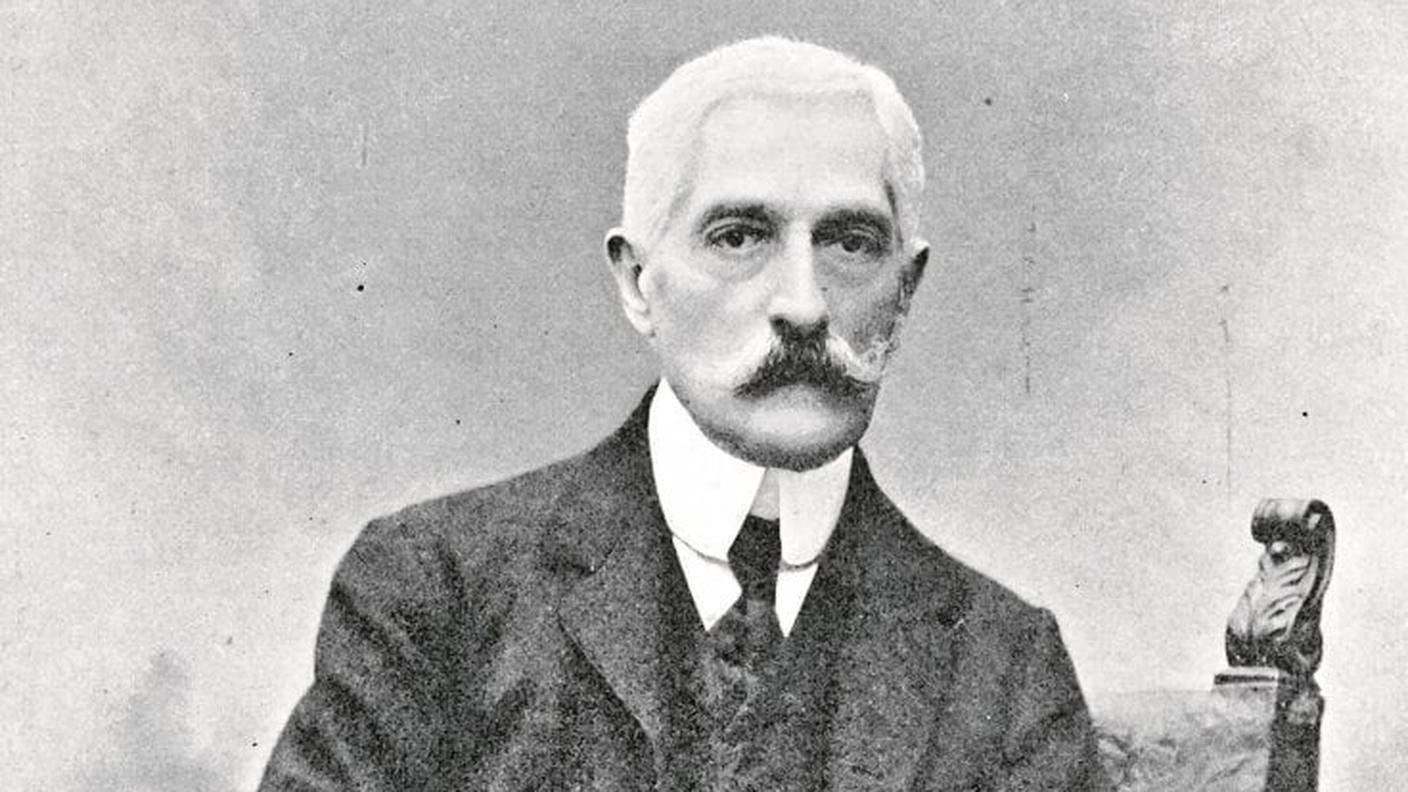Per avvicinarsi alla verità umana e poetica di Peter Bichsel, e insieme per apprezzare a fondo l’inestimabile eredità che ha lasciato con la sua vastissima opera, bisogna prendere spunto dalla risposta – molto elusiva e sorniona, in puro “stile Bichsel” – con la quale lo stesso Bichsel dava immancabilmente scacco matto agli intervistatori che ad ogni suo nuovo libro (soprattutto le raccolte di elzeviri, ma non solo) gli chiedevano perché mai scrivesse unicamente della vita quotidiana: «Perché non c’è altra vita che non sia la vita quotidiana…».
https://rsi.cue.rsi.ch/info/cultura-e-spettacoli/Morto-lo-scrittore-Peter-Bichsel--2676629.html
A volte, Bichsel ribadiva e ampliava il concetto, affermando che non bisogna mai illudersi di aver capito qualcosa in generale: nel mestiere di vivere (per riprendere il titolo del celeberrimo diario di Cesare Pavese, uno dei suoi autori d’elezione insieme a Gottfried Keller, Robert Walser e Pier Paolo Pasolini) non ci sono professionisti, ma soltanto dilettanti più o meno allo sbaraglio, perché in fondo la vita è qualcosa che non si sa cosa sia, ci si fanno molte idee, ma alla fine ci sono soltanto la quotidianità, le cose che si perdono e il tempo che passa.
Oltre che un grande scrittore e un narratore puro, Peter Bichsel era infatti una perfetta controparte e un ottimo interlocutore, sempre ricco di spunti, di riflessioni profondissime ma espresse con “ingenuità” schilleriana e soprattutto con la “leggerezza” tanto invocata da Nietzsche. Se mai si decidesse, in un futuro che si spera non troppo lontano, di raccogliere in volume una scelta delle interviste, la sua bibliografia si arricchirebbe di un titolo che potrebbe tranquillamente competere con le opere più celebri e giustamente celebrate: dalle Storie del lattaio fino a La doppia vita di Cherubin Hammer, passando per Le stagioni, le meravigliose Storie per bambini, i pamphlet come La Svizzera dello svizzero e ovviamente le numerose raccolte di elzeviri. Il suo paterno e fraterno amico Max Frisch lo aveva giustamente definito un “poeta” nel senso etimologico del termine, vale a dire un creatore e reinventore di realtà. Il germanista Peter von Matt, da parte sua, ha detto che tra cento anni, chiunque vorrà capire come erano gli svizzeri nella seconda metà del Novecento e all’inizio degli anni duemila, dovrà leggere Peter Bichsel.
Esiste soltanto la vita quotidiana, nella quale siamo tutti dilettanti. Sono due dati di fatto incontestabili e non privi di implicazioni, perché ne deriva che la “verità”, nella sua più intima essenza, esiste soltanto nei fenomeni, nelle cose che succedono perché succedono, nella trama di un tempo che in ogni suo istante è già perduto nelle voragini del passato e nelle nebbie del ricordo. Bichsel ha derivato questa consapevolezza da Robert Walser, soprattutto da un breve racconto intitolato Storia di Helbling, declinandola in termini molto personali e originali. Il suo fratello spirituale Gianni Celati, che lo ha più volte citato nei propri scritti, aveva parlato al proposito dell’“impensato della quotidianità”, una formula molto indovinata e molto utile anche per entrare nel “continente” Peter Bichsel, dove tutto è quotidiano ma anche impensato, e viceversa.
A differenza del pur amatissimo Flaubert (il suo romanziere preferito, insieme al Tolstoj di Guerra e pace), Peter Bichsel avrebbe avuto tutte le ragioni per affermare “Madame Bovary non sono io”, perché coi suoi racconti, i suoi romanzi, la sua produzione saggistica e soprattutto coi suoi elzeviri ci ha davvero fatto capire che le proiezioni immaginative e le astratte idealità non portano a nulla. La vita quotidiana è l’unica vita che c’è, e per giunta non è affatto banale, scontata e prevedibile, perché la quotidianità è costituita da un fitto reticolo di gesti, parole, atti mancati, azioni anche minime che si uniscono a formare la trama più autentica dell’esistenza nel tempo e il suo unico senso realmente possibile e perseguibile. Considerata all’interno di una simile prospettiva, ha scritto Bichsel prendendo le mosse da taluni esiti della produzione di Gottfried Keller (in particolare il tardo romanzo Martin Salander, suo dichiarato livre de chevet) la vita è come una “festa” continuamente differita, che forse prima o poi si svolgerà veramente.

Intervista a Peter Bichsel
Alice 25.01.2025, 14:40
Contenuto audio
Come sempre nei grandi scrittori, anche nell’opera di Bichsel ci sono molte cosiddette frasi originarie, che la spiegano in poche ma precise e penetranti parole. Nel suo caso, in realtà, la frase originaria è un brevissimo racconto, Sulla città di Parigi, che dà il titolo a una raccolta uscita nel 1993: «A Langnau, nell’Emmental, una volta c’era un grande magazzino. Si chiamava Zur Stadt Paris, “Alla città di Parigi”. E’ questa sarebbe una storia?» La domanda, ovviamente, è retorica: si sarebbe tentati di rispondere negativamente – il nome di un magazzino a Langnau nell’Emmental, che storia potrebbe mai essere? – e invece si tratta a tutti gli effetti di una storia, perché l’impensato del quotidiano è ricco di storie del genere, che si possono raccontare in poche righe ed esprimono qualcosa che le contiene e insieme le trascende: il “niente di speciale”, come lo aveva definito Cesare Zavattini.
Non deve quindi stupire che Bichsel abbia condensato e sintetizzato la propria poetica parlando di questo brevissimo racconto, questa storia/non storia: «Non credo che il senso della letteratura consista nel creare dei contenuti; credo piuttosto che il senso dello scrivere coincida e si identifichi col puro e semplice narrare, col raccontare storie. E questo perché gli uomini hanno bisogno di storie per sopravvivere, hanno bisogno di modelli che li mettano in condizione di raccontare la propria vita. Solo la vita che riusciamo a raccontare a noi stessi è una vita provvista di senso». La narrazione e il racconto, così concepiti, danno un senso alla vita perché la sottraggono al nulla comune e al muto apparire, e quindi la rendono dicibile, esperibile, in una parola: vivibile.
Ecco perché in Bichsel tutto è racconto: il gesto di una bambina, un ricordo, una cartolina postale, un portalettere costantemente in ritardo, le condizioni meteorologiche, un viaggio in treno, le chiacchiere da osteria, un uomo che vive fino a ottant’anni «perché quando era ventenne aveva dimenticato di suicidarsi», un nome, uno sguardo, una luce particolare, che uno stile attento ed estremamente sorvegliato – Bichsel scriveva benissimo, in un tedesco arioso e di squisita limpidezza, ma anche ricco di marcature dialettali – trasporta all’interno di una dimensione nella quale tutto è normalissimo ma insieme impensato.
Forse è una delle ultime, grandi poetiche prodotte dalla letteratura del secondo Novecento: “il ritmo sconnesso”, il recupero dell’oralità, la prevalenza della storia come racconto sulla storia come storicizzazione. La si potrebbe anche definire una poetica dell’ascolto, o della disposizione all’ascolto, come ha detto lo stesso Bichsel in chiusura delle cinque lezioni di poetica tenute nel 1982 all’Università di Francoforte e poi raccolte nel volume Il lettore, il narrare: «Signore e signori, cari amici, vi ringrazio. All’inizio avevo molta paura di voi, ma siete stati molto gentili e io ho preso a volervi bene perché ho visto che vi si può raccontare delle storie. Avete fatto una cosa che tutti noi dovremmo fare molto di più: avete dato il vostro consenso alle mie storie. Il mondo sarebbe più bello se consentissimo al nostro fidanzato o alla fidanzata, alla moglie, al marito, ai figli, anche al vicino, di raccontarci le loro storie».
C’è inoltre l’eredità dello scrittore politico, che ha riproposto una domanda – quante Svizzere esistono? – già presente nei due massimi scrittori di lingua tedesca dell’Ottocento: il bernese Jeremias Gotthelf, che ha svelato con molta crudezza l’altra faccia dell’idillio delle zone rurali, e il già ricordato Gottfried Keller, il citoyen zurighese che ha duramente criticato il pervertimento del liberalismo e dei principi della costituzione del 1848. Secondo Bichsel, ci sono sempre state due Svizzere: la “Svizzera degli svizzeri” e più ancora la “Svizzera dei non svizzeri”, che della Svizzera vedono soltanto le luci o al massimo i chiaroscuri, ma non le ombre. Insieme a Max Frisch e Friedrich Dürrenmatt, che hanno diffuso a livello internazionale un’immagine della Svizzera molto diversa da quella cristallizzatasi nella tradizione, Bichsel è stato tra i massimi esponenti del “patriottismo critico” (la definizione è di Peter von Matt), una corrente culturale che nella seconda metà del Novecento si è sforzata di fornire una lettura alternativa della realtà elvetica.
E’ a lui, in particolare, che si deve la sottolineatura della decisiva e fondamentale differenza tra indipendenza e autonomia. Anche le sue pagine sui limiti e certe storture del sistema democratico (non solo elvetico), nonché sul rischio di derive autoritarie, contenute in un lungo saggio del 1998 dal titolo Die Totaldemokraten, hanno qualcosa di sinistramente profetico e meritano di essere seriamente meditate. Il progresso, secondo Bichsel, dev’essere perseguito per il bene degli uomini (di tutti gli uomini), ma non deve trasformarsi in una presuntuosa e arrogante ideologia. Allo stesso modo, il capitalismo deve rimanere un sistema economico, senza trasformarsi in una visione del mondo, peggio ancora: nell’unica visione del mondo. E’ davvero impossibile dargli torto.
La Svizzera dello svizzero e gli altri suoi scritti di carattere politico e di critica sociale hanno inoltre contribuito a cambiare o comunque a rimodellare in maniera sostanziale la funzione dello scrittore all’interno dei confini elvetici, fissando un “prima” e un “dopo”. Si tratta di un’acquisizione di inestimabile valore, perché Bichsel, proprio riflettendo sull’impensato quotidiano, ha svelato fino a che punto il cosiddetto “privato” e il “pubblico” non siano scindibili e anzi si condizionino a vicenda. Come sosteneva il suo “antico maestro” Gottfried Keller: dalle fondamenta della casa al fumo che esce dal camino, tutto è politica.
Indossare le storie come abiti, diceva Max Frisch. Vivere raccontando, raccontare vivendo, per sopravvivere. E’ proprio vero: fra cento anni, se qualcuno vorrà capire cosa sia stata la Svizzera – i suoi oggettivi meriti, ma anche certe sue menzogne e fissazioni – nella seconda metà del Novecento e nei primi decenni del secolo ventunesimo, dovrà assolutamente ricorrere ai libri di Peter Bichsel. Ma lo stesso discorso vale per chiunque, sempre tra cento anni, avrà intenzione di capire le idee, le paure, le illusioni e speranze degli esseri umani di questi decenni, ovunque nel mondo. Perché pochi come Peter Bichsel sono riusciti a descriverle con tanta efficacia, naturalezza e ironia, partendo dall’impensato della quotidianità.
Nel 1981, quando Bichsel trascorse un anno come “scrittore residente” nella località di Bergen-Enkheim in Germania, Max Frisch aveva concluso il discorso elogiativo con queste simpatiche parole: «Cittadine e cittadini di Bergen-Enkheim, non viziatelo troppo, e soprattutto vedete bene di restituircelo, perché in Svizzera abbiamo bisogno di Peter Bichsel!». Sono parole tuttora validissime: Peter Bichsel, il suo ricordo e la sua presenza, si vorrebbe quasi dire la sostanza del suo “esserci” proustiano a prescindere dall’accidente biologico della morte, rimangono un punto di riferimento e un’immagine ideale. Ce n’è bisogno, oggi più che mai, non solo in Svizzera.
Hermann Hesse aveva detto che se Robert Walser avesse avuto centomila lettori, il mondo sarebbe stato migliore. Lo si potrebbe dire anche di Bichsel, proiettandosi in un ideale futuro: più lettori avrà, più il mondo potrà essere un posto magari non migliore, ma senza dubbio meno brutto, abietto e disumano. Chissà, forse un giorno la “festa” dell’impensato quotidiano si svolgerà davvero, e ci saranno schiere di lettori e lettrici di Peter Bichsel che costituiranno la testimonianza e la prova vivente di una sua frase di insidiosa e utopica bellezza: «Quando vedo per strada due persone che si abbracciano, si baciano oppure si tengono per mano, ho sempre l’impressione che abbiano letto lo stesso libro».
Incontro con lo scrittore Peter Bichsel
Neo 22.03.2025, 19:30