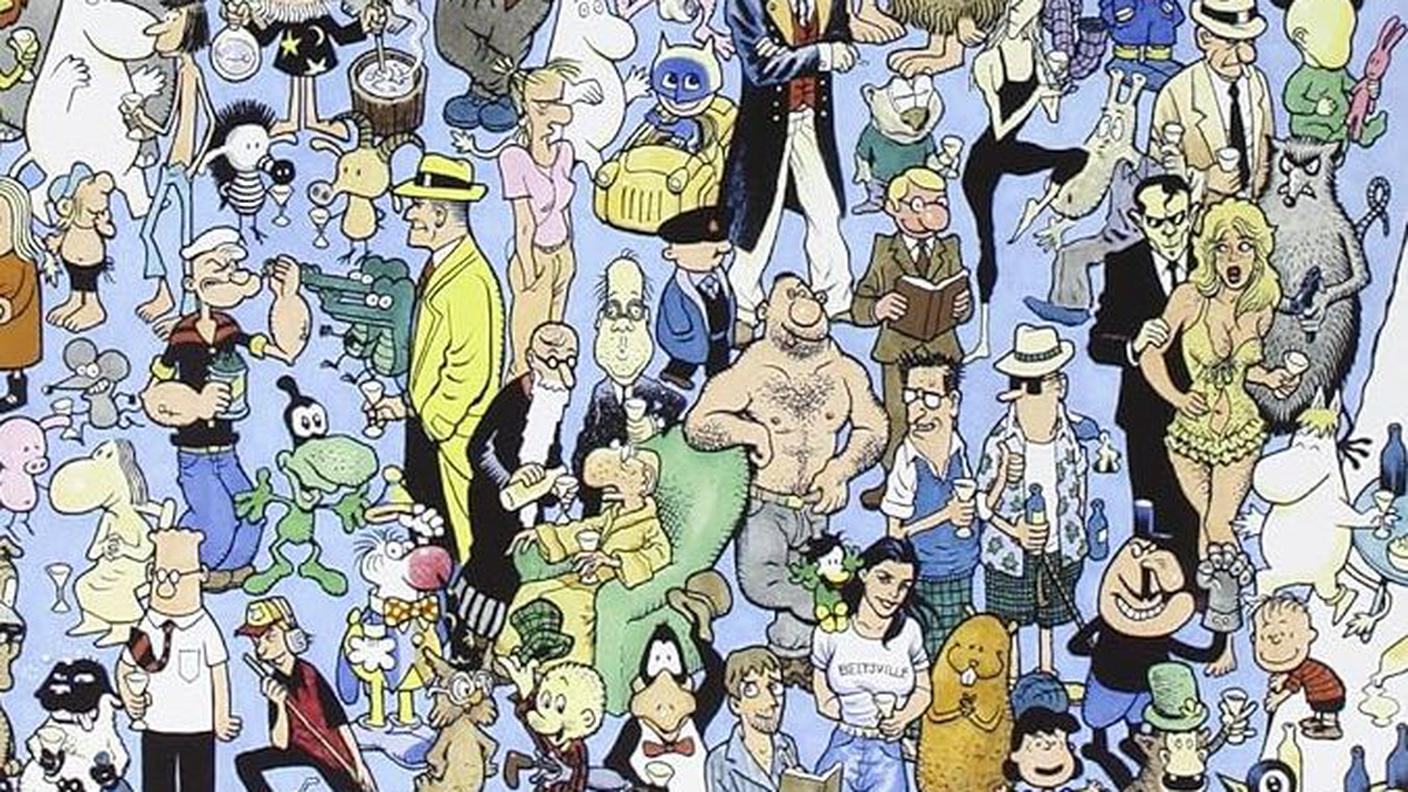Ci fu perfino chi coniò un puntuto e velenoso neologismo e giunse a parlare un po’ sprezzantemente di “norvegiomania”, designando con questo termine la vastissima eco suscitata nella cultura europea dalla letteratura scandinava della seconda metà dell’Ottocento. E non era uno qualunque, perché il neologismo “Norwegerei” fu coniato nientemeno che da Theodor Fontane, autore di “Effi Briest” e maestro indiscusso, insieme a Gottfried Keller e al quasi coetaneo e compaesano Theodor Storm, del realismo tedesco del secondo Ottocento. Come in ogni esagerazione, c’era molto di falso ma anche qualcosa di vero e sostanziale, perché in effetti la “norvegiomania” fu anche una moda.
Rimane comunque il fatto che la letteratura scandinava di quel periodo è stata di altissimo livello, perché ha prefigurato temi e motivi poi ampiamente ripresi e sviluppati nel corso del Novecento. Thomas Mann, ad esempio, che fece propria l’eredità del realismo di Fontane e Storm declinandola nel senso della decadenza e del disfacimento dei valori della tradizione, sottolineò a più riprese il proprio debito di riconoscenza nei confronti degli esponenti della “norvegiomania”.
I nomi, in alcuni casi, sono molto noti: i già ricordati Ibsen e Strindberg (il primo con la sua spietata analisi del cosiddetto “salotto borghese”; il secondo con la sua tormentata vicenda umana e poetica, la concezione dell’uomo come “carattere senza carattere” e della vita come “lotta di cervelli”), il critico letterario danese Georg Brandes, che svolse un fondamentale ruolo di mediazione tra la cultura scandinava e l’Europa continentale, i Premi Nobel Bjornson e Hamsun (entrambi norvegesi ma per il resto completamente agli antipodi: “poeta nazionale” il primo, saldamente ancorato alla tradizione e cantore di una presunta ingenuità nordica e del tipo antropologico “biondoceruleo”, poi ripreso da Thomas Mann nel “Tonio Kröger”; scrittore di immenso talento il secondo, critico lucidissimo del disagio della civiltà ma anche fautore, negli anni della vecchiaia, della forma più abietta di quello stesso disagio, la barbarie nazista), e poi ancora il danese Jens Peter Jacobsen, tra i primi traduttori di Darwin e acceso sostenitore di Nietzsche e del nichilismo, Alexander Kielland, Jonas Lie, il pastore protestante Kaj Munk, il bohémien rivoluzionario di Oslo Hans Jaeger, il decadente e morbinoso Ola Hansson (autore del vietatissimo romanzo erotico “Sensitiva amorosa”, che gli costò un lungo esilio, trascorso in parte anche in Svizzera) e non da ultimo Herman Bang e il suo genio tormentato, che non a caso influenzò il più fragile e sensibile dei figli di Thomas Mann, Klaus, morto suicida a soli 43 anni. La “norvegiomania”, insomma, era ben più che una semplice moda.
In questa vasta schiera di letterati, scrittori e drammaturghi, che hanno inserito all’interno di un nuovo contesto la percezione della realtà e hanno davvero afferrato alla gola le cose ultime della vita e della storia, merita di essere annoverato lo svedese Hjalmar Söderberg, che per troppo tempo, anche in patria, è stato ingiustamente considerato una figura marginale e di secondo piano. Nato a Stoccolma nel 1869 e morto a Copenaghen nel 1941, dopo gli studi compiuti a Uppsala Söderberg esordì come giornalista e in seguito si dedicò esclusivamente alla letteratura. Fu attivo soprattutto sul volgere del secolo, quando diede alle stampe il romanzo “Smarrimenti” (1895), la raccolta di novelle “Il disegno a inchiostro” (1898) e lo straordinario racconto in forma di diario “Il Dottor Glas”, pubblicato nel 1905. Un’altra opera narrativa, il romanzo “Il gioco serio” (1912), contiene molte tematiche e suggestioni poi riprese e sviluppate quasi alla lettera da Ingmar Bergman, soprattutto in film come “Una lezione d’amore”, “Sorrisi di una notte d’estate” e “Luci d’inverno”.
Per capire a fondo l’opera di Söderberg è tuttavia necessaria una premessa: come dimostrano molte traversie toccate al già ricordato Hansson e allo “scandaloso” Strindberg, che subì anche un assurdo processo per blasfemia, la Svezia prevalentemente pietista di quei decenni -soprattutto, ma non solo, in termini di costumi e diritti civili- non aveva nulla a che vedere con quella che è stata poi la Svezia socialdemocratica e progressista del “Folkhemmet”, la “Casa del Popolo”, esempio di una possibile “terza via” nel periodo della guerra fredda e modello di welfare e garanzie sociali.Giudicato scabroso dai benpensanti dell’epoca, in particolare per la sua spiccata capacità di mettere in evidenza tutte le ipocrisie e le gabbie della vita sociale, e anche perché le sue opere affrontano di petto temi estremamente spinosi e delicati -e purtroppo sempre attuali- come l’eutanasia, la violenza sessuale e l’aborto (soprattutto ne “Il Dottor Glas”, che in alcune parti è effettivamente piuttosto esplicito), Söderberg è stato scoperto con notevole ritardo, ma oggi lo si può finalmente leggere e apprezzare in tutto il suo valore. Talune sue considerazioni, pur latamente condivisibili, sono ad ogni modo oggettivamente difficili da metabolizzare. Basti pensare, solo per citare un esempio, a questo breve monologo del protagonista ne “Il Dottor Glas”, sull’aborto clandestino: «Una donna è venuta da me, disperata, e io ho promesso di aiutarla. Aiutarla, già… Cosa significava e cosa avrebbe significato, nessuno di noi allora poteva saperlo. Quel che lei mi chiedeva era così semplice e facile! Non mi costava né fatica, né dubbi… Rendevo un servizio delicato a una donna giovane e bella… E per lei significava felicità e vita… Dal suo punto di vista, che poi è diventato anche il mio. Perciò ho promesso di aiutarla, e l’ho fatto. Ho fatto quello che allora si doveva fare».
«La vita è un sogno che si sogna su un materasso troppo duro», diceva col consueto tono “canaille” il grande romantico tedesco Jean Paul, pseudonimo letterario di Johann Paul Richter. «La mia vita è un sogno oscuro e confuso», dice invece l’io narrante del racconto “Il sogno dell’eternità”: «Un giorno mi sveglierò in un altro sogno più vicino alla realtà e con un senso più profondo dell’attuale. Da quel sogno mi sveglierò in un terzo e poi in un quarto, e ogni nuovo sogno sarà più vicino alla realtà del precedente. In questo avvicinarsi alla verità consiste forse il senso misterioso e profondo della vita». Le grandi riflessioni che la cultura scandinava ha idealmente consegnato alla cultura europea del Novecento sono passate anche attraverso le pagine di Söderberg: la scissione tra la vita e la sua rappresentazione, la percezione della vita stessa e della realtà come un sogno, la disperata e disperante ricerca di un senso che non si mostra e forse non c’è, il vuoto, la frantumazione e l’assenza dei significati, la difficoltà di dialogo tra il maschile e il femminile come cifra simbolica della solitudine e dell’incomunicabilità.
Quest’ultimo tema, di chiarissima ascendenza strindberghiana ma svolto da Söderberg in maniera molto originale, forse meno immediata e aggressiva ma più ricca di semitoni che ricordano i drammi borghesi di Ibsen (viene da pensare a “Casa Rosmer”), è presente soprattutto in quello che rimane l’apice della sua produzione teatrale, il dramma in tre atti “Gertrud”, uscito in volume nel 1906 e rappresentato per la prima volta nel febbraio dell’anno successivo al Teatro Reale Drammatico, il “Dramaten” di Stoccolma, poi reso leggendario dalle messe in scena di Bergman.
“Gertrud” permette inoltre di capire fino a che punto le varie forme espressive e i differenti registri utilizzati dallo scrittore svedese si uniscano a formare una poetica molto solida e coerente, nonché una precisa visione del mondo e della realtà umana. Se è vero che esiste un “universo” strindberghiano e ibseniano, lo stesso si può dire nel caso di Söderberg, i cui personaggi vanno a costituire nel loro insieme una specifica commedia umana in chiave scandinava. Esattamente come “Il Verbo” del danese Kaj Munk, anche “Gertrud”, che in ultima analisi è più un testo per la lettura che per la scena, deve la propria fama internazionale alla celebre trasposizione cinematografica del grande regista danese Carl Theodor Dreyer, che nel 1964 ne prese spunto per firmare quello che sarebbe stato il suo ultimo lavoro e insieme il suo testamento umano e spirituale.
Il film di Dreyer, per quanto di altissimo valore, magistralmente orchestrato e recitato, rende giustizia solo in parte alla complessità del testo di Söderberg, la cui trama si fonda su una serie di rimandi o sottotesti, se così li si può definire, che possono essere pienamente colti solo in virtù di una lettura attenta e ripetuta. Molto affine alla Marie Grubbe di Jacobsen e ad Ellida Wangel, la “donna del mare” dell’omonimo dramma di Ibsen, proiettata in un futuro che diventa passato senza riuscire a cristallizzarsi nel presente, Gertrud è un’eroina tragica che incarna una visione impossibile dell’amore come unione totale.
Non lo trova nel matrimonio fallimentare con Gabriel Kanning, un losco politicante che la vede come mero oggetto e mezzo per un fine, ma nemmeno nella ricerca del “temps perdu” col musicista Lidman e poi col poeta Jansson. Alla fine, sola e disillusa, poco prima di morire, si rende conto che non soltanto la vita «scivola via tra le dita», ma anche la nostalgia della vita stessa, sia quella vissuta che quella non vissuta -o soltanto immaginata- nell’“amitié amoureuse” col fedele e adamantino Axel. Anche lei, insomma, come l’io narrante del racconto “Disegno a inchiostro”, non può che pronunciare la frase che più di ogni altra sintetizza la verità umana e poetica di Hjalmar Söderberg: «Sono passati tanti anni e non mi pongo più domande sul senso della vita. Ma non perché creda di averle trovate».