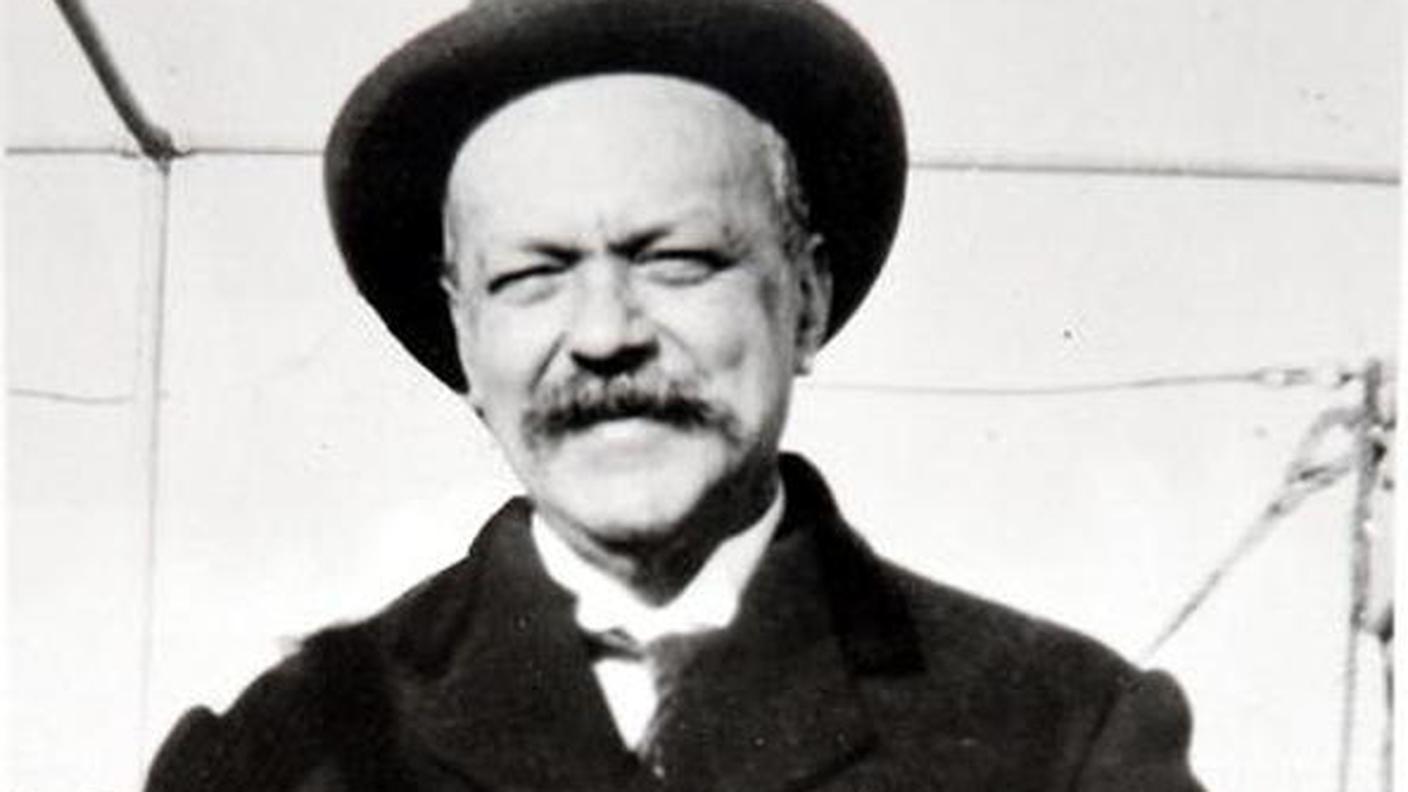La vecchiaia non rende più saggi, rende solamente più vecchi, ha scritto Knut Hamsun, quasi novantenne, in un passo del suo tardo e controverso memoriale “Per i sentieri deve cresce l’erba”, pubblicato nel 1949. Italo Svevo era morto da più di vent’anni, ma è lecito pensare che sarebbe stato in profondo disaccordo, perché dai frammenti del suo quarto romanzo, “Il vecchione” o “Il vegliardo”, pensato come continuazione de “La coscienza di Zeno”, ma anche dal testo teatrale “La rigenerazione”, si profila un’altra verità: la vecchiaia forse non rende più saggi e probabilmente rende davvero più vecchi, ma sicuramente rende meno “vivi” e quindi più liberi.
Svevo ha infatti investigato come pochi altri (al suo livello c’è forse il solo Ibsen dei drammi della maturità) il crepuscolo dell’individuo borghese e l’eclissarsi della cosiddetta “vita vera” sostituita dall’ansia di vivere, la riduzione del fin troppo celebrato e sopravvalutato “io” umanistico a un mero fascio di pulsioni schizoidi che tendono vanamente a qualcosa di astratto e inafferrabile. La vita così concepita e circoscritta è quindi nient’altro che una “malattia della materia” (la definizione è contenuta in una serie di schizzi e aforismi che prendono spunto da Nietzsche), una sorta di non meglio definibile processo infiammatorio che in determinate circostanze e per chissà quali motivi ha provocato una suppurazione della materia morta e un bel giorno si arresterà, tornando nuovamente alla dimensione inorganica e inanimata.
La diagnosi di Svevo, che con ogni probabilità costituisce davvero il punto di non ritorno del nichilismo novecentesco, è tuttavia declinata in chiave profondamente ironica e supportata da una terapia, se così la si può definire, che individua nel problema stesso la sua soluzione. Se la vita è una malattia della materia, uno spettacolo tragicomico e di dubbio significato, se il comune destino è quello di dimorare nell’assenza e nell’esilio, l’unico possibile spiraglio consiste nella riflessione (Svevo usa il termine “letteraturizzare”) e cioè nella distanza, nella continua oscillazione tra la vita e la sua rappresentazione. Nei frammenti del quarto romanzo, che costituiscono blocchi narrativi compatti e autonomi, il tipo antropologico dell’“inetto”, presente nei primi due romanzi “Una vita” e “Senilità”, lascia infatti spazio al “vecchio”, l’inetto per eccellenza, colui che ormai è irrimediabilmente escluso dagli ingranaggi dell’esistenza attiva. Ma è proprio in virtù di questa esclusione che la vecchiaia si configura come la condizione che avvicina maggiormente alla vita vera intesa come pieno possesso di sé. Nella vecchiaia, osserva Svevo in un passo del frammento intitolato “Il vecchione”, «la descrizione della vita, una grande parte della quale, quella di cui tutti sanno e non parlano, è eliminata, si fa tanto più intensa della vita stessa». L’unico modo per convincersi di aver vissuto e in ultima analisi per continuare a vivere consiste quindi nel “letteraturizzare” la vita, perché la scrittura è memoria e la memoria, a sua volta, è correzione e aggiustamento della vita, soprattutto perché produce quello che il vecchione definisce il “tempo misto”: «Continuo a dibattermi fra il presente e il passato, ma almeno tra i due non viene a cacciarsi la speranza, l’ansiosa speranza del futuro. Continuo dunque a vivere in un tempo misto com’è il destino dell’uomo, la cui grammatica ha invece i tempi puri che sembrano fatti per le bestie le quali, quando non sono spaventate, vivono lietamente in un cristallino presente. Ma per il vegliardo la mutilazione per cui la vita perdette quello che non ebbe mai, il futuro, rende la vita più semplice», perché «quando la nostra memoria ha saputo levare dagli avvenimenti tutto quello che in essi poteva produrre sorpresa, spavento e disordine, si può dire che essi si sono trasferiti nel passato».
Slegata dalla farragine della “realtà”, che assilla continuamente con obblighi e doveri, la vecchiaia permette di vivere in un puro presente ignaro di passato (ormai cristallizzato, ordinato e risolto nella memoria) e di futuro (un tempo incertissimo e comunque ristretto). La salvezza dalla vita come malattia della materia consiste insomma nel tacito, elusivo e dissimulato ritrarsi dalla scena, nel diritto -finalmente acquisito- di mostrare le ferite inferte dal tempo, di portare apertamente le insegne della sconfitta e di preservarsi dagli scacchi e dai fallimenti ai quali la vita, con le sue vane e ansiose speranze, continua fatalmente ad esporre.
«Già il presente non si può andar a cercare né sul calendario né sull’orologio che si guardano solo per stabilire la propria relazione al passato o per avviarci con una parvenza di coscienza al futuro. Io le cose e le persone che mi circondano siamo il vero presente», dice l’io narrante all’inizio del frammento intitolato “Il mio ozio”. Rifiutare un simile privilegio significa molto semplicemente rituffarsi nel magma e nella confusione della «vita orrida vera», come accade a Giovanni Chierici, il protagonista de “La rigenerazione”, che non tollera la propria inettitudine di vecchione, si sottopone a un’operazione di ringiovanimento ed è costretto a fornire nuove dimostrazioni della propria vitalità. Cercherà la conferma in un ridicolo quanto catastrofico amorazzo ancillare, che non farà altro che ridurlo a parodia e caricatura di se stesso. Perché la libertà e la salvezza sono nella “vecchiaia selvaggia”, non nella fissità della dialettica salute/malattia, non nei miraggi, nelle illusioni e nella corsa dietro il vento della vita attiva, col suo passato non risolto e il suo futuro continuamente differito.
Ecco allora che i vecchi, vecchioni e vegliardi di Svevo sono impegnati a «scribacchiare giornalmente», anzitutto «perché è una misura di igiene», e poi perché «quando si scrive della vita la si rappresenta più seria di quanto non sia» e la vita stessa appare come attutita e modificata, smorzata nella memoria e nell’astrazione. Quando Svevo diceva che «fuori dalla penna non c’è salvezza» si riferiva precisamente a questa funzione lenitiva della scrittura, che nel vecchione rappresenta un gioco mai concluso, un ventaglio di possibilità che in quanto tali si oppongono all’ingombrante presenza della “realtà” e della «vita orrida vera». E’ pressappoco per gli stessi motivi che Max Frisch, alcuni decenni dopo, parlerà della scrittura come “vita al congiuntivo”.
Scettico e disincantato, e per quanto amante dei paradossi, Svevo non si spinge ad affermare che la vecchiaia è l’unica vera esistenza, però la identifica con l’unica età della vita nella quale è possibile avvertire, tra le fessure del tempo, qualcosa che assomiglia alla persuasione. Ogni presunta epicità, ogni patetico impeto faustiano sono ormai aboliti, e il vecchione, come si può leggere in uno degli ultimissimi frammenti, non ha più nulla da chiedere a Mefistofele in cambio della propria anima: gli rimane soltanto la scrittura, il “letteraturizzare”, che è pochissimo ma anche tantissimo, perché gli permette di volgere uno sguardo alla propria vita, di sorridere della sua insensatezza e perfino di ciò che potrebbe accadere in un futuro più o meno lontano, come dicono le ultime righe de “La coscienza di Zeno”, quando «ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie».