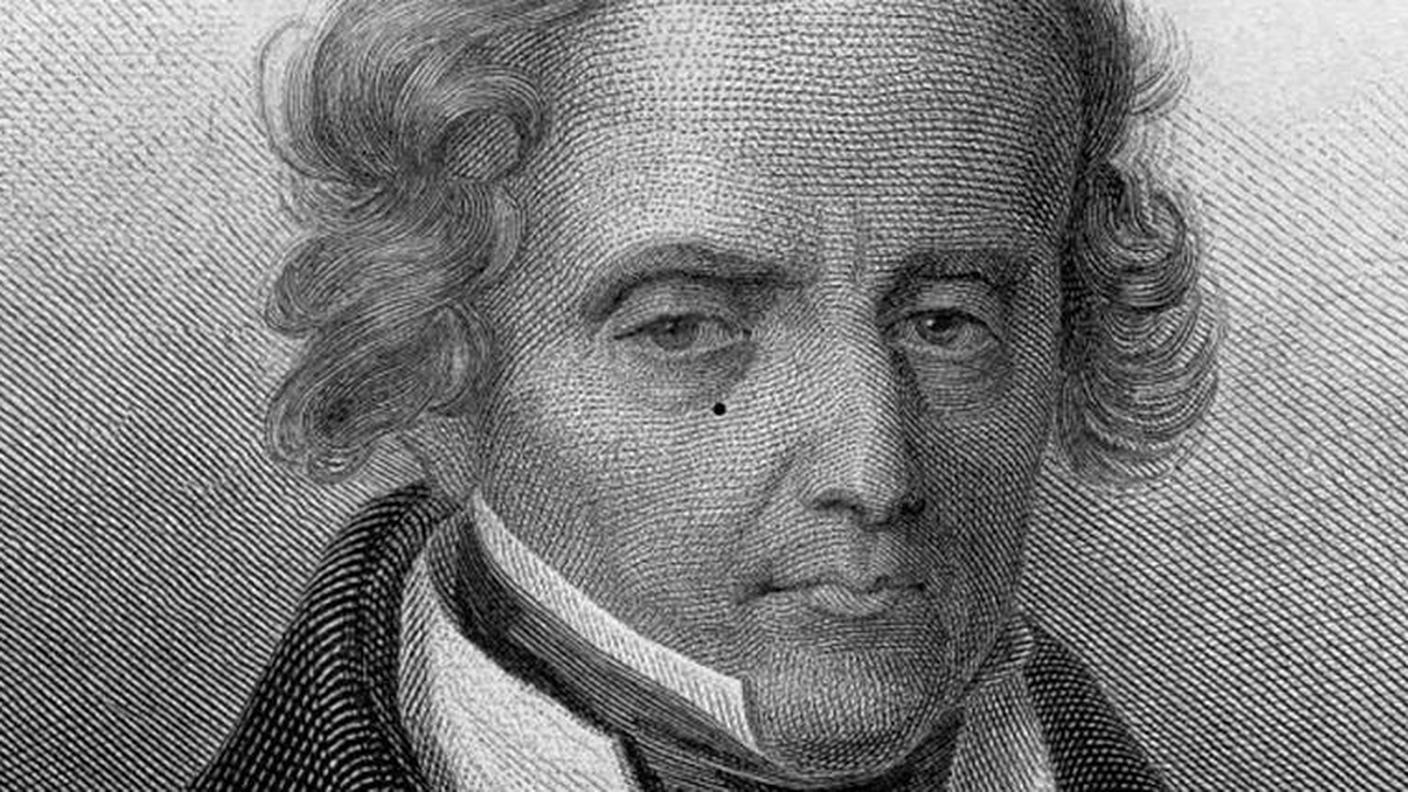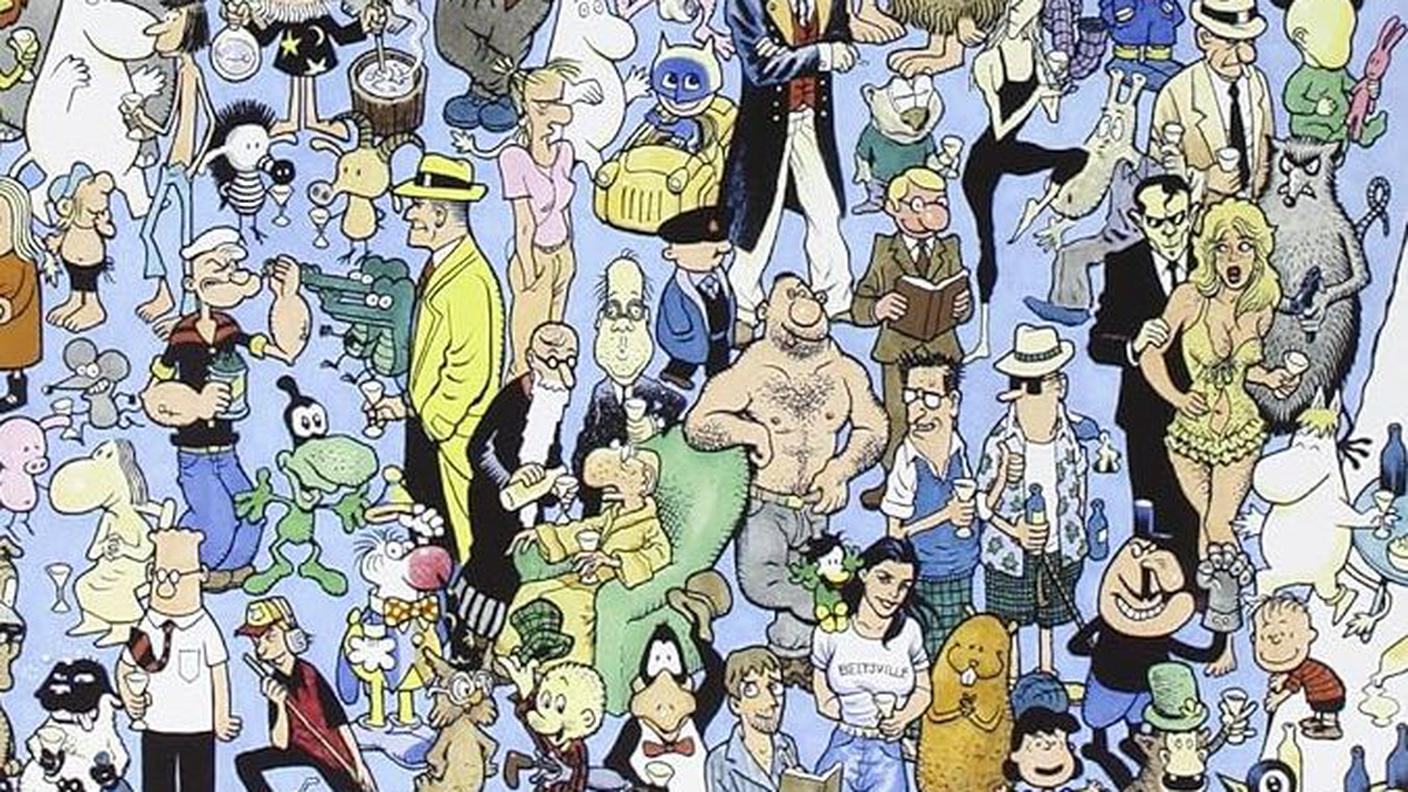Sono probabilmente anni che ci domandiamo quale sia stato, quando sia stato, in quale preciso momento della Storia, il confine tra l’Africa tradizionale e quella corrotta dall’avvento della civiltà. E il primo nome che ci torna al pensiero, pensando non solo all’Africa ma al primitivo in quanto tale, è inevitabilmente quello di Claude Lévi-Strauss. Nel suo celeberrimo Tristi tropici – e con una connotazione teorica più rigorosa nel Pensiero selvaggio – l’antropologo francese è infatti stato il testimone oculare, secondo la sua stessa definizione, di che cos’era la vita delle ultime popolazioni incontaminate del pianeta.
Ma questo senso di “ultimità” – se vogliamo chiamarlo in chiave apocalittica – questo senso di “tramonto”, di “occaso”, di “terminalità”, questo fatale e tragico senso di “fine” del mondo primitivo – che cerca per sé una data e un luogo conclusivi – non è solo nelle pagine della migliore antropologia: lo ritroviamo anche, nelle forme dell’autobiografismo e del memoriale, in un altro libro celeberrimo: "La mia Africa" di Karen Blixen. E naturalmente, essendo quel testo ambientato negli anni Trenta del secolo scorso, la domanda a cui cerchiamo una risposta potrebbe risuonare: Allora la fine del primitivo, la fine del diritto alla primitività, coincide con la fine del secolo XIX?
È molto probabile che sia così. Poiché in effetti il Novecento, tra le numerose rivoluzioni che portò con sé, fu anche, ai suoi esordi, l’ultimo secolo in cui l’ignoto della primitività, l’oscuro universo della vita selvaggia, il tempo della pura e intatta “barbarie”, smise di essere tale, obbligando i popoli ancestrali a confrontarsi con l’arrivo dei “bianchi” e quella multiformità di culture che era nel deposito delle tradizioni arcaiche a uniformarsi vieppiù a quella mostruosa creatura chiamata omologazione. O, se vogliamo, globalizzazione. O, volendo essere più precisi, occidentalizzazione.
Insomma, "La mia Africa" è una sorta di testamento della capitolazione: l’ultimo grido di verità di chi viveva, credeva, pensava, desiderava e pregava come era prima della civiltà e a prescindere dalla civiltà. E Karen Blixen, lungi dall’esserne stata la meravigliata spettatrice, se ne è dimostrata la partecipe protagonista.
È infatti lì, nel cuore dell’Africa, che la “baronessa” Blixen abitò per quasi un ventennio della sua vita: sugli altipiani del Ngong, a stretto contatto con quei popoli la cui primitività sta oggi inesorabilmente scomparendo. I Masai, con la loro fierezza e fragilità, la loro sporcizia e la loro totale incapacità di subordinarsi a qualsiasi forma di coercizione; i Somali, dai tratti puri e dalla diffidenza connaturale, con la loro domestichezza con il deserto e la loro predispozione ai commerci; i Kikuyu, con la loro antica ritualità, le loro danze, i loro totem, i loro tabù, la loro indistruttibile fedeltà al destino e al fato, all’inesorabilità del cosmo e della natura.
In questo quadro, la Blixen oscilla tra memorialistica, sociologismo e autobiografia e costruisce quello che in un certo senso è il canto finale del mondo cosiddetto “primitivo”. Un canto che ha il pregio, come in genere nei libri non ideologici, di non raccontare un idillico “mondo antico” risparmiato alla meschinità e al male, ma di presentarci un universo di valori che nella loro radicale diversità da quelli moderni, per così dire “civili”, diventa un fondamentale contraltare alla nostra presunzione di superiorità.
Quanto l’Africa ha prodotto è in effetti ancora oggi una risorsa irrinunciabile. E custodirne la memoria è uno dei doveri a cui un partecipe lettore di Karen Blixen dovrebbe sempre essere sensibile. Non stiamo parlando di semplici tradizioni culturali, ma di connotazioni dell’umano che la civiltà, il progresso, la modernizzazione e l’occidentalizzazione hanno gradualmente perduto o sacrificato per strada: il ritualismo, il senso del sacro e dell’onore, la priorità del tribalismo e dell’identitarismo sulla mera convenienza mercantile, la sensibilità ai simboli, la subordinazione ai disegni del destino, la devozione agli spiriti.
Potremmo naturalmente deridere – leggendo “esoticamente” il libro della Blixen – tali patrimoni dell’antico. Ma in verità, tanto nell’epoca della scrittrice danese quanto ai nostri giorni, quei retaggi sono un valore esortativo fondamentale: laddove viviamo nella convinzione che il progresso, lo sviluppo e la cosiddetta civilizzazione siano il portato di un miglioramento oggettivo, essi ci invitano viceversa a non averne nessuna certezza definitiva. Poiché è vero, dal profilo del mero benessere materiale tale miglioramento è indiscutibile, ma sul piano della immediata umanità non è escluso che il primitivo ci riporti a un senso di peggioramento, o perlomeno a un senso di perdita, altrettanto indiscutibile.
Le pagine di Karen Blixen ne sono allora una sorta di irrecusabile testimonianza: il primitivo vale almeno quanto il moderno, la primitività almeno quanto la civilizzazione. E saper trovare la quadra o un punto di intesa tra le due dimensioni non significa “nostalgismo” bensì consapevolezza storica. Significa riconoscere che ogni tempo ha i suoi tesori e che cancellare quelli ancestrali equivale a denegare la presunta superiorità di quelli moderni.