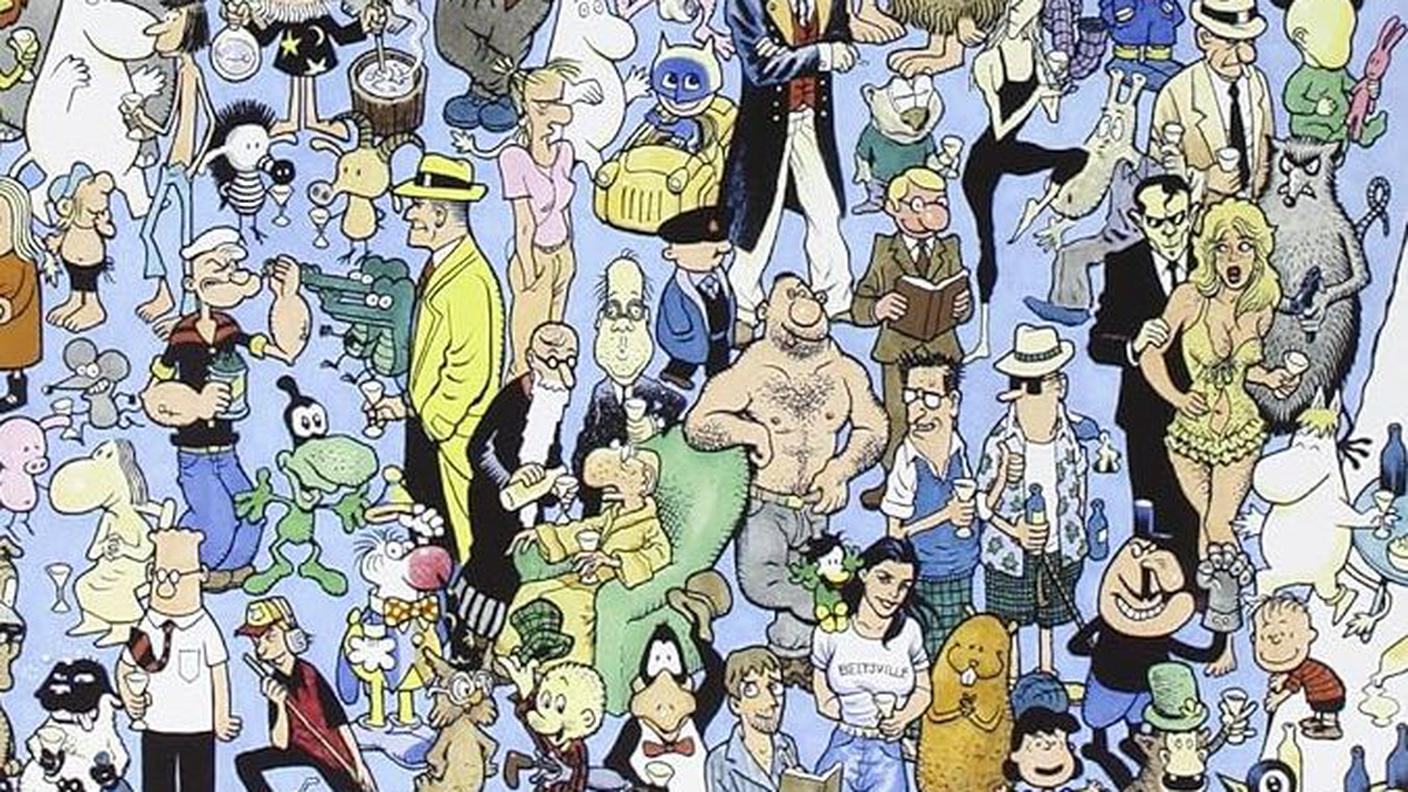Dici Alessandro Manzoni e, d'acchito, pensi al suo cattolicesimo provvidenzialista, alla sua ossessione agorafobica, al suo provincialismo universalista, alla sua anaffettività verso i figli, alle sue nevrosi, frutto di un’infanzia poco protetta e poco accudita (la madre, Giulia Beccaria, era una donna libera e disinvolta, ma poco attenta alla prole). Tutte cose vere, basta leggere il libro imprescindibile di Natalia Ginzburg (La famiglia Manzoni) per farsi un’idea delle molteplici sfaccettature biografiche.
Manzoni raccontato da Claudio Cesare Secchi
RSI Cultura 07.04.2015, 00:00
Ma, allo stesso tempo, se ti metti a rileggere I Promessi Sposi, lontano dai luoghi comuni e dai ricordi scolastici, scopri che Alessandro Manzoni fu innanzitutto un autore assolutamente avanguardistico per la sua epoca. Il gioco ironico che instaura con il lettore, quel suo dialogo costante, atto a metterlo in guardia di fronte alla realtà rappresentata, segnalando la veridicità dei fatti storici, evidenziando le implicazioni etiche, suggerendo insomma da che parte stare, fanno de I Promessi Sposi un supremo esempio d'antiromanzo. Se a questo aspetto, poi, si aggiungono i continui giochi intratestuali e intertestuali, le citazioni nascoste (a partire dal memorabile incipit paesaggistico, che discende da una citazione di Daniello Bartoli, il grande narratore secentesco), ecco che improvvisamente il testo manzoniano si trasforma in una scatola catottrica in cui è custodita l'intera memoria letteraria.

Umberto Eco parla di Alessandro Manzoni
RSI Cultura 07.04.2015, 00:00
A questi aspetti puramente narrativi occorre aggiungere ovviamente la sua ossessione per la lingua, che è la gioia dei filologi e dei variantisti («prima minuta», «seconda minuta», «copia per la censura»: questi sono solo alcuni dei nomi usati per le diverse stesure). Sull’enorme lavoro linguistico (che è epitome della complessa officina letteraria di Alessandro Manzoni), basti qui ricordare che la stesura de I promessi sposi inizia nel 1821. La prima versione, frutto di mille ripensamenti, sarà conclusa nel 1823. Gravida di moralismo, di digressioni storiche e frutto di una lingua che mischia toscanismi, francesismi e latinismi, verrà pubblicata solo nel 1915, con il titolo di Fermo e Lucia, per mero gusto filologico (e forte del successo della versione finale, intitolata appunto I promessi sposi). Il Manzoni, infatti, insoddisfatto del risultato linguistico e narrativo, ripulisce la prima versione dalle infinite digressioni e rende l’intreccio più agevole e meno didascalico. Nasce così la Ventisettana (1827): una versione che ancora non soddisfa il Manzoni, che è alla ricerca di una lingua che sia emblema dell'unificazione culturale (una sorta di ideale metastorico della lingua). Prenderà così corpo la famosa versione «risciacquata in Arno», scritta in una sorta di italiano toscanizzato, la cosiddetta Quarantana che uscirà in fascicoli tra il 1840 e il 1842.
Se la lingua e la narrazione fanno de I promessi sposi un testo ultramoderno, una sorta di antiromanzo alla Sterne, anche le inserzioni critiche e morali del Manzoni meritano un’attenta ricontestualizzazione. Da questi interventi si evince infatti che il cattolicissimo Alessandro Manzoni si schiera in realtà con Renzo (tanto che I promessi sposi possono anche essere letti come una sorta di Bildungsroman del Tramaglino), e critica per contro l’indolente Don Abbondio. Allo stesso tempo il narratore prende le parti della povera gente («gente meccanica e piccol affare») e si scaglia contro il Potere, sia esso linguistico, ecclesiastico o classista, stigmatizzando il «latinorum» di Don Abbondio, la protervia dell’Azzecca-Garbugli, il sapere inutile di Don Ferrante, e la ricchezza di Don Rodrigo.
A questa invettiva contro il Potere Alessandro Manzoni affianca un'altra filippica, quella contro il «particulare». Manzoni individua infatti nell’egoismo (nell’avere a cuore solo il proprio interesse) il grande problema dell’Italia (di ieri, di oggi e di domani). In altre parole il Manzoni si scaglia contro l’etica del calcolo e dell’interesse personale, celebrando invece la via del collettivismo e dell'universalismo.
Giorgio Orelli legge e commenta Alessandro Manzoni
RSI Cultura 07.04.2015, 00:00
Ulteriore esempio dello stravolgimento dei luoghi comuni si ha a proposito della religiosità di Alessandro Manzoni. Di norma su questo tema si evoca il concetto della Provvidenza, che interverrebbe a favore dei giusti (e che è invito alla rettitudine morale). Ne I Promessi Sposi, però, i conti non tornano: Renzo e Lucia si ammalano e guariscono dalla peste; ma la stessa sorte tocca al Griso. Muore invece Don Cristoforo, il più santo fra gli uomini, e questa sorte non è certo compensata dalla morte di Don Rodrigo. Insomma, la Provvidenza sembra non avere influenza sulla sorte degli uomini, e semmai si vede nel gesto umanissimo di Renzo allorché decide di offrire tutto ciò che ha a una famiglia di mendicanti, dicendo: «Là c’è la Provvidenza». La religiosità del Manzoni è dunque una religiosità che contempla sì l’intervento divino, cui però si sommano altri fattori come la fortuna, l’ingegno, l’etica e il Male.
Già, il Male. Nella storia di amore fra Renzo e Lucia, che alla fine si sposeranno, oltre alla Provvidenza si intrometterà costantemente anche il concetto di Male. Infatti, allorché lasceranno la terra natia per andare a vivere a Bergamo, dovranno sempre fare i conti con «qualche fastidiuccio» (la mala sorte si frappone, insomma, alla loro felicità).
Il ritratto di Alessandro Manzoni a 150 anni dalla morte, oltre ai ricordi scolastici, non può pertanto non tener conto di questi aspetti, ovvero che il maggior romanziere dell'Ottocento italiano fosse un uomo metodico e ossessivo, un grande unificatore della lingua e della cultura italiana, uno scrittore assolutamente modernista ed avanguardista.
Altri video dagli Archivi RSI