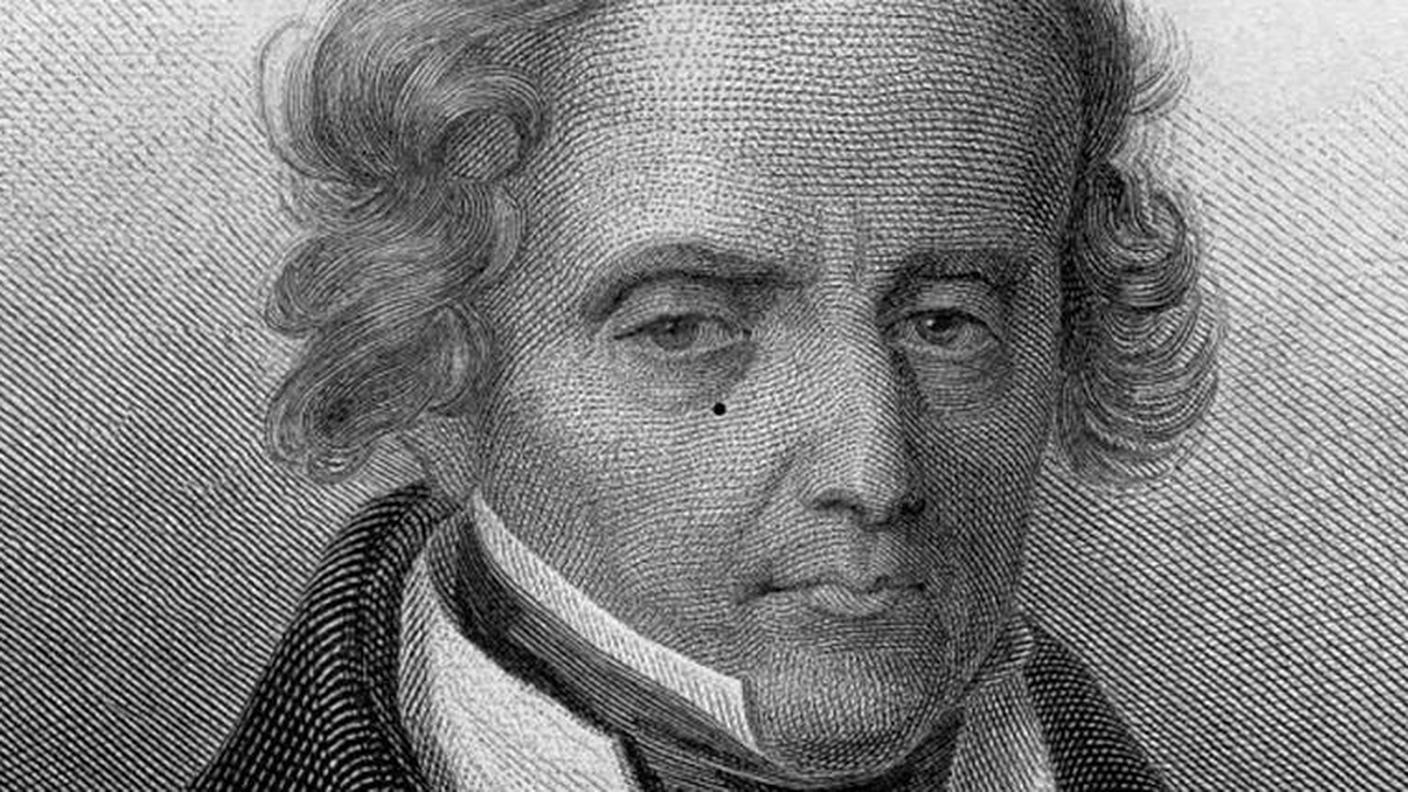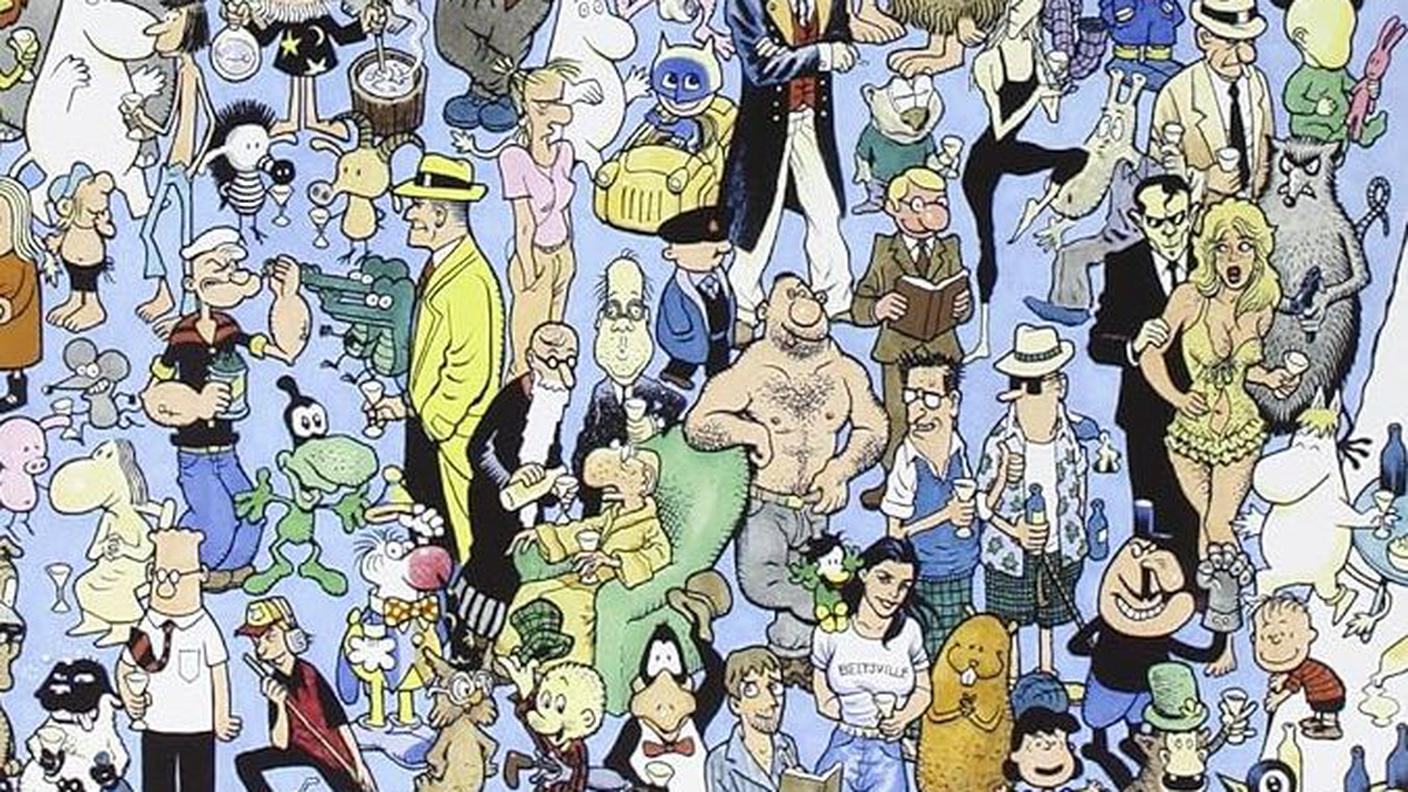Il libro più complesso e denso di Dostoevskij (11 novembre 1821- 9 febbraio 1881) è anche il suo libro più breve: Memorie del sottosuolo (da taluni tradotto in Memorie dal sottosuolo). Non è un romanzo, non è un saggio, ma letteratura prestata alle altitudini dello spirito: è quello che si potrebbe chiamare il linguaggio del pensiero quando raggiunge le ineffabili regioni dell’irrazionalità. Filosoficamente parlando, è l’espressione realizzata di che cosa sia la razionalità quando si pronuncia in nome del suo contrario e della sua contraddizione.
E che cosa pronuncia la razionalità, cosa testimonia la ragione, quando deve farsi carico di rivelare quella quintessenziale dimensione dell’uomo che è la sua vita mentale, il territorio segreto dei suoi processi sommersi? Lo potremmo dire riprendendo le parole che Dostoevskij affida al suo ragionamento: “La ragione, signori, è una bella cosa, è indiscutibile, ma la ragione non è che la ragione e non soddisfa che la facoltà raziocinativa dell’uomo, mentre il volere è di tutta la vita umana, con la ragione e con tutti i pruriti. E sebbene la nostra vita, in questa manifestazione, riesce sovente una porcheriola, pur tuttavia è la vita, e non è soltanto un’estrazione di radice quadrata”.
In queste frasi – le citazioni dal volume potrebbero essere infinite – si coglie un dato fondamentale: l’arbitrio con cui il pensiero raziocinante, a partire da quello matematico-scientifico, dimentica con deliberato ottimismo l’abisso in cui si sostanzia l’umano e il suo “è così perché è così” che lo rende consapevolmente, se necessario, anche riprovevole. In altre parole l’incapacità sostanziale del razionalismo e del linearismo logico-morale di individuare la più essenziale profondità dell’animo umano non già nel “vasto oceano dell’inconscio” (Platone) ma lasciandosi bastare la minuscola isoletta della coscienza. Un approccio che richiama, ben al di là del facile misticismo degli irrazionali, quel mondo come volontà e rappresentazione che Schopenhauer, precursore di Nietzsche (pensiamo alla “transvalutazione di tutti i valori”), razionalmente riconsegnò alle oscure, inafferrabili profondità del pensiero vedico e della impensabilità dell’essenza.
Continua, d’altra parte, con ironico distacco Dostoevskij: “La ragione sa solamente quello che è riuscita a conoscere (...) mentre la natura umana agisce nella sua interezza, con tutto quello che contiene, coscientemente e inconsciamente, e magari dice il falso, ma vive”. Ecco: in pochissime parole – magari dice il falso, ma vive – Dostoevskij ci ricorda che qualunque tra i princìpi ai quali l’uomo ha voluto affidare il compito di determinare la chiarezza e la verità dell’esistenza – e perché no, della Storia – può essere ineccepibile dal punto di vista della logica scientifico-matematica, ma non per questo rivela realmente ciò che la natura umana è quando vive ovvero quando scopre, per dire così, la sua ipercoscienza. In altre parole: niente è più insidioso dell’essere persuasi che nella giustezza di un principio razionale si conservi anche il quid inarrivabile della vita e del vivere.
Per questo Dostoevskij scardina, nelle Memorie del sottosuolo, ogni comodo e compiaciuto moralismo: perché ogni moralismo pretende di ricondurre l’esistenza a un ordine o a un senso, mentre la vita – l’essenza del vivere – è più barbaramente e irragionevolmente una scommessa con il disordine e il caos: a tal segno è anzi sussiego nei confronti del caos e dell’irrealizzato, dell’inesausto itinerario verso un approdo e un risultato, da essere paradossalmente un tributo all’imperfezione: “L’uomo diventerà pazzo apposta per essere privo di ragione e tener duro!”
Siamo così all’apoteosi di questo ribaltamento dell’ovvio e del convenzionale, del canone e del buon senso. Laddove l’uomo è più integralmente se stesso – cioè indifferente alla prassi di volersi risolto – là non può palpitare che la voluttà della follia, là la follia diventa addirittura una dimensione dell’essere scientemente perseguita, là la follia non è tracollo o deriva ma apogeo dell’essenziale.
Superfluo, allora, riconoscere le implicazioni di questo approccio all’umano e al vivere. Ogni dimensione dell’esistenza ne viene toccata: dalla Storia (di cui “tutto si può dire tranne che sia uno spettacolo ragionevole”) alla stessa Civiltà, l’uomo finisce per rivelarsi come il portatore involontario di un sottosuolo da cui nessuna pretesa razionale riuscirà mai in definitiva a sottrarlo. Non fosse perché, appunto, “il volere molto spesso e anzi per lo più dissente del tutto e ostinatamente dalla ragione”.
Marco Alloni