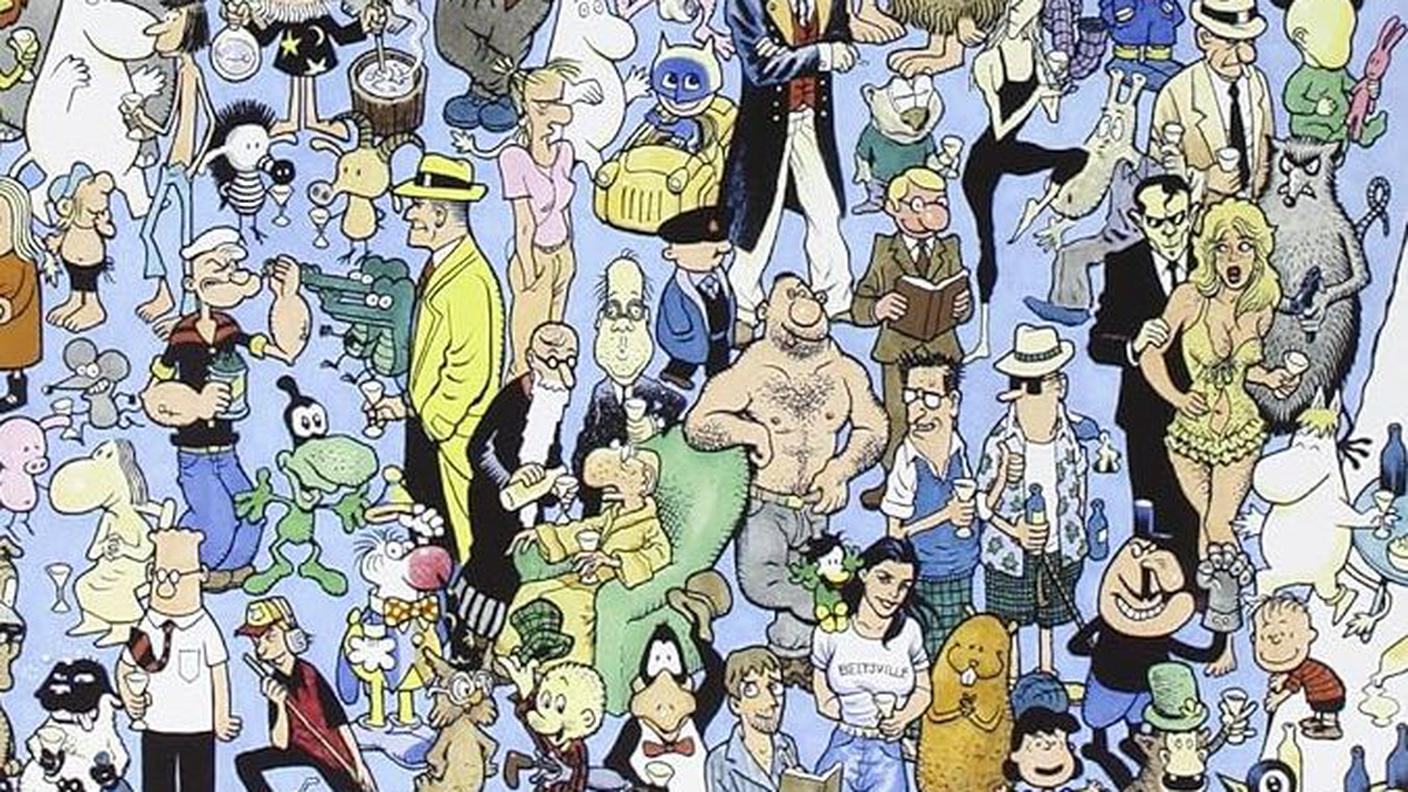Quando, una ventina di anni fa, andai a visitare la casa di Pablo Neruda a Isla Negra, in Cile, capii quasi subito con chi avevo a che fare e perché il poeta del Canto general avesse raggiunto i cuori di tante persone. Perché Neruda era – secondo una qualifica che quasi mai si presta ai poeti e tanto meno alla poesia – un uomo simpatico.
Sì, malgrado i suoi modi neghittosi, a tratti burberi e trasognati – come magistralmente rievocati da Philippe Noiret nel Postino di Neruda – egli era in primo luogo, intimamente e spiritualmente, simpatico. Lo era per così dire in ottemperanza all’etimo della parola: lo era perché l’intera sua vita e opera furono syn-patheia, furono pathos delle cose e adesione al destino degli altri. A partire, naturalmente, dai diseredati e dai semplici per arrivare a quella partecipazione generale al mondo che fu l’insieme della sua opera.
La sua casa di Isla Negra – una dedalica dimora onirica a ridosso delle calette dell’Oceano, da cui sembra che Neruda non si sia mai spinto in acqua perché incapace di nuotare (lui che adorava immensamente il mare) – ne è la dimostrazione. La seriosa e mortifera austerità del Cile golpista di Pinochet – che di fatto portò a morte il Cile di Allende nelle stesse ore in cui uccise “in contumacia” il poeta – è lì in grande stile derisa e motteggiata dal tripudio di vitalismo che promana dagli ambienti.
Ambienti giocosi, ambienti di fantasia e di capricci immaginativi, ambienti di false porte, di librerie sterminate che nascondono vani inaccessibili, ambienti di oggetti e anticaglie delle dimensioni e forme più variegate. Ambienti, in una parola, dove una sorta di sofisticato “feticismo maturo” incontra gli incantamenti puerili per cantare e decantare la ricchezza e la policromia del mondo.
Ma non solo in senso geografico – gli spostamenti, come ambasciatore e soprattutto come esule, di Neruda per il mondo non si contano – bensì in primo luogo in senso temporale: Isla Negra è una sorta di precipitato, di quintessenza della memoria. Il Tempo riacquista lì il suo dominio sull’oblio, ogni terra solcata dal poeta torna a vibrare attraverso gli oggetti che la richiamano, ogni passo della sua vita si riflette nel presente attraverso le suggestioni materiali – ninnoli, polene, amuleti, vasellame – che egli recupera dal passato.
Si direbbe, a livello architettonico-decorativo, una versione fisica di ciò che Neruda ha raccolto in termini culturali nel suo libro di memorie Confesso che ho vissuto. Un titolo beffardo e a suo modo magniloquente, forse vanitoso dell’ingenua vanità di chi realmente può vantare di aver vissuto, ma che nella sua fluviale semplicità riesce a farsi sintesi di una vita sempre magistralmente in bilico tra pericolo e incantamento.
Pablo Neruda, "Abbiamo perso"
Colpo di poesia 20.05.2022, 22:00
Contenuto audio
Perché di questo, omaggiando Neruda nel cinquantenario della morte, è obbligatorio rendersi conto: che se la sua vita di comunista o di poeta civile è stata una vita militante, la sua opera di scrittore l’ha riflessa in tutte le sfumature e varianti che la militanza, il concetto di militanza, porta con sé. O si milita forse solo per il Partito, la Causa, l’Ideologia? In verità Neruda, dal primo all’ultimo verso scritto nella sua intensa vita di paladino della giustizia e dell’eguaglianza, ha celebrato in primo luogo la Vita e la Libertà. La Vita nella sua essenzialità, nelle sue lotte, nella sua policromia, nei suoi bagliori e nelle sue ombre: il sesso, l’amore, l’incantamento per il femminile, la natura e i suoi risvolti di enigmaticità. Ma poi anche la Libertà come espressione originaria dell’essere al mondo: liberi e uguali tranne quando qualcuno ci impedisce di esserlo.
Il suo comunismo in forma di vitalismo e viceversa vanno dunque letti in questa chiave: laddove qualsiasi voce offerta a celebrare la vita è poesia (“La poesia è sempre un atto di pace. La poesia nasce dalla pace come il pane nasce dalla farina”), ogni atto che pretende di tacitarla è tirannia. E contro la tirannia è vano opporre una contraria e speculare tirannia: contro la tirannia può qualcosa solo lo spirito poetico.
In questo senso Neruda è a un tempo un romantico e un drammatico, un elegiaco e un rivoluzionario. Lo è perché in questa cointeressenza tra poesia è pace si esprime necessariamente ogni possibile forma di rivoluzione morale contro dittature e satrapie. E la sua “simpatia” a questo fondamentalmente si àncora: non già per suscitare riso o divertimento, gaudio o sollazzo, bensì per ricordare al lettore – agli esseri umani – che tutto merita di essere celebrato. E che laddove anche solo una carota (ricordiamo la sua emblematica Ode alla carota) è negata allo sguardo e allo spirito poetico, la vita è già esposta all’autorità, la libertà è in pericolo, la dittatura è pronta a riassumere il proprio dominio sulle cose.
Isla Negra, nella sua natura metonimica, è quindi la più eloquente “poesia” di Neruda: in essa ogni minimo oggetto della vita e del ricordo palpita per raccontare il negletto miracolo della vita in sé, la cui difesa spetta ai ribelli che impugnano le carabine contro i generali, ma la cui conservazione eterna può essere solo nelle mani della parola.