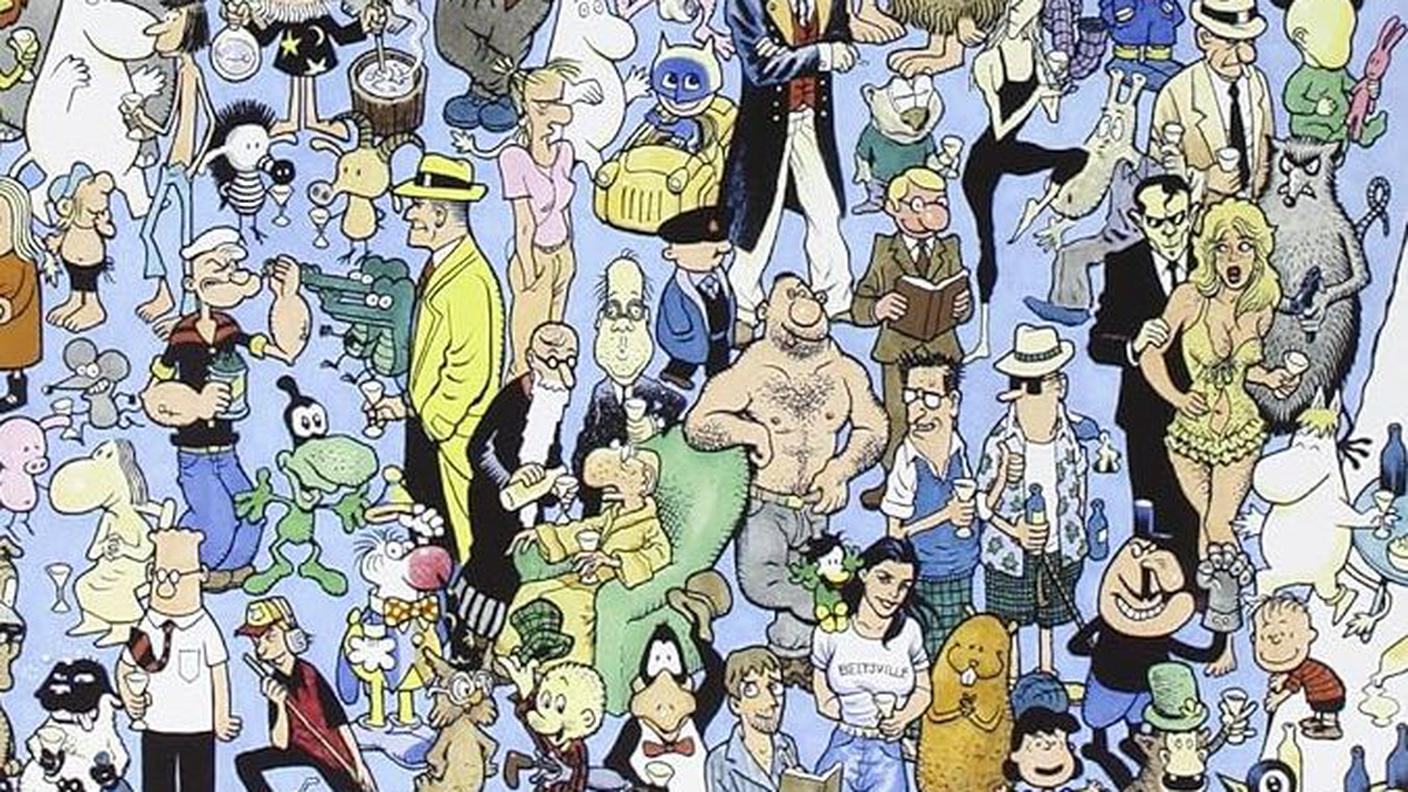Il progenitore, se così lo si può definire, è stato Antonin Artaud, che col suo “teatro della crudeltà”, teorizzato tra la fine degli anni Venti del secolo scorso e l’inizio del decennio successivo, ha fissato un “prima” e un “dopo”, indicando la via verso territori inesplorati e delineando una concezione completamente nuova della messinscena, del suo messaggio e dei suoi contenuti. Artaud pensava in particolare a un teatro finalmente libero dalla psicologia, più vicino ai dati elementari della vita (i «veridici precipitati») e «alle patologie che consumano le esistenze, con le esistenze stesse che si consumano nelle patologie» (secondo la celebre e penetrante definizione di Hugo von Hofmannsthal). Gli spettacoli dovevano quindi abbattersi come una “peste” sul pubblico, minando alla base il conformismo delle presunte élites culturali e fornendo una lettura alternativa dell’esistente, nella consapevolezza -diventata nel frattempo ben più di una consapevolezza- che «non siamo liberi» e «il cielo può sempre cadere sulla nostra testa».
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/play-top/Luomo-che-pens%C3%B2-limpensabile--1130262.html
Tutte le avanguardie del Novecento si sono poi inserite in questo solco, che Artaud ha tracciato un po’ ovunque nei suoi scritti ma soprattutto all’inizio di un saggio del 1926, consacrato al teatro del suo grande modello Alfred Jarry: «Il teatro partecipa del discredito in cui, una dopo l’altra, cadono tutte le forme d’arte. In mezzo alla confusione, all’assenza, al deterioramento di tutti i valori umani, all’angosciosa incertezza in cui siamo immersi, riguardo alla necessità e al valore di questa o quell’arte, di questa o quella forma di attività dello spirito, la più colpita è probabilmente l’idea di teatro. Se il teatro non è un gioco, se è una realtà vera, il problema che abbiamo da risolvere è quello dei mezzi attraverso i quali restituirgli quest’ordine di realtà, fare di ogni spettacolo una sorta di avvenimento».
Come tutte le grandi utopie, anche quella di Artaud è rimasta tale. Ci sono stati tuttavia alcuni momenti di estrema vicinanza alla sua realizzazione, in particolare per quanto riguarda l’idea del teatro come “pestilenza” e lettura radicalmente altra della realtà. Il primo è ravvisabile nella breve stagione degli Angry Young Men, i “giovani arrabbiati” che in Inghilterra, nella seconda metà degli anni Cinquanta, portarono sui palcoscenici tutta la rabbia nei confronti di una società che si rispecchiava e insieme si giustificava in un teatro ancora fermo alle dinamiche sociali dell’anteguerra.
https://rsi.cue.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/blu-come-unarancia/Antonin-Artaud--866260.html
Il secondo momento, caratterizzato soprattutto da una profonda riflessione sullo specifico del linguaggio teatrale -e più in generale sul linguaggio come potenziale e spesso effettivo strumento di potere e coercizione-, è invece individuabile nella vivacissima scena drammaturgica austriaca della seconda metà degli anni Sessanta e nelle opere del suo massimo rappresentante, l’enfant prodige e ai tempi giovanissimo Peter Handke, che tra il 1966 e il 1970, non ancora trentenne, diede alle stampe cinque cosiddette “pièces vocali” (Sprechstücke) di vaga ascendenza beckettiana- il pensiero corre agli Atti senza parole- ma segnate da una cifra stilistica molto personale e non priva di una spiccata originalità: Insulti al pubblico, Profezia, Autodiffamazione, Richieste di aiuto, Il minore vuole il tutore e Quodlibet.
Il testo più significativo, anche perché si presenta come una sorta di manifesto programmatico, è senza alcun dubbio Insulti al pubblico (1966), che si fonda sul totale abbattimento della “quarta parete” e su un effetto di straniamento declinato non già con intenzioni didattiche e quindi ideologiche, come nel caso di Brecht, ma piuttosto nel segno di un sovvertimento dell’idea stessa del teatro nella sua accezione tradizionale, con gli attori che recitano e il pubblico che assiste allo spettacolo. Quella che viene messa in scena è invece la “crudeltà” nel senso desiderato da Artaud, con gli attori che recitano non recitando e il pubblico che è spettatore e insieme attore, perché riceve gli insulti degli attori, che a loro volta diventano spettatori (o per meglio dire: ascoltatori) della propria recita.
Le coordinate vengono quindi sovvertite, soprattutto quando gli attori si rivolgono in questo modo al pubblico: «Verrete insultati, perché anche l’insulto è un modo di parlare con voi. Insultando possiamo diventare diretti. Possiamo far scoccare una scintilla. Possiamo distruggere lo spazio d’azione. Possiamo demolire una parete. Possiamo tener conto di voi. Poiché vi insulteremo, voi non ci starete più ad ascoltare, voi ci starete a sentire. La distanza tra noi non sarà più infinita. Poiché vi insulteremo, la vostra immobilità e la vostra rigidità appariranno finalmente in tutta chiarezza».
In alcune interviste dell’epoca, Handke aveva affermato che lo spettatore deve essere lasciato solo con se stesso, perché soltanto in questo modo può giungere a una percezione che non rimanda ad alcun significato ma si giustifica proprio in quanto percezione, prima di ogni possibile interpretazione, che in quanto tale è già un’ideologia o perfino una forma di controllo. Il finale di Insulti al pubblico, che in realtà è un non-finale di un non-spettacolo, esemplifica in maniera molto chiara questa idea della percezione: «Subito cala il sipario. Tuttavia non resta chiuso, ma torna subito ad aprirsi, indipendentemente dal comportamento del pubblico. Gli attori stanno in piedi e, senza guardare nessuno, volgono gli occhi verso il pubblico. Attraverso gli altoparlanti il pubblico viene fragorosamente applaudito e sonoramente fischiato; inoltre attraverso gli altoparlanti si possono forse far sentire anche le reazioni del pubblico a un concerto di un gruppo beat. Le grida e le urla assordanti durano fino a quando il pubblico se ne va. Soltanto allora il sipario cala definitivamente». Qui non c’è nulla che corrisponda alle consuete attese del pubblico: nessuna azione, nessun dramma, nessuno svolgimento. Il pubblico viene invece insultato dagli attori -dalle voci degli attori- per la sua passività, la sua acquiescenza, la sua necessità di sentirsi al sicuro. Si tratta davvero, con ogni probabilità, del punto di massimo avvicinamento all’utopia di Artaud e di uno degli apici del teatro del secondo Novecento.
Si dice spesso, naturalmente in maniera provocatoria e sul filo del paradosso (ma un paradosso che contiene anche una discreta dose di verità), che il teatro inteso come sperimentazione e re-invenzione della realtà sul palcoscenico è finito con Beckett. Muovendosi sul filo del medesimo paradosso, si può aggiungere che il teatro, almeno come sperimentazione linguistica, è forse finito con questi lavori del giovanissimo Handke, nello specifico con Insulti al pubblico, perché in seguito nessuno si è spinto tanto a fondo e ha messo così fortemente in questione l’essenza stessa del linguaggio teatrale, il suo senso e le sue potenzialità comunicative.
E’ un discorso che vale per lo stesso Handke, che ancora negli anni Settanta e in parte del decennio successivo, con le celebri sceneggiature per i film di Wim Wenders e le prime originalissime prove narrative, aveva perseguito con estrema coerenza e un’altissima qualità di scrittura le idee innovative e per molti versi rivoluzionarie contenute nei testi teatrali degli esordi. L’idea, in particolare, espressa chiaramente nella definizione “pièce vocale”, che lo spettacolo teatrale potrebbe e anzi dovrebbe fornire un’immagine del mondo fatta di fonemi che contengono il mondo stesso e quindi lo esprimono. Romanzi come Breve lettera del lungo addio, Lento ritorno a casa e Nei colori del giorno, per citare tre titoli, sono la declinazione in chiave narrativa di questa idea originariamente teatrale.
Il Nobel eurocentrico
Laser 11.10.2019, 09:00
Contenuto audio
Poi, come talora succede a chi scrive molto bene (e Handke, che è un narratore puro e dotato di un talento nativo, scrive davvero benissimo, con uno stile che in tedesco si definisce gemeistert, ricercato e sorvegliatissimo, ma insieme arioso e di squisita limpidezza), ha cominciato a specchiarsi in maniera un po’ narcisistica nella propria perfezione di stile, con una ricerca spesso eccessiva e francamente un po’ arida del celebre mot juste flaubertiano. E’ principalmente a questo Handke che è stato assegnato il Premio Nobel, non certo al giovane e coraggioso eversore dei Sprechstücke. Anche la sua collaborazione nel 2016 con Wenders per la versione cinematografica del testo scenico I bei giorni di Aranjuez, che ha visto la coppia (il trio, a dire il vero, perché nel film c’è anche un cameo che vede protagonista Nick Cave, già presente ne Il cielo sopra Berlino) riformarsi dopo circa un trentennio, si è risolta in definitiva in un elegantissimo e ricercato esercizio di stile, formalmente perfetto, ma piuttosto privo di nerbo e di anima.
Ma oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, che effetto fanno gli “insulti” che il giovane drammaturgo e futuro Premio Nobel rivolgeva al “pubblico”? Cosa rimane del suo personalissimo effetto di straniamento e della sua versione del teatro della crudeltà? Non si può negare che il tutto abbia un sentore quasi di archeologia, ma si tratta di un’archeologia -per dirlo con un ossimoro- sinistramente attuale e perfino familiare. Il che dimostra fino a che punto avesse ragione un altro grande eversore del teatro come Ennio Flaiano, autore di un testo totalmente “rivoluzionario” come La conversazione continuamente interrotta e teorico dello “spettatore addormentato” quale spettatore ideale, quando aveva detto -pressappoco nello stesso periodo degli esordi di Handke, con uno dei suoi consueti paradossi/non paradossi- che l’autentico straniamento e il vero teatro della crudeltà vanno ormai cercati fuori dai teatri. In effetti li si può trovare ovunque, nell’eterna, straniante e crudele tragicommedia della quotidianità e della cosiddetta “vita reale”, che troppo spesso si abbatte come una “pestilenza” sui suoi attori e spettatori sempre più attoniti e intercambiabili.