Può capitare che una grande epoca avviata verso la fine riesca a riflettere sul proprio tramonto, trasformandolo letterariamente nella cifra più autentica dell’intera condizione umana. L’epoca del tramonto dell’Impero Absburgico e della vecchia Austria, nei primi decenni del Novecento, è stata precisamente una di queste epoche. L’autore che più di ogni altro, anche per qualità di scrittura, ne ha individuato il tratto paradigmatico è stato con ogni evidenza Robert Musil, che è riuscito a fondere nella propria opera i due aspetti di fondo della grande cultura austriaca, l’anima e l’esattezza.
L’“anima”, in Musil, si identifica con lo scavo psicologico e la capacità di servirsi degli strumenti della letteratura (la parola, il segno, la parabola) per scendere in quei fondali melmosi dell’Io che proprio in quel periodo, e nello stesso luogo, venivano scandagliati anche dalla psicanalisi di Freud. L’“esattezza”, invece, è riconducibile all’assoluto nitore del dettato, a una prosa di adamantina purezza anche se talora screziata di ironia, alla precisione matematica con la quale vengono restituiti il tramonto, il declino e il senso della fine.
Nato a Klagenfurt il 6 novembre 1880, morto a Ginevra il 15 aprile 1942, Robert Musil si è confrontato col tramonto della civiltà austriaca a partire dal capolavoro giovanile “I turbamenti del giovane Törless” (ottimamente portato sugli schermi cinematografici da un regista di finissima sensibilità letteraria quale Volker Schlöndorff) e lo ha infine riassunto ne “L’uomo senza qualità”, un’opera monumentale che sarebbe riduttivo definire semplicemente “romanzo”.
“L’uomo senza qualità” -«una gigantesca cordigliera di nebbia e cristallo, un immenso padiglione di specchi rotanti e deformanti», dove si avverte ad ogni pagina «il freddo bisturi di un vivisettore rigorosissimo», secondo la bella definizione del compianto Italo Alighiero Chiusano- è piuttosto un’enciclopedia della modernità che è insieme romanzo e saggio, affresco di un’epoca e riflessione sulle cose ultime. Lo si potrebbe anche definire un infinito catasto del frammentario, che nella sua pretesa di descrivere la totalità, e cioè il senso complessivo dell’esistenza, finisce per sottolinearne la mancanza. Tutte queste caratteristiche ne fanno una delle opere davvero imprescindibili e dirimenti del Novecento letterario.
Lo ha fatto acutamente notare una sua celebre concittadina, Ingeborg Bachmann, osservando che il capolavoro di Musil ha rovesciato in maniera definitiva il rapporto tra l’Io e la Storia: non è più l’Io ad agire nella Storia, come nei grandi romanzi dell’Ottocento, ma è la Storia ad agire nell’Io. In Musil, infatti, al posto dell’Io nel senso tradizionale del termine c’è un’entità non meglio definibile, dissolta in una serie di funzioni autonome (logiche, cognitive, economiche, sociali, istintuali) non riconducibili a un centro ordinatore.
Ma chi è l’uomo senza qualità? E soprattutto: perché è “senza” qualità? Perché le qualità, forse, esistono ancora come parti di un Tutto, ma appunto non c’è più un Io, un Tutto, in grado di riassumerle. Musil aveva già espresso questa consapevolezza nel quarto capitolo della sua tesi di laurea sulle teorie del grande matematico Ernst Mach (il “concetto di funzione” opposto al “concetto di causalità”) e in un celebre passo de “I turbamenti del giovane Törless”, parlando del numero immaginario “i”, corrispondente alla radice quadrata di meno uno, ad indicare non solo un’unità di calcolo, ma anche un segno convenzionale per qualcosa che non esiste (nessun numero elevato al quadrato dà come risultato meno uno). Il fascinoso e sfuggente Ulrich, l’uomo senza qualità, incarna il perfetto tipo psicologico dell’austriaco del tramonto absburgico: possiede molte qualità, ma non riesce a indirizzarle verso uno scopo preciso, perché il cosiddetto “reale” è ormai privo di coordinate e non permette uno sviluppo coerente e lineare della personalità. Ulrich è quindi un individuo di carne e sangue, pensieri e pulsioni, ma è anche irreale come il numero immaginario “i”: un significante senza concetto, una vita priva di Vita.
C’è un preciso momento in cui Ulrich tocca con mano il vuoto e l’assenza. Accade quando viene nominato segretario del comitato che ha il compito di organizzare le celebrazioni per il settantesimo anniversario dell’ascesa al trono di Francesco Giuseppe, nel 1918. I preparativi per la celebrazione, denominata “Azione parallela”, costituiscono l’unico filo conduttore di una narrazione che è volutamente priva di una trama e procede per strappi e accumulazioni, con numerose variazioni e racconti nel racconto: la storia d’amore tra Walther e Clarisse, ad esempio, l’ambiguo legame tra Ulrich e la sorella Agathe, per non dire della lunga e sconvolgente digressione sul maniaco sessuale Moosbrugger, condannato a morte per l’assassinio di una prostituta. Per orientarsi meglio in questa grande enciclopedia del Nulla e del Vuoto è molto utile la lettura de “Il redentore”, la più significativa delle numerose versioni preliminari del romanzo. Databile intorno al 1921/22, è stata pubblicata anche in versione italiana alcuni anni fa.
Nel frattempo, tra una digressione e l’altra, l’Azione parallela non ha più ragione di esistere, perché la vecchia Austria è crollata sotto l’urto degli eventi storici. La trama si sgretola in pezzi sempre più piccoli, che dicono la frammentazione di una realtà impossibile da riprodurre proprio perché potenzialmente riproducibile all’infinito. “L’uomo senza qualità” rimane quindi incompiuto. O meglio, rimane compiuto e definitivo nella sua incompiutezza. Musil cominciò a scriverlo nel 1925, la prima e la seconda parte uscirono rispettivamente nel 1930 e nel 1933, l’ultima parte uscì postuma nel 1943, la prima edizione in un volume unico è del 1952. Ma è proprio questa incompiutezza -che esprime un principio poetologico e insieme ontologico- a renderlo di una verità sempre più vera.
C’è chi si è spinto a paragonare “L’uomo senza qualità” alla “Divina Commedia”, peraltro non senza validi motivi. Ma è opportuno sottolineare una sostanziale differenza: nello sconfinato labirinto di Musil, che è anche il nostro labirinto, c’è solo un purgatorio astratto e senza uscita. E che non lascia intravedere né consolazione, né salvezza.
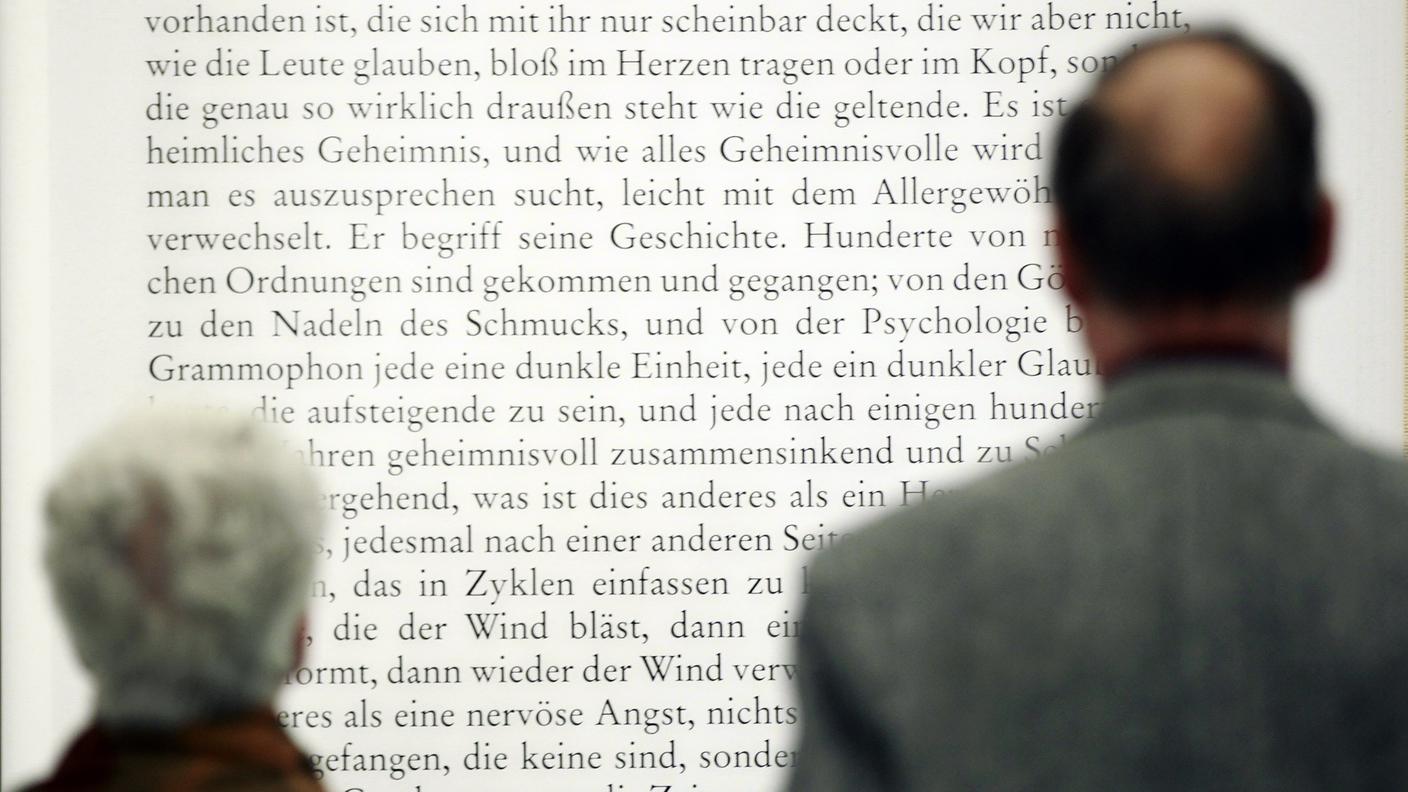
L’Uomo Senza Qualità di Robert Musil
Laser 27.08.2014, 13:45
Contenuto audio



