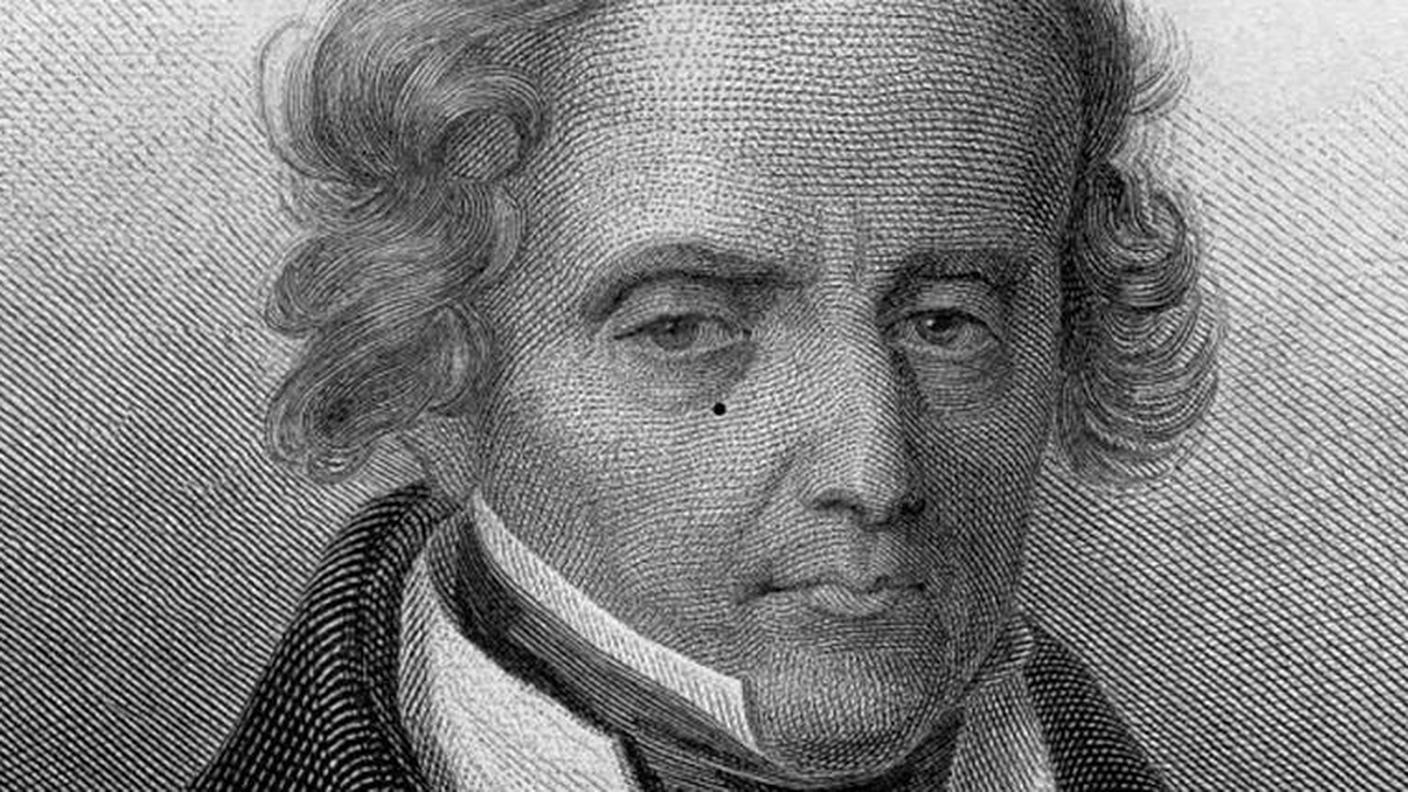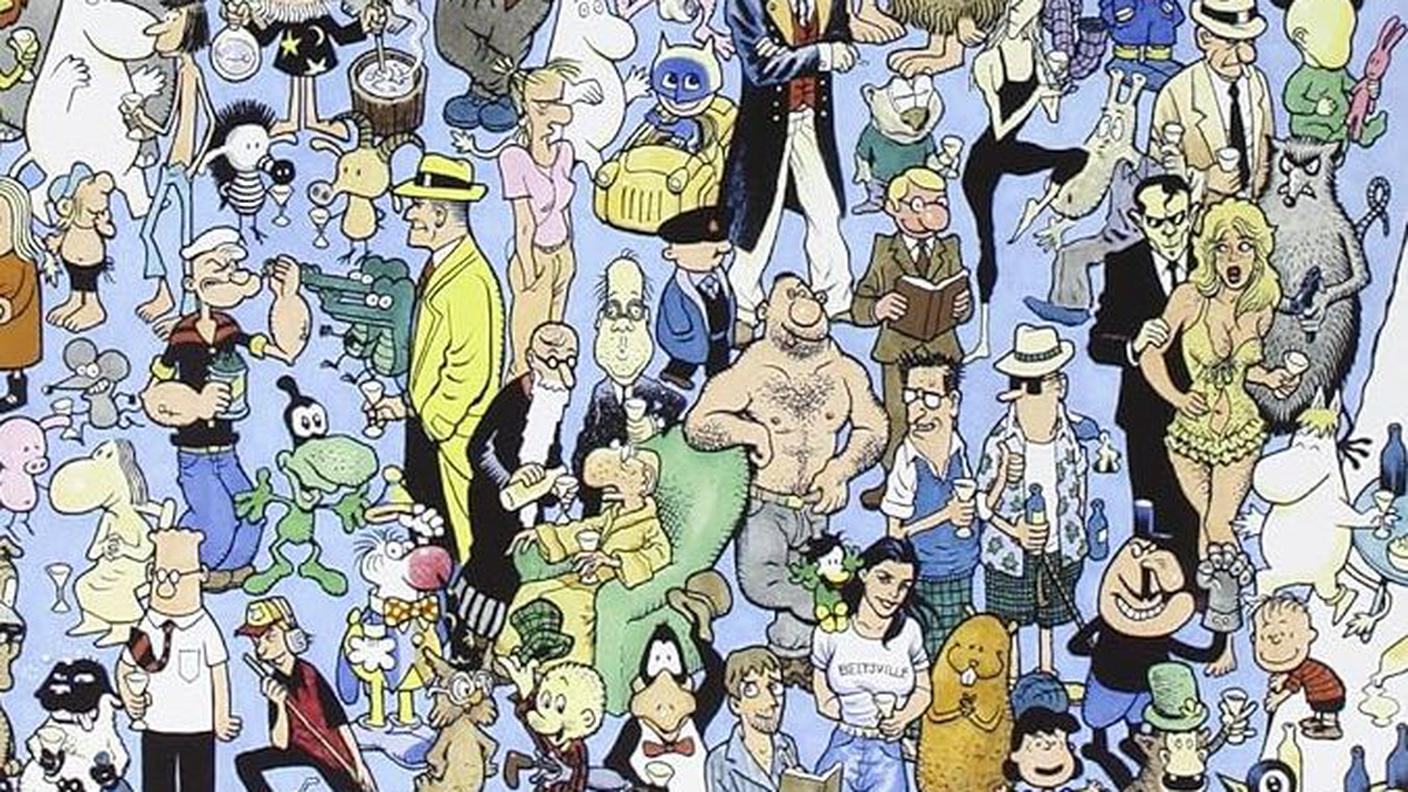Gli dèi abitano là dove sempre hanno abitato. Ma sulla terra si sono perdute certe indicazioni che si possedevano su quei luoghi. O non si sa più ritrovarle in vecchi fogli abbandonati e dispersi.
Roberto Calasso
Noi tutti abbiamo conosciuto Roberto Calasso (30 maggio 1941 - 28 luglio 2021), i suoi numerosi premi, le conferenze internazionali e l’ancor più noto successo di Adelphi, punta di diamante della cultura italina degli ultimi cinquant’anni. Ma ciò che più impressionava era vederlo nel suo ufficio, dietro allo scrittoio, che regge in una mano uno smartphone e nell’altra un’amigdala. Due oggetti, due artefatti separati da un abisso di 2,5 milioni di anni, e nonostante ciò molto simili, tanto che Calasso poteva sentenziare che «sono sostanzialmente la stessa cosa», ossia protesi.
Sono protesi, ma per chi? o per cosa? Per l’Homo. Già, perché al centro dell’attenzione di Calasso c’è sempre stato l’Homo, dal Paleolitico a oggi, nella sua comunanza e vicinanza, da un lato con l’animale e dall’altro con il divino. Queste due presenze, l’animale e il divino, hanno accompagnato da sempre la storia dell’uomo, il quale ha cercato di addomesticarle, senza successo e perdendone in arte la forza primigenia. In particolare per quanto attiene al divino, che sembra eccedere la mente utilitaristica dell’Homo saecularis, incapace di esperire l’ignoto. Come disse Calasso in un’intervista pubblicata da La Repubblica, «Homo saecularis si è sbarazzato delle religioni, ma è tremendamente credulo». Questa incongruenza, fra la perdita del sacro e la credulità quotidiana, è stata al centro di uno degli ultimi lbri di Calasso, L'innominabile attuale, in cui lo scrittore-saggista ha fotografato questo tipo particolare di Homo, che si è liberato del grande peso dell’ignoto, del divino e dell’invisibile, ma senza ottenere felicità, bensì smarrimento.
Quando Calasso osserva l’attuale lo fa confrontandolo con altre epoche umane, in cui si sono praticate altre modalità di esistenza. E lo fo analizzando alcune delle matrici più profonde dell’esistere dell’Homo: dalla caccia al sacrificio, ai miti, all’arte e alla tecnica, alla fede e al pensiero, alla scienza, alla letteratura, alla società, alla metamorfosi e alla morte. Portatore – per dirla con Nietzsche e Calasso stesso – di un pensiero impuro, l’Homo ama miscidare le discipline, senza precludersi alcuna prospettiva. E in questa mescolanza, sempre presente, vi è un’idea di fondo della cultura che, nel nostro tempo, lentamente va obliandosi: quella secondo cui la cultura, quando viene accostata all’utile, muore.
Il mondo letterario che ci ha consegnato di Calasso è un mondo chiaro, iper-letterario. Grazie alla letteratura, alla sua conoscenza libresca, egli ha saputo vivificare e illuminare di nuova luce il raffinato pensiero dei vedānta, così come i miti greci e l’opera del Tiepolo, e di Baudelaire, Kafka, Simone Weil... la lista è lunga, troppo lunga, ma più che i nomi ciò che qui interessa è osservare come Calasso sia sempre andato alla ricerca di quel sapere fondamentale che attraversa artisti, poeti e intellettuali, quel sapere secondo cui il pensiero e la letteratura raggiungono la massima profondità e la massima altezza nel momento in cui la forma diventa l’ultima sostanza.
«Le storie non vivono mai solitarie: sono rami di una famiglia, che occorre risalire all’indietro e in avanti» (Calasso). La cultura di Calasso ha saputo illuminare il mondo passato per raccontare il presente, ma senza cercare di svelarne il mistero, bensì di mostrarlo tra i dedali infiniti di ciò che è Homo. Eppure, negli infiniti suoi scritti, traspare anche una nota nostalgica di quel mondo mitico in cui la poesia era animata da dèi ed eroi, di quel mondo ancestrale e libero in cui l’invisibile era visibile e non vi era null’altro che caccia, eros e sacrificio, o di quelle lettere e di quei libri che ci parlano di là dal tempo pagina dopo pagina. Per questo al centro dell’attenzione di Calasso ci sono stati soprattutto quegli scrittori che hanno parlato del divino, degli dèi e dell’invisibile, e ci sono stati quei testi che come fiumi carsici scorrono nel sottosuolo ma poi riemergono, portatori di un sapere irriducibile; fiumi che, nella loro metamorfosi più avvincente, superano la contingenza e prendono il nome di «letteratura assoluta».