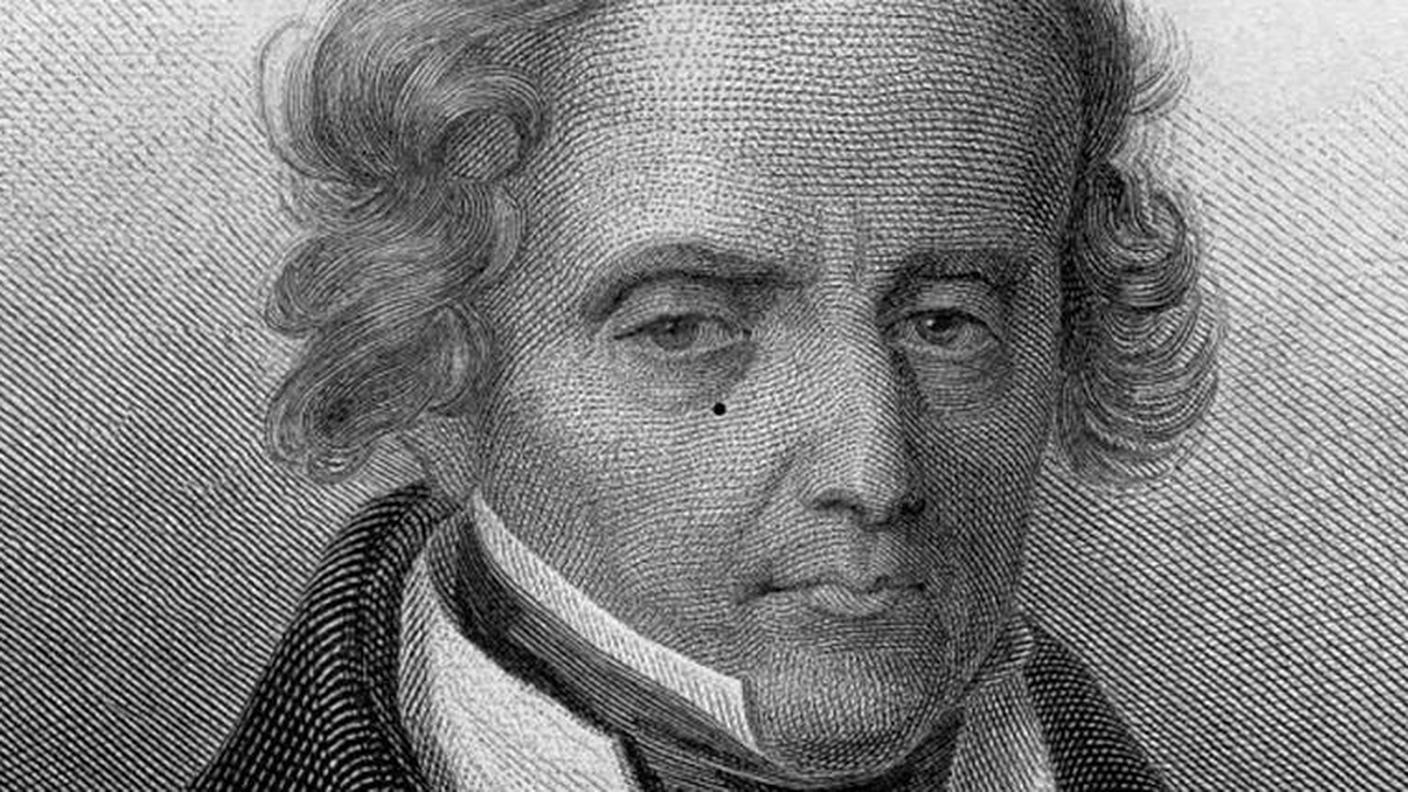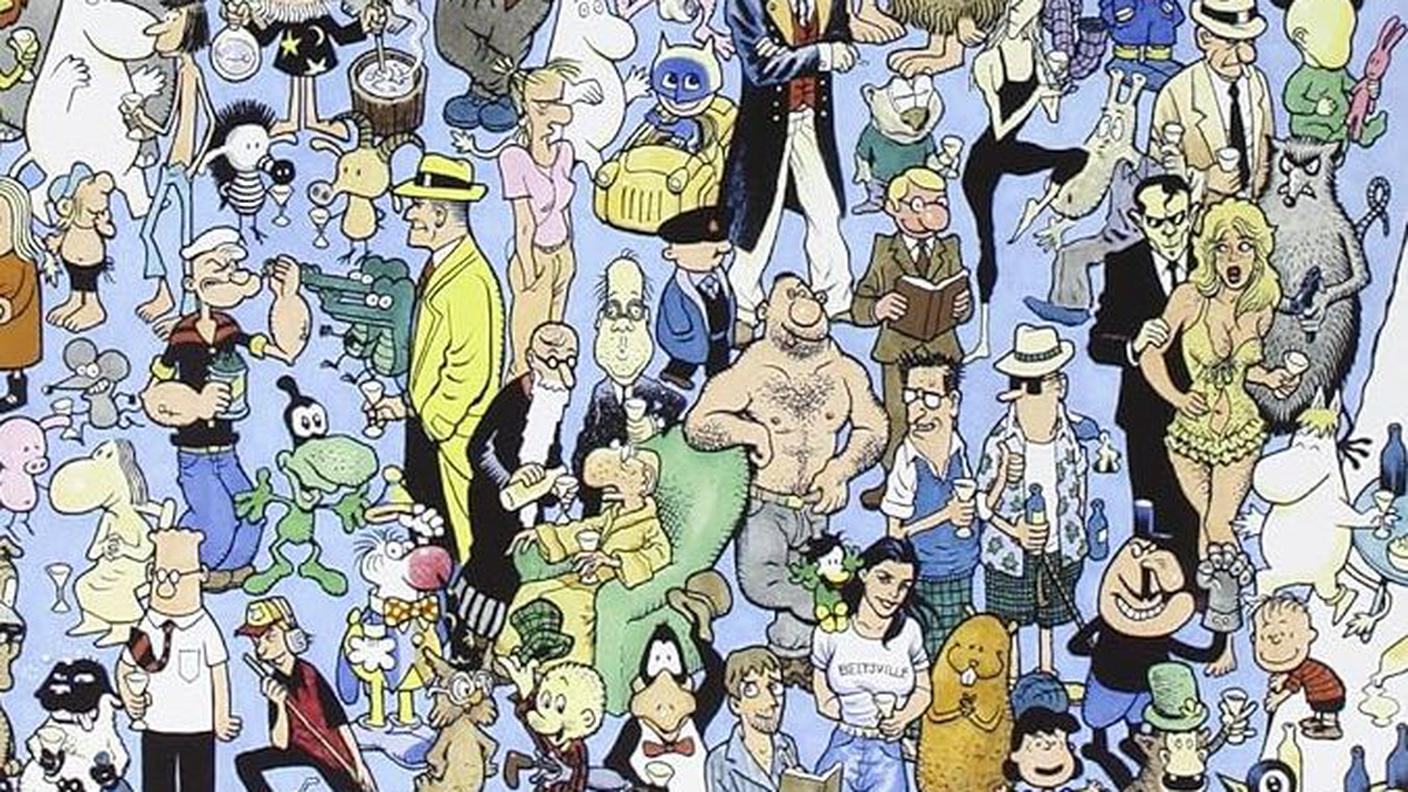I grandi scrittori morti sono una gloria per le nazioni e una moneta facilmente e comodamente spendibile nei discorsi ufficiali, ma spesso sono anche un enorme problema. Lo sa bene proprio la Svizzera, che nel corso del Novecento ha prodotto con Max Frisch e Friedrich Dürrenmatt due narratori e drammaturghi di livello mondiale ma anche due coscienze critiche e due personaggi estremamente scomodi. Il tempo è passato, ricorrono gli anniversari della nascita e della morte, ma il ricordo è sempre vivo e in certi ambienti si preferirebbe dimenticare.
Più a nord c’è un’altra nazione, la Svezia liberale e progressista del “Folkhemmet”, modello di welfare e garanzie sociali, che negli scorsi anni, in occasione del centenario della morte, ha avuto sostanzialmente gli stessi problemi con la massima gloria letteraria, August Strindberg: uno scrittore eccelso, certo, un drammaturgo che ha spostato i confini dell’espressione scenica e ha contribuito a ridisegnare la percezione che l’uomo ha di se stesso, ma anche un inguaribile misogino “à la Lombroso”, che considerava la donna alla stregua di un essere inferiore. Questo, almeno, è quanto dice la vulgata, che ancora oggi è molto diffusa e contribuisce a tener viva la leggenda nera di uno Strindberg nemico giurato del femminismo, una sorta di Barbablù in sedicesimo che per le donne nutriva un odio che sconfinava nel vero e proprio disprezzo. Non è vero praticamente nulla, o quasi.
Beninteso, se la lettura si limita al ciclo narrativo “Sposarsi”, apparso nel 1884-85 in risposta a “Casa di bambola” dell’amico-nemico e quasi conterraneo Ibsen, oppure al sulfureo “Autodifesa di un folle”, scritto in francese nel 1887-88 e poi apparso nel 1893, geniale quanto sgradevole racconto della crisi e della fine del suo primo matrimonio, è facile convincersi che Strindberg nutrisse una profonda avversione nei confronti delle donne. E’ nota, in particolare, la delirante tirata contenuta nell’ultima pagina di “Autodifesa di un folle”, dove il genere femminile viene descritto (si fa per dire) in questo modo: «Mezze scimmie, esseri inferiori, bambine malate, malate e pazze tredici volte all’anno nel periodo delle mestruazioni, autentiche dementi nel corso della gravidanza, irresponsabili il resto della vita, disgraziate, incoscienti, criminali per istinto, bestie che fanno il male senza saperlo». Parole inequivocabili, almeno all’apparenza, se non fosse che lo stesso Strindberg, parlando in particolare dell’opera narrativa, abbia più volte premesso un’avvertenza colpevolmente trascurata e perfino ignorata: «E’ tutto vero. O quasi…».
“O quasi…”, appunto. Perché le grandi opere letterarie, anche quelle che si presentano più o meno scopertamente coi tratti dell’autobiografia o della “tranche de vie”, non vanno mai lette come un semplice resoconto dei fatti oppure come un’esposizione oggettiva e naturalistica di una presunta “verità”. Strindberg, nello specifico, reinventa la realtà del suo primo matrimonio e presenta una verità che è l’autodifesa di un folle, come dice chiaramente il titolo, non un protocollo legale. E’ il “folle”, insomma, che giudica le donne creature inferiori e abiette, non la persona August Strindberg. E men che meno il drammaturgo, che senza dubbio ha creato dei mostri come Laura, la moglie del capitano ne “Il padre”, oppure dei mezzi mostri come la bipolare e fin troppo volubile signorina Giulia, o ancora la climaterica e acidula Alice in “Danza di morte”, ma anche figure angelicate come la giovane Eleonora in “Pasqua”, che si fa carico delle colpe altrui, l’elusiva e fascinosa Signora in “Verso Damasco”, la meravigliosa Agnes ne “Il sogno” e Svanevit nell’omonimo dramma.
Ci sarebbe inoltre da aggiungere che la sua prima moglie, Siri von Essen, nobile finlandese con pretese da attrice e inclinazioni sessuali piuttosto disinvolte, non era propriamente una santa e aveva sposato il giovane e ingenuo Strindberg -uomo di repentini entusiasmi e altrettanto repentini disincanti, dal carattere oggettivamente difficile- al fine di garantirsi una prospera carriera teatrale, pur nella consapevolezza di possedere attitudini alquanto limitate. Ma questo, va da sé, è tutto un altro discorso.
Si è detto spesso, non senza validi motivi, che il fumantino e umorale Strindberg non ha quasi mai ragione, ma è sempre interessante. Nel caso del femminismo, oltre che interessante, ha anche parecchie ragioni da vendere. Per capire il suo atteggiamento nei confronti della donna è tuttavia necessario inquadrare storicamente il femminismo in Svezia negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo, perché era un femminismo molto differente da quello (vero o presunto, tra l’altro) stilizzato in “Casa di bambola” di Ibsen. Il femminismo nella sua accezione più recente possiede una connotazione molto marcata, progressista e di sinistra, ed è considerato lo strumento ideologico di emancipazione della donna. Ai tempi di Strindberg, invece, il femminismo aveva caratteri del tutto differenti: in piccola parte era legato ai movimenti socialisti, mentre in maniera preponderante era legato ai movimenti religiosi ed era un genere di femminismo conservatore e molto potente sul piano del controllo sociale, perché affondava le proprie radici perfino nei vertici della monarchia svedese. Era un femminismo, per così dire, piuttosto tendente all’igiene, senza alcuna traccia di reale e concreta emancipazione.
La posizione “outrée” di Strindberg, del tutto autonoma e in piena contrapposizione rispetto a questo femminismo borghese di impronta religiosa e conservatrice, si apre invece verso una dimensione di natura che comprende anche la libertà sessuale: un vero e proprio tabù, per l’epoca, in Svezia e non solo. Strindberg venne considerato scandaloso e immorale (subì addirittura un processo per blasfemia a causa di un racconto contenuto in ”Sposarsi”) proprio perché voleva concedere libertà sessuale anche alla donna, e quindi andava a toccare un punto nevralgico della morale del tempo, sottolineando un aspetto che naturalmente non poteva piacere al femminismo di impronta religiosa. E che invece è molto vicino proprio al femminismo della seconda metà del Novecento.
«Anche il progresso, diventato vecchio e saggio, votò contro», recita un simpatico e puntuto aforisma di Ennio Flaiano. Il vero progresso, per lo scettico Strindberg, era costituito dalla negazione delle menzogne sociali e dal ritorno alle condizioni di natura, dove a suo parere c’era una sostanziale parità tra uomo e donna anche sul piano dei mezzi di sussistenza. Un’utopia piuttosto ingenua, si potrebbe dire, soprattutto in considerazione del fatto che la tendenza del tempo andava verso l’industrializzazione e strutture sociali sempre più complesse. La posizione di Strindberg può quindi essere valutata come anacronistica e perfino inattuale, ma è una posizione precisa e consapevole, che individua e colpisce un nervo scoperto nella misura in cui fa capire che il cosiddetto “progresso” non è sempre una garanzia di diritti e eguali opportunità, e può anche “votare contro”. Questo Strindberg è attualissimo non solo nel suo “grande disprezzo” di derivazione nietzscheana, ma anche -e soprattutto- nella sua non meno nietzscheana “inattualità” e nelle sue contraddizioni: misogino, forse, ma sicuramente, seppur a suo modo, femminista ante-litteram. Chiarire un simile equivoco significa riconsiderare tutta la sua opera all’interno di una nuova, sorprendente e in definitiva attualissima prospettiva.