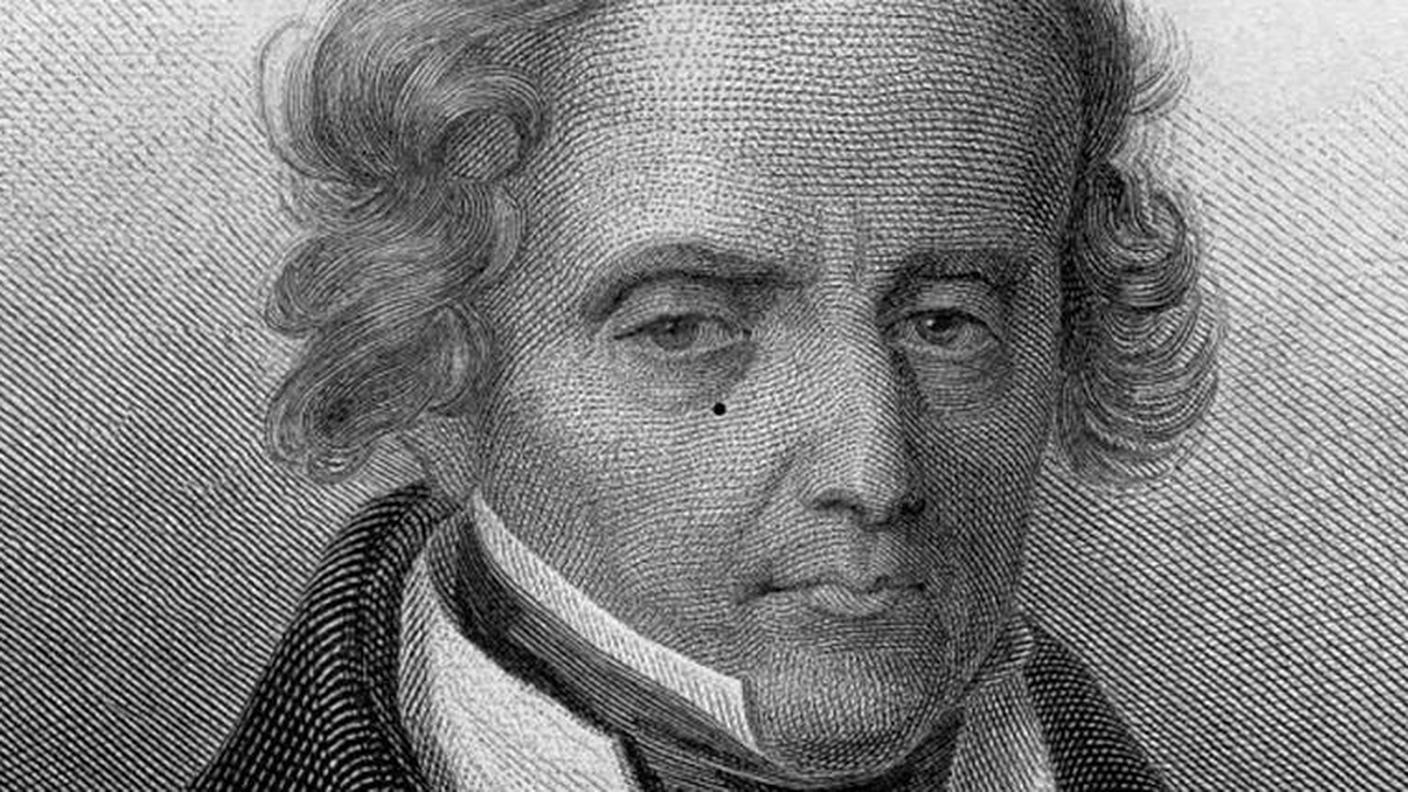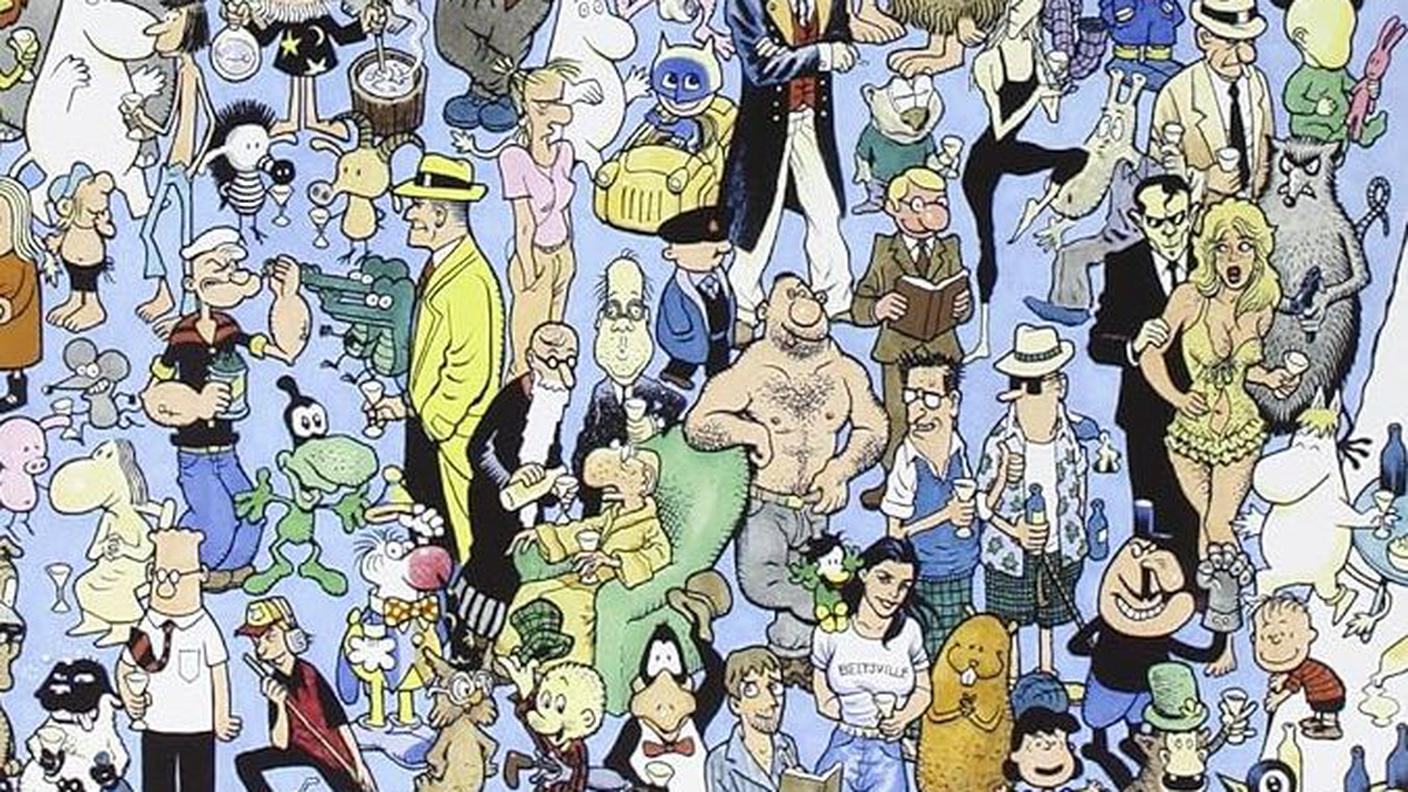Sono molto i romanzi che analizzano la figura di un unico personaggio, sia esso una donna o un uomo, sia esso accompagnato o meno da deuteragonisti. E in una percentuale significativa tali personaggi sono già richiamati nel titolo dell’opera: Siddharta, I dolori del giovane Werther, Storia di Tönle, Il ritratto di Dorian Gray, Anna Karenina, Una giornata di Ivan Denisovic e via elencando.
Peculiarità di tali romanzi è portare alle estreme conseguenze quello a cui segretamente aspira ogni narratore: disegnare un essere umano – almeno uno– come se fosse realmente esistito. E se il miracolo riesce, renderlo a tal punto vivo da farne una figura paradigmatica.
Pensiamo a Don Chisciotte, da cui procede l’aggettivo «donchisciottesco». Pensiamo al Pereira di Tabucchi, emblema della resistenza codarda al potere. Pensiamo a classici come Otello o Amleto, a figure come Arlecchino o Pulcinella, a eroi come Ulisse o a eroi mancati come il Gregor Samsa di Kafka. Ciascuno di questi personaggi ci offre l’impressione – antico o contemporaneo che sia – di essere davvero esistito. E soprattutto di aver svelato di sé elementi senza i quali non saremmo in grado di riconoscere fino in fondo noi stessi.
Un miracolo che colloca la letteratura – soprattutto la narrativa – in quegli spazi innominabili della realtà in cui la finzione si presta a fare da guida alla vita superandola in realismo e surclassandola in profondità di coscienza e verità.
Uno di questi fenomeni si incontra leggendo Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Si tratta in effetti di uno dei romanzi che – prestati al cinema o meno che sia – ha il potere quasi ipnotico di consegnarci l’immagine di un uomo addirittura più reale del suo autore. E soprattutto di mostrarci, attraverso la sua personalità, un intero mondo e un’intera epoca. Chi è infatti Jay Gatsby, il miliardario del cui fascino l’io narrante ripercorre la misteriosa e intrigante vicenda? A un primo sguardo sembrerebbe un ostinato edonista a cui le maschere della vita mondana consentono di nascondere le ombre più oscure del suo passato, dei suoi sentimenti. Poi ci si accorge che è l’emblema di ciò che tutti noi siamo al cospetto della vita nella sua essenzialità: un uomo la cui solitudine non può essere affrontata se non radicalmente.
Siamo negli anni ruggenti del primo ventennio americano, quando tutto sembra vivere, al termine della Grande Guerra, nell’esaltazione di un presente sconfinato e senza insidie. La villa di Gatsby è ricettacolo di feste e intrattenimenti a cui partecipa la crème della società newyorchese. E unico dato che connota la realtà di quei raduni pare essere lo svago, il divertimento e l’ostentazione della propria spensieratezza e classe sociale.
Ma proprio in questo quadro – senza voler nulla anticipare a chi non conosce la trama del libro – si gioca il destino di quello che vorremmo chiamare l’uomo solo Gatsby, a cui nessuna sovrastruttura di agio o prestigio può levare l’ossessione per l’amatissima Daisy, alla quale ha consacrato tutti i sacrifici che l’hanno condotto da una condizione di estrema povertà all’agio della sua vita adulta.
Proprio su questo crinale si giocano i pregi di questo romanzo, che nel tratteggiare il Sogno Americano ante-litteram, la possibilità miracolosa di conquistare le vette della società in forza della sola abilità, spregiudicatezza e intelligenza, ricorda come questo Sogno sia in realtà uno specchietto per le allodole: annidandosi la verità di un individuo – soprattutto di un individuo come Gatsby – negli antri più reconditi della passione e della debolezza.
Siamo così alla contraddizione radicale tra ciò che il mondo mostra di sé e quanto il mondo occulta nelle proprie parvenze. Un contrasto che finisce per delineare – oltre alle minacce che sottendono un’epoca fondata sulle apparenze e sull’effimero – il dissidio profondo che anima un essere umano: quello tra la sua immagine e la sua anima, tra la sua reputazione e i gorghi segreti del suo cuore.
Per questo Il grande Gatsby, uno dei più riusciti romanzi a un solo personaggio, ci attrae indissolubilmente a sé. Perché in Gatsby riconosciamo tutto ciò che il demone recondito della solitudine porta con sé: essere destinato alla sconfitta più bruciante quanto più esposto alla pretesa di poter trionfare tramite mezzucci quali il potere, la gloria, la ricchezza, la mera grandezza sociale.