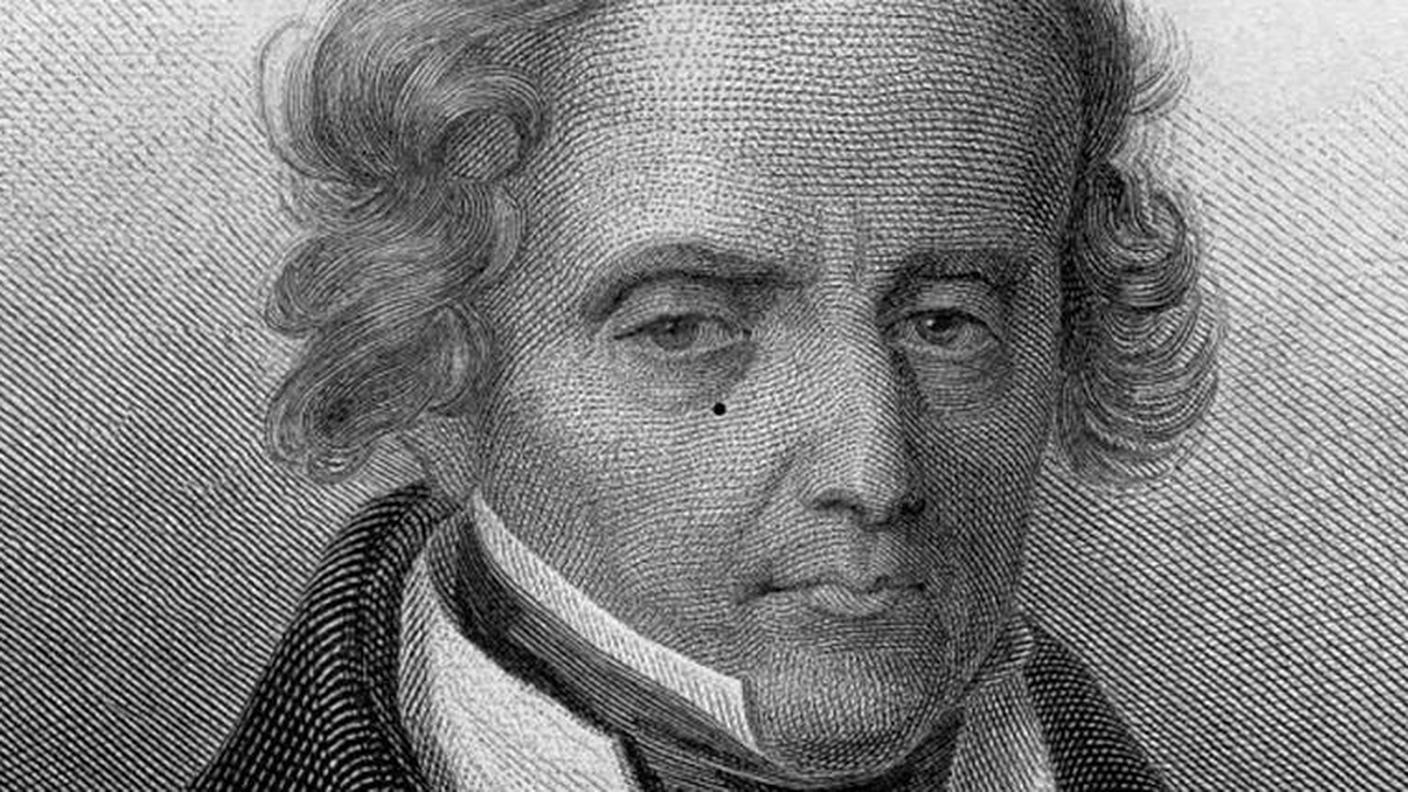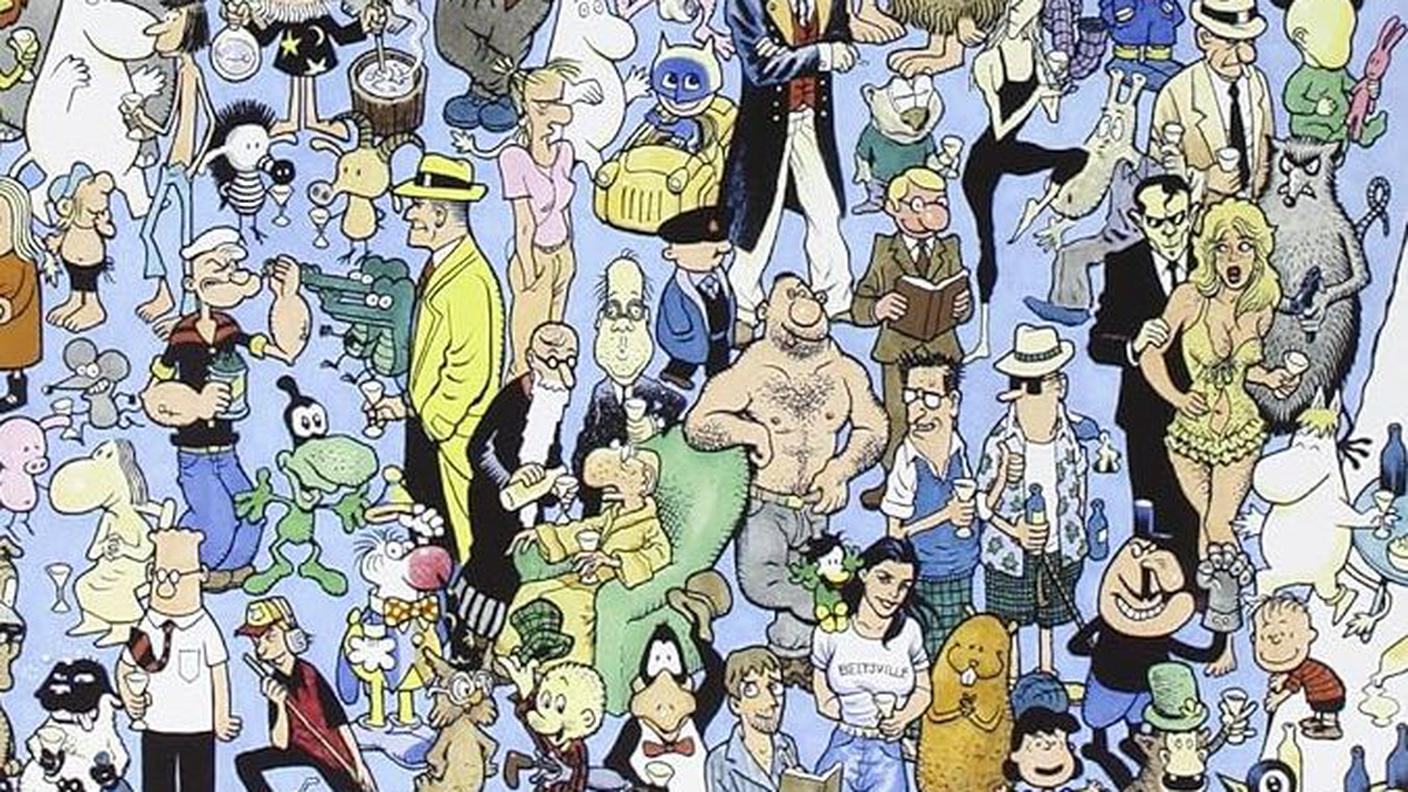Nel giorno della nascita della Szymborska, a Bnin, cent’anni fa, la prima cosa che mi torna in mente è la sua morte, avvenuta il primo febbraio 2012: un ricordo d’alba e d’ombra il giorno dopo, quando ho ricevuto l’e-mail di un’amica scrittrice.
“Our shadow comrade is gone” il titolo, traducibile come “La nostra compagna d’ombra se n’è andata”, ma anche “La nostra compagna-ombra se ne è andata” nel senso di ministro-ombra, governo-ombra formato dai capi dell’opposizione.
E se Szymborska era all’opposizione tout-court, come tutta la buona poesia, lei lo era anche rispetto alla poesia, per la sua impossibile leggerezza e la possibilità della gioia, e in questo senso direi che era all’opposizione proprio dell’ombra. Ma come lo è la luce di una candela, che a sua volta genera ombre, però vivaci, ballerine.
Il messaggio dell’amica scrittrice poi era breve ma ancora più polisemico, “and no more proper nail polished poetry”. Dagli albori interstiziali ricavo due versioni nette: “e niente più vera poesia unghia-laccata”, “e niente più vera poesia polaccamente incisiva”.
Mi soffermo su queste due righe per la loro mimesi szymborskiana (che è un modo degli scrittori per salutare chi lasciandoci ci lascia la sua poesia, “Earth, receive an honoured guest”), a livello di forma e di contenuto: giocose nella gravità e precise nella molteplicità, toccano elementi chiave nel modo più conciso possibile. Oltre a un’intimità e all’opposizione, l’elemento femminile, quasi coquette, quanto graffiante, ma con stile, dell’unghia laccata. L’incisività, lucida, luminosa, della poesia polacca. E il “niente più”: la fine, con la morte di Wisława Szymborska, di tutto questo. [Di tutto questo, in questi termini. In Polonia si continua a scrivere poesia, ma è un’altra cosa, e semplicemente hanno unghie diverse le altre scrittrici incisive: per attenerci ai Nobel polacchi, Olga Tokarczuk; o, per attenerci a questo testo, Adania Shibli].
Ricominciamo dalla fine, con Szymborska, del mistero della poesia polacca.
Nel 2012 c’erano ancora Julia Hartwig e Różewicz, a dire il vero, ma lui aveva preso un’altra strada, e c’era Adam Zagajewski, che invece ha percorso la strada maestra, magistralmente, ma seguendo chi l’ha battuta. [Anche Adam sapeva una o due cose sulla luce e sull’ombra, della sua Fiamma si parla pure al TG – mentre la sua poesia Tenta di lodare il mondo mutilato è stata la quarta di copertina della prima edizione del “New Yorker” dopo l’11 settembre].
Quella strada maestra è uno dei misteri sincronici della letteratura, come Shakespeare e Cervantes che muoiono lo stesso anno, forse lo stesso giorno, il 23 aprile 1616, o i titoli del 1922 (escono l’Ulisse di Joyce, La terra desolata di Eliot e Jacob’s Room di Woolf, Kafka comincia Il castello, Rilke scrive le Elegie duinesi e Proust termina la Recherche) o i poeti russi della prima metà del Novecento. Per il mistero polacco bastano tre nomi, Szymborska, Miłosz e Herbert, tre poeti incommensurabili, estremamente diversi, quasi a coprire le terre emerse della poesia, eppure toccati dalla stessa acqua, luminosa, lucida.
I primi due hanno vinto il premio Nobel a relativamente pochi anni di distanza, mentre l’altro, quello dimenticato, per me era il più straordinario dei tre. Zbigniew Herbert. Dimenticato al punto che di una poesia di quelle che cambia e salva la vita, Il messaggio del Signor Cogito, in italiano sul web non si trova una lettura decente, e a malapena il testo (nella traduzione di Marchesani, il grandissimo che ha tradotto in italiano il mistero polacco).
Partito dalla fine, mi trovo a metà del testo.
È un buon momento per il Tutto
Tutto – / una parola sfrontata e gonfia di boria. / Andrebbe scritta fra virgolette. / Finge di non tralasciare nulla, / di concentrare, includere, contenere e avere. / E invece è soltanto / un brandello di bufera.
Dopo aver detto tutto, Qualche parola sull’anima.
Poesia che comincia con una sorpresa: “L’anima la si ha ogni tanto. / Nessuno la ha di continuo / e per sempre”.
E con una sorpresa termina: “Si direbbe che / così come lei a noi, / anche noi / siamo necessari a lei per qualcosa”.
In un’equazione, la poesia di Szymborska sta all’essere umano come l’anima sta a Szymborska.
Così la sua poesia è necessaria a Roberto Saviano, quando è sull’orlo del baratro, e Saviano è stato necessario alla sua poesia, qualora avesse voluto essere più letta in Italia. [Come, qualora la letteratura polacca volesse essere più letta in Italia, le è necessario Francesco Cataluccio].
Ma quando per un documentario la regista Katarzyna Kolenda-Zaleska, come un genio della lampada (della candela), ha chiesto a Szymborska quali desideri voleva che venissero esauditi (“Ti piace viaggiare?” “No. A me piace tornare”), Wisława ha parlato sì di Italia, ma le sue necessità erano più nell’ordine del comico. Ha chiesto di conversare con Woody Allen che, come Saviano, come l’essere umano, ha commentato: “Sapete che sono un ipocondriaco, quindi la sua poesia Vestiario è sempre accanto al mio letto: solo così riesco a superare la notte”. E di visitare il paesino irlandese di Limerick, che ha dato il nome a una delle forme umoristiche della poesia più popolari ed efficaci, il limerick appunto. Perché le piaceva farsi fotografare sotto i cartelli di paesi dai nomi buffi o simbolici, Neanderthal, Sodoma; a Corleone ha scritto un limerick su Corleone.
Un’altra sua necessità, che ricorre spesso quanto quella di umorismo – e di curiosità, stupore, precisione – è quella del dubbio. Il non-sense dei limerick, e il non-so dell’ispirazione. Cito dalla sua Nobel Lecture, un passo che intreccia i nostri fili con il suo tocco incisivo, laccato: “L’ispirazione non è un privilegio esclusivo dei poeti o degli artisti in genere. C’è, c’è stato e sempre ci sarà un gruppo di individui visitati dall’ispirazione. Sono tutti quelli che coscientemente si scelgono un lavoro e lo svolgono con passione e fantasia. Ci sono medici siffatti, ci sono pedagoghi siffatti, ci sono giardinieri siffatti e ancora un centinaio di altre professioni. Il loro lavoro può costituire un’incessante avventura, se solo sanno scorgere in esso sfide sempre nuove. Malgrado le difficoltà e le sconfitte, la loro curiosità non viene meno. Da ogni nuovo problema risolto scaturisce per loro un profluvio di nuovi interrogativi. L’ispirazione, qualunque cosa sia, nasce da un incessante ‘non so’. […] Per questo apprezzo tanto due piccole paroline: ‘non so’. Piccole, ma alate. Parole che estendono la nostra vita in territori che si trovano in noi stessi e in territori in cui è sospesa la nostra minuta terra”.
Così, con un battito di piccole ali, arriviamo alla fine di questo minimo percorso (“ogni imperfezione è più facile da sopportare se la si serve a piccole dosi”) nei pressi della gioia di scrivere di Wisława Szymborska, gioia che è “il potere di perpetuare”. È “la vendetta di una mano mortale”. Perché “non c’è vita / che almeno per un attimo / non sia immortale”. E allora finiamo qui, Sulla morte – ma, chiaramente – senza esagerare.