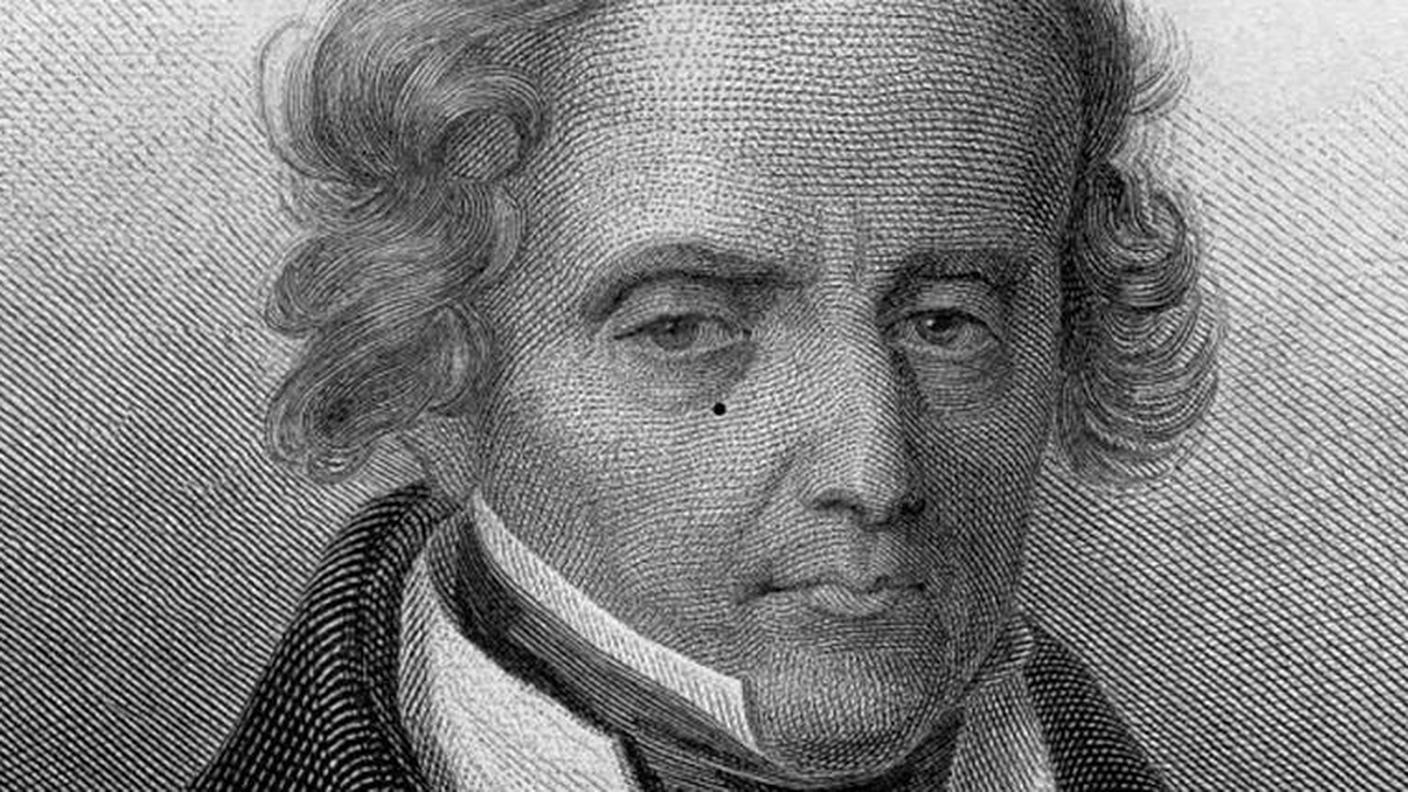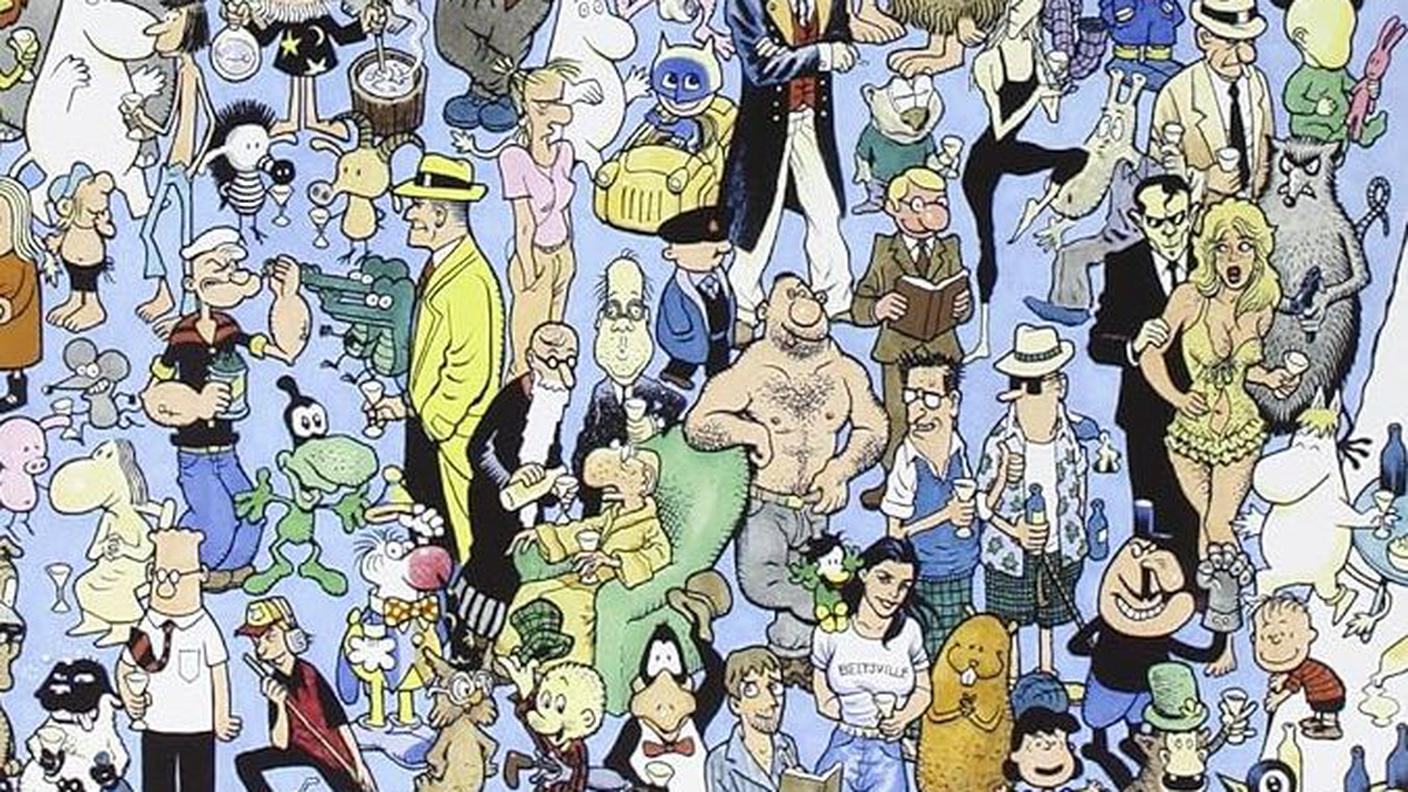Per capire un libro come “Le serate di Médan” -che è non soltanto un libro, ma il manifesto di una scuola letteraria e un eccezionale esempio di reinvenzione letteraria della realtà e del materiale storico- è necessario tenere presente che i cosiddetti “luoghi della letteratura” costituiscono ovviamente lo sfondo più o meno immaginario e reinventato delle vicende narrate (la Londra di Dickens, la Praga di Kafka, la Dublino di Joyce, solo per citare alcuni esempi), ma sono anche il concreto orizzonte che circoscrive e rende possibile l’opera di reinvenzione.
Médan, nello specifico, che è una cittadina nella regione dell'Île-de-France, a circa cinquanta chilometri da Parigi, è entrata a far parte dei grandi “luoghi letterari” grazie al capostipite del naturalismo, Émile Zola, che nel 1878 investì buona parte dei cospicui proventi dovuti al “succès de scandale” del romanzo “L’Assommoir” (“Lo scannatoio”), uscito l’anno prima, nell’acquisto di un’abitazione situata nella zona di campagna che ancora oggi circonda la cittadina.
Nell’abitazione, che lo stesso Zola aveva scherzosamente definito una “cabane à lapins” e oggi ospita il “Musée Dreyfus”, si formò immediatamente un cenacolo letterario formato da giovani amici e ammiratori, tutti ammaliati dal nuovo verbo del naturalismo e convinti della necessità di restituire i fenomeni della vita nella loro immediatezza, senza gli orpelli romantici, in nome di una totale adesione alla realtà anche nei suoi aspetti più crudi e scabrosi. Si tratta del principio poetico che Zola aveva svolto per la prima volta nel 1867 in “Thérèse Racquin” e che tornerà, variamente declinato, in tutto il ciclo narrativo dei “Rougon-Macquart”, soprattutto ne “L’Assommoir” e in “Nana”, che all’epoca suscitarono parecchio scalpore per gli argomenti affrontati e le situazioni descritte. Il tema della vita e del presunto consorzio civile come “lotta di cervelli” e “scannatoio” verrà poi ripreso da August Strindberg, il cui teatro naturalistico, in particolare “Signorina Giulia”, è una dichiarata trasposizione in senso drammaturgico delle idee di Zola, con l’unica ma sostanziale differenza che per Strindberg, nella “lotta dei cervelli”, escono tutti sconfitti, perché lo “scannatoio” non risparmia nessuno.
Tra i molti frequentatori di Médan, furono soprattutto cinque giovani scrittori a recepire la lezione di Zola: Guy de Maupassant, Joris-Karl Huysmans, Henry Céard, Léon Hennique e Paul Alexis, che nel corso delle riunioni serali del giovedì cominciarono a ragionare insieme al “cher maître” su un progetto molto ambizioso.
"I Rougon Macquart" di Émile Zola
Il conflitto con la Prussia, che si era concluso alcuni anni prima con una gravissima sconfitta della Francia e la fine del Secondo Impero, aveva infatti prodotto un’ondata di revanscismo che si era concretizzata in una letteratura di infimo livello, intrisa di retorica patriottarda e volutamente incapace di raccontare quanto era realmente successo. Perché, invece, non scriverne in nome di una totale adesione alla realtà dei fatti, con lucidità ma anche con ironia, fornendo una lettura naturalistica della guerra in tutto il suo orrore e la sua miseria, non solo da parte prussiana ma anche da parte francese? Perché non riunire in un volume sei racconti che, in nome della “cultura del vero”, avrebbero mostrato le finzioni di quello che Zola definì per l’occasione «un patriottismo da parata che si nutre di bandiere, odi e canzonette»? I sei racconti, in parte già scritti e parzialmente rivisti per conferire al volume una maggiore unità tematica, uscirono nel 1880 in un libro che si intitola appunto “Le serate di Médan” e si apre con una dichiarazione d’intenti che è anche un atto d’accusa: «Le seguenti novelle sono state già pubblicate, in parte in Francia, in parte all’estero. Le abbiamo riunite perché ci sembra che procedano da un’unica idea, che abbiano una medesima filosofia. Siamo pronti a tutti gli attacchi, alla malafede e all’ignoranza di cui la critica corrente ci ha dato già tante prove. Ci siamo curati soltanto di affermare pubblicamente la nostra autentica amicizia e, al tempo stesso, le nostre tendenze letterarie».
Tra i sei racconti, oggettivamente diseguali ma tutti di straordinario impatto, ci sono due capolavori universalmente riconosciuti, “Palla di sego” di Maupassant e “Zaino in spalla” di Huysmans, i due “discepoli” più dotati, che non a caso presero in seguito strade piuttosto lontane da quelle tracciate dal “maestro”. “L’attacco al mulino” di Zola (il proprietario di un mulino e il fidanzato di sua figlia Françoise vengono trucidati senza alcuna ragione dai prussiani, per mera crudeltà, mentre l’ufficiale francese, dopo la riconquista del mulino, grida “Vittoria! Vittoria!” all’indirizzo della povera Françoise) è costruito con notevole ingegno narrativo ma non è paragonabile alle opere maggiori dello stesso Zola, mentre meriterebbero una rivalutazione e un riposizionamento i racconti dei tre scrittori già all’epoca meno famosi e oggi pressoché dimenticati.
“Il salasso” di Henry Céard, ambientato nel lungo inverno dell’assedio di Parigi, è una discesa negli inferi dell’animo umano, con l’indimenticabile figura di una vecchia cortigiana, la signora di Pahauën, che determina il corso degli eventi e provoca morte e distruzione, facendo semplicemente leva sulla propria (peraltro appassita e miseranda) venustà. “L’episodio del n. 7” di Léon Hennique, storia di un eccidio consumato per vendetta in una casa di tolleranza («meschine stanze dove vari reggimenti avevano riversato il soverchio delle loro voluttà e delle loro sbornie»), contiene alcune pagine di spaventoso impatto visivo e perfino olfattivo, perché si ha davvero la sensazione di percepire la graveolente animalità della vita e della morte. “Dopo la battaglia” di Paul Alexis è infine il resoconto di una di quelle mostruosità che soltanto la guerra può produrre, col rapporto tra un giovane abate, che si è salvato nascondendosi dietro il corpo esanime di un compagno di battaglia, e una giovane vedova che sta trasportando su un carretto, in un cupo scenario invernale, la bara col cadavere del marito.
Ma i due racconti più celebri e giustamente celebrati, che spiccano di gran lunga su tutto il resto, sono “Palla di sego” di Maupassant e “Zaino in spalla” di Huysmans. Non solo per il valore artistico, ma anche perché colgono il male assoluto della guerra in due vicende che dicono tutta la tragicommedia umana: nel caso di Maupassant, una povera e dignitosissima prostituta costretta da un gruppo di indegni bottegai e vili nobilucci francesi a concedersi a un ufficiale prussiano; nel caso di Huysmans, le avventure tutt’altro che picaresche (e molto autobiografiche) di un povero soldato che passa di ospedale in ospedale, nella vana speranza che qualcuno riesca a curargli una fastidiosissima dissenteria. Il malessere, per un grottesco paradosso, si risolverà soltanto dopo la sconfitta, il congedo e il ritorno a casa: «Mi strofino dolcemente il ventre, pensando che infine non c’è più tutto l’orrore della dissenteria trascinata nei luoghi dove la gente fa i propri bisogni in comune, senza pudore. E mi dico che bisogna aver vissuto nella promiscuità degli ospedali e degli accampamenti per apprezzare il valore di un catino d’acqua, per assaporare la solitudine di quei posti in cui ci si cala i pantaloni con comodo». E’ il racconto più bello, anche perché tutto orchestrato su un registro di sorvegliatissima ma urticante ironia. Un racconto che tra l’altro, nelle righe iniziali, prima dell’odissea scatologica, contiene alcune delle parole più penetranti -perché più semplici- mai scritte contro la guerra. Contro ogni guerra e “scannatoio”: «Era scoppiato il conflitto con la Prussia, ma io non comprendevo i motivi che rendono necessarie le carneficine tra eserciti contrapposti. E non sentivo la necessità né di uccidere gli altri, né di farmi uccidere da loro».