Sarà pure banale, ma paragonarsi ai geni è inevitabile, e inevitabilmente doloroso. Altrimenti detto: cosa facevamo noialtri, a vent’anni?
Nel 1970, Stevland Hardaway Judkins – nato in una piccola città del Michigan nel 1950 – aveva pubblicato dodici album con la Motown, e stava preparando il tredicesimo. Era sotto contratto dall’età di undici anni con una casa discografica leggendaria, la più grande fabbrica di hit dell’america dei Sessanta, e aveva scritto successi enormi per sé e per altre star dell’epoca, a partire da Smokey Robinson (Tears Of A Clown). Inutile rimuginare: anche se su quel libretto universitario i voti fossero stati tutti dieci, difficilmente avremmo potuto competere con una qualsiasi Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours). Meglio tornare a Stevie Wonder, e non pensare a noi mortali.
Nella sua vita già eccezionale, Stevie Wonder a vent’anni era – strano a dirsi – insoddisfatto. L’abbraccio dell’etichetta cominciava a sembragli soffocante: voleva avere maggiore libertà creativa, offrire nelle sue canzoni anche un commento ai cambiamenti sociali e politici che l’America stava attraversando. Fare, insomma, come Marvin Gaye, che stava registrando in quei mesi un disco che parlava della povertà, della tossicodipendenza, della guerra (ovviamente, What’s Goin’ On). Berry Gordy, fondatore e boss incontrastato della Motown, aveva già litigato con Gaye perché non voleva rischiare inserendo nei suoi dischi argomenti controversi. Ora, ci si metteva pure quel ragazzino. Gordy disse no, Stevie abbozzò, e si limitò a far scadere il suo contratto con la Motown, che lo legava all’etichetta fino ai ventun anni, la maggiore età negli Stati Uniti. Così, nel 1971 si ritrovò legalmente un uomo adulto, con una carriera già più che avviata, e la possibilità di pubblicarsi da solo la sua musica. Quella che gli pareva. Senza contratto, Stevie registrò due dischi, Music Of My Mind e Talking Book, che usò come leva per ottenere nel 1972 dalla Motown un nuovo contratto, con un milione di anticipo – dieci volte più dei soldi guadagnati nel decennio precedente – royalty più alte e soprattutto la libertà creativa che chiedeva. Nel frattempo, proprio tra Music Of My Mind e Talking Book, aveva conosciuto i produttori Robert Margouleff e Malcolm Cecil, che lo introdussero all’uso dei sintetizzatori. L’anno successivo, era pronto per registrare Innervisions.
L'album che uscì da quelle sessioni è uno dei capolavori della musica del Novecento, in un decennio d’oro per Stevie Wonder, che nei Settanta compie il salto definitivo verso la storia.
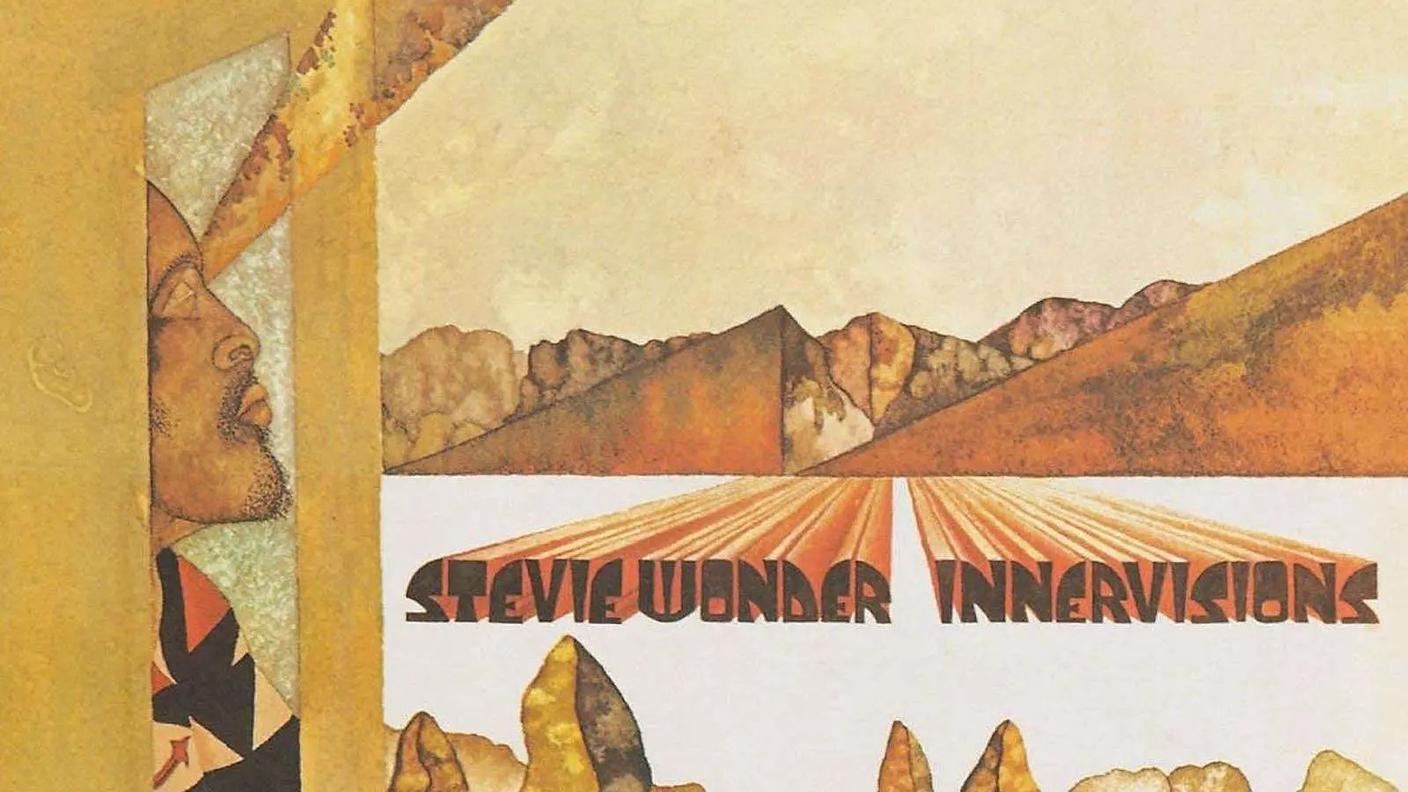
Innervisions è stato descritto dai critici come "Il tentativo di Stevie Wonder di trovare una speranza nel cambiamento dei tempi che stava coinvolgendo l'America nera". Il personale è politico, diceva un noto slogan degli anni Sessanta, e Wonder sembra riprenderlo in canzoni che parlano di amore (Golden Lady) e perdita di quest’ultimo (All In Love Is Fair), di governo e politica (He’s Misstra Know-It-All, su Richard Nixon), riflettendo sulle sfide individuali e collettive dei neri, sulla distruzione del sogno americano in un gorgo di droga (Too High), violenza e conflitto, fino a immaginare nuove soluzioni e nuove possibilità: “La legge non è mai passata / Ma ora tutti gli uomini si sentono liberi / Siamo davvero andati così avanti, nello spazio e nel tempo / O è solo una visione, nella mia mente?”. Dall’afflizione della realtà a nuove visioni – interiori prima, poi destinate a riflettersi nel mondo – capaci di liberare l’immaginazione, e farci tornare (o restare) umani. Naturalmente, senza riuscire a cancellare l’ansia che si tratti solo dell’ennesima illusione.
Ovviamente l’impegno che traspare dai testi non mette in ombra il genio musicale di Wonder, che in sette pezzi su nove suona tutti gli strumenti. Ogni canzone è invecchiata splendidamente, ma forse la coppia composta da Living for the City e Higher Ground rappresenta il miglior esempio dell’attualità di Innervisions: la prima è la storia di un giovane nero che lascia la sua casa nel Mississipi per recarsi a New York, ma finisce vittima di quello che oggi gli americani hanno chiamato “razzismo sistemico”, e che negli anni Settanta era semplicemente la normalità. Un pugno nello stomaco nascosto dentro una confezione funk perfetta: senza ascoltare le parole, potrebbe quasi essere un pezzo buono per ballare. Quasi. La seconda, una canzone di protesta che quarant’anni dopo la sua composizione è diventata l’inno che ha portato il primo presidente nero alla Casa Bianca. L’ennesima dimostrazione che quel groove ipnotico parla, oltre il tempo e le generazioni. Una canzone sopravvissuta anche a se stessa, che a ben sentire porta evidenti i segni della depressione che ha accompagnato diversi momenti della vita di Stevie Wonder, così come della soluzione che appare più evidente ai suoi occhi: Dio. L’eco delle parole di Martin Luther Knig, del resto, era ancora fortissimo.
Tre giorni dopo il lancio di Innervisions, la sera del 6 agosto 1973, Stevie Wonder era su un’auto guidata da suo cugino John Harris lungo l'Interstate 85, in South Carolina. Harris cercò di superare un camion carico di legname, invece provocò un incidente durante il quale un tronco volò via dal camion e si schiantò contro il parabrezza colpendo Stevie. Gli provocò un trauma cranico e una commozione cerebrale, e pare che Wonder rimase incosciente per diverse ore – alcuni dicono, giorni – prima di cominciare una lenta ripresa. Nonostante ci siano alcune stranezze in questa ricostruzione (riportate ad esempio dalla biografia di Mark Ribowsky Signed, Sealed, Delivered: The Soulful Journey of Stevie Wonder, che non nasconde i dubbi dei suoi collaboratori dell’epoca) la storia è ormai scritta così: ogni riferimento spirituale dentro Innervisions è un presagio dell’incidente che ha regalato a Wonder una seconda vita, attraverso un miracolo. È del resto stato lui stesso a dichiarare: “Devo aver capito che stava per accadere qualcosa, che sarebbe servita a farmi prendere coscienza di molte cose, a rimettermi in sesto. È stata la mia seconda occasione di vita, per fare di più, e per dare valore al fatto che sono vivo”. Come sempre, realtà e leggenda si mescolano più volentieri, quando c’è di mezzo musica tanto meravigliosa.






