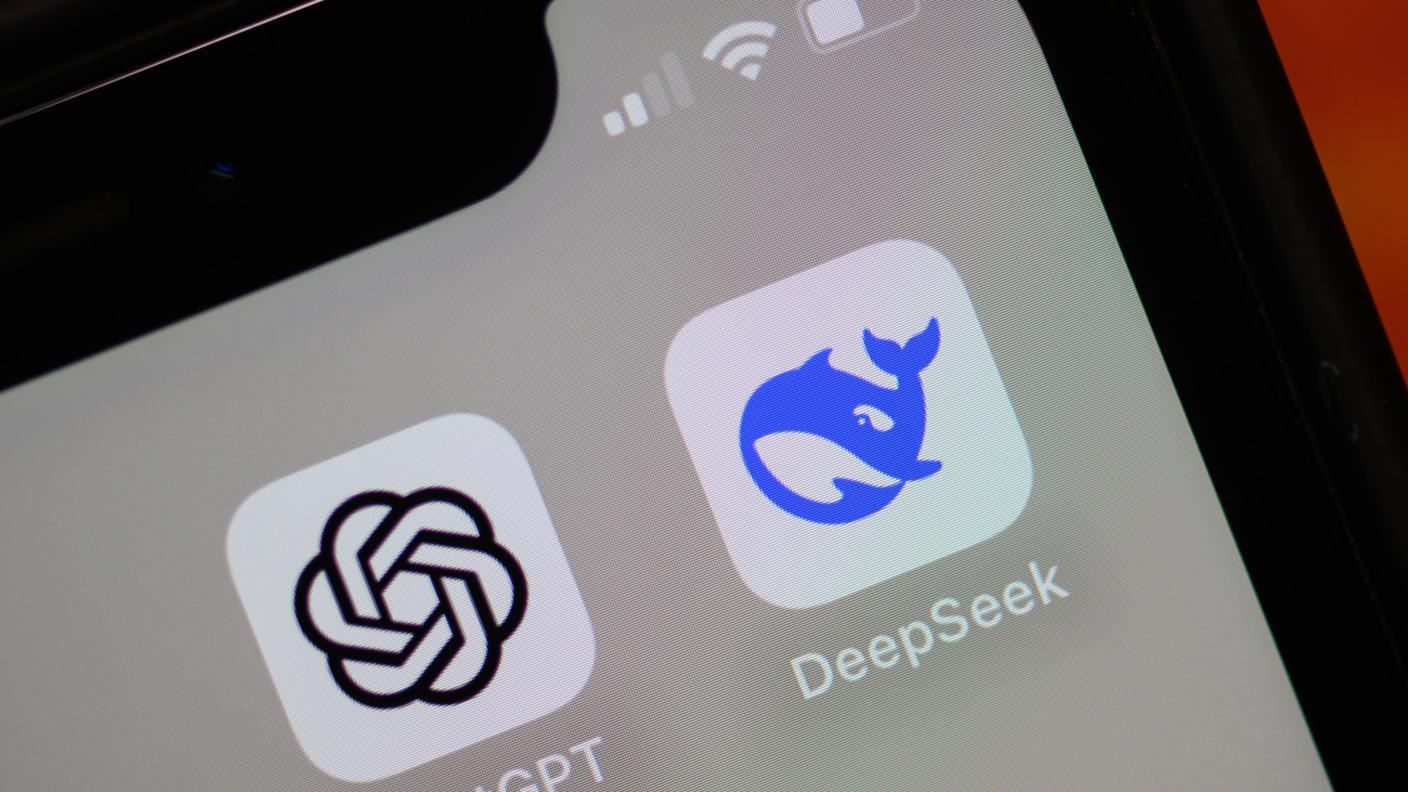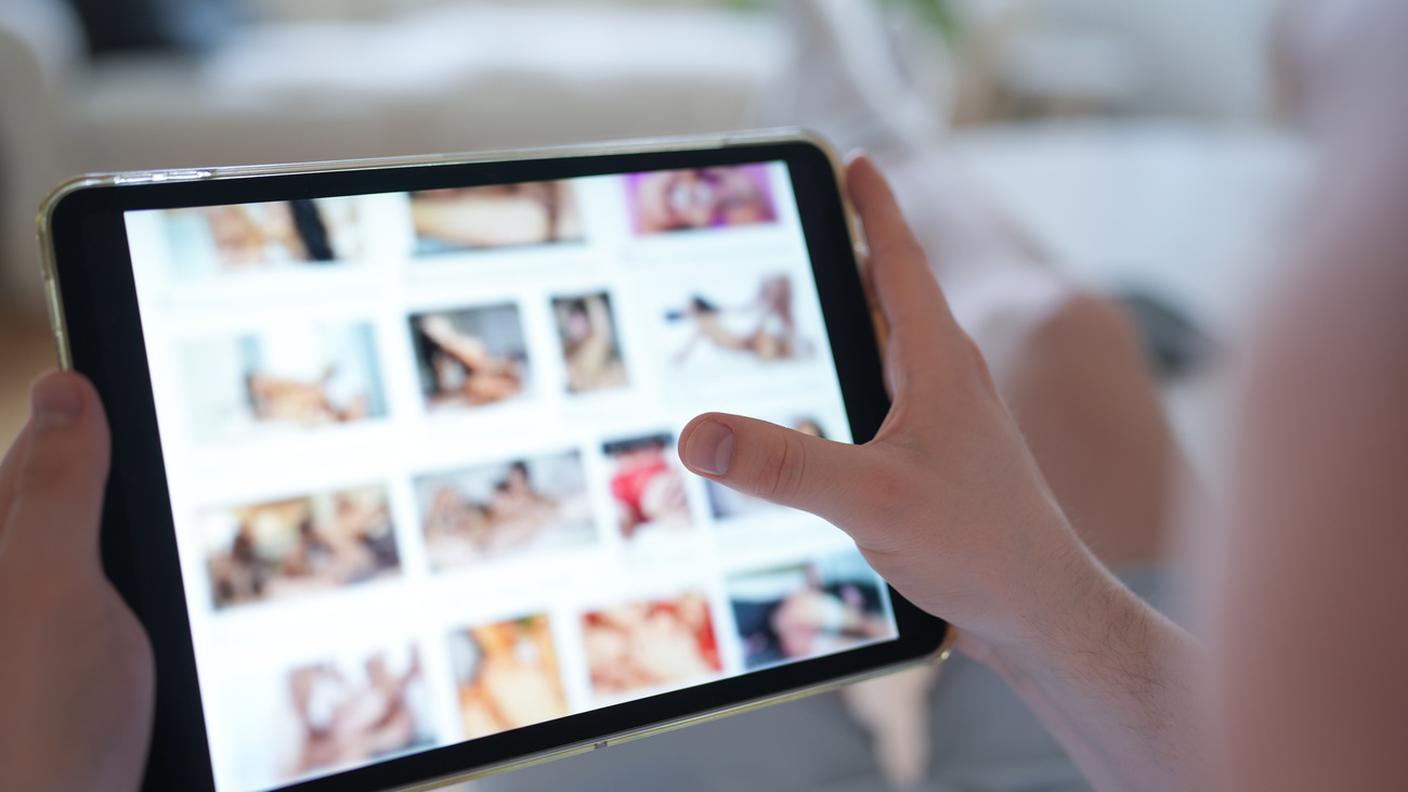Un altro aprile, un’altra primavera per l’intelligenza artificiale. Nel 2023, di questi tempi, cedevo all’ondata di hype intorno all’argomento, e scrivevo delle preoccupazioni dell’industria musicale riguardo alla musica generata da software. Fake Drake e compagnia, quel periodo ce lo ricordiamo tutti. Due anni dopo, la confusione è ancora grande, sotto il cielo dell’AI.
Un po’ di cose che sono successe nel frattempo.
1) Diverse startup tecnologiche si sono concentrate sulla musica: nel corso del 2024 si è parlato molto di Suno e Udio, software in grado di comporre testi, riprodurre voci, scrivere melodie e generare strumentali, tutto in pochi clic. Dopo aver raccolto più di 120 milioni di dollari di finanziamenti, Suno è stata citata in giudizio dalle major, che non vedevano di buon occhio il fatto che quei risultati erano stati ottenuti dopo aver dato in pasto al programma milioni di ore di musica protetta da diritti d’autore. Strano, in effetti.
2) Alcuni musicisti un po’ in là con gli anni hanno usato l’intelligenza artificiale per ringiovanire la loro voce: il caso più eclatante è quello di Brenda Lee, ottantenne star del country che ha pubblicato una nuova versione in spagnolo della sua mega-hit natalizia Rockin’ Around the Christmas Tree, utilizzando un’intelligenza artificiale “addestrata responsabilmente” (qualsiasi cosa significhi) per effettuare la traduzione, e soprattutto riprodurre la voce dei tempi d’oro. Considerate che la versione in inglese, originariamente del 1958, nel solo 2022 aveva totalizzato 464 milioni di stream, e capirete che non si tratta di una piccola notizia.
L’idea di utilizzare l’AI per aiutare i cantanti anziani non è male, ma ovviamente la più diffusa è sempre quella di resuscitare i morti: e così, Drake ha inserito un deepfake della voce di Tupac Shakur in uno dei capitoli del suo celeberrimo dissing con Kendrick Lamar, quello finito male; ma anche (giusto per andare su personaggi e generi completamente diversi), gli eredi di Jerry Garcia hanno stretto un accordo con la società di intelligenza artificiale ElevenLabs per ricreare la voce del defunto leader dei Grateful Dead, in modo da poterla utilizzare per leggere audiolibri, e-book, articoli e altro, in 32 lingue diverse. Quindi, se volete farvi leggere Kafka da Jerry, la sera, beh, potete. Perché dovreste volerlo fare, non è dato sapere. A me, comunque, gli audiolibri fanno dormire più delle benzodiazepine.
3) Sono state svolte diverse ricerche sull’effettivo utilizzo dell’AI nel mondo musicale: più o meno tutte concordano nel dire che tre quarti dei produttori tendono a non utilizzarla, se non in fase di mastering o per altri usi prettamente tecnici. E anche tra i non-addetti ai lavori, gli appassionati di musica artificiale sembrano essere ancora pochi, almeno se rapportati al florilegio di nuove società che si sono buttate su questo mercato. Vedremo.
Sono solo tre esempi che raccontano come l’orizzonte della musica non-umana si sposti velocemente; ma allo stesso tempo, direzione e destinazione sono tutt’altro che chiare. La questione più importante rimane senza dubbio il significato dell’intelligenza artificiale generativa per l’industria musicale. Cioè – perdonate la volgarità – l’impatto sui soldi. Perché si può sempre sostenere che i musicisti debbano fare musica solo per amore dell’arte, ma di solito a farlo sono gli artisti che abitano in qualche castello hollywoodiano degno del grande Gatsby.
Quando pensiamo all’industria musicale, pensiamo subito alla musica pop che passa in radio, a Taylor Swift e Beyoncé. Ma le etichette e i singoli autori dipendono economicamente, ad esempio, anche dalla musica di sottofondo che sentiamo nei bar e nei negozi, negli hotel e in generale nei luoghi pubblici. Per non parlare del business della musica cosiddetta utilitaristica: playlist costruite con suoni studiati per aiutare gli ascoltatori a concentrarsi, rilassarsi, oppure allenarsi in palestra. Pensate ai lo-fi beats che accompagnano i momenti di studio di milioni di ragazzi delle generazione Z, e avrete un’idea delle dimensioni del fenomeno.
Potrebbe essere proprio questo, il primo ambito in cui l’impatto dell’AI generativa si farà sentire: un ristorante potrebbe decidere di riprodurre musica artificiale, simile ad altra che conosciamo, ma non uguale, per evitare di pagare Suisa o altre organizzazioni equivalenti. Allo stesso modo, un film a basso costo potrebbe utilizzare musica generata da un algoritmo. Esiste infatti un mercato – tutt’altro che secondario – per la musica cinematografica e televisiva, che rappresenta fonte di sostentamento per molti musicisti e compositori. Non sto parlando di Mozart della modernità come Ennio Morricone, ma di professionisti del settore, attorno a cui si muovono turnisti, studi di registrazione, tecnici del suono e ogni altra figura necessaria a questo tipo di produzioni.
La sostituzione degli umani in questi settori avverrebbe gradualmente, come sta accadendo ad esempio nel mondo dei giornali e delle riviste, che – soprattutto in caso di testate native digitali – pubblicano una dose sempre crescente di scritti e illustrazioni generate da software. Così, senza arrivare agli estremi della cosiddetta “dead internet theory”, che prevede entro breve uno spazio digitale completamente sommerso da contenuti non-umani, alcune ricerche stimano che entro il 2030 l’AI generativa potrebbe arrivare a occupare circa un quarto del mercato dei ricavi musicali da streaming, passaggi cinematografici/televisivi e riproduzioni in spazi pubblici. In attesa, naturalmente, delle prime hit pop completamente artificiali.
Dunque, cosa fare? Beh, per prima cosa, perdonate la banalità, non sperare che sia davvero possibile resistere al cambiamento: l’avanzamento tecnologico è inevitabile, e procede senza il nostro consenso. Peggio dei fanatici dell’AI, ci sono solo i talebani che pretendono di bandire completamente dal panorama culturale ogni discorso al riguardo.
È però necessario, nel caso della composizione generativa di opere musicali, cercare di assicurarsi che gli autori siano equamente compensati: i diritti sulle opere dovrebbero essere concessi in licenza, e i programmi di intelligenza artificiale dovrebbero permettere di tracciare i riferimenti originali che sono stati usati per rispondere a una determinata richiesta dell’utente. Ancora meglio, si potrebbe creare una specie di identità digitale univoca per gli artisti, che contenga le informazioni sulla loro musica e i loro diritti d’autore, e tramite la quale possano concedere autorizzazioni per l’addestramento dell’AI generativa o per altri usi innovativi. L’obbiettivo è quello di costruire un sistema equo e trasparente, in cui l’intelligenza artificiale generativa diventi etica: un volano per il mercato, invece che l’arma finale destinata a distruggere la creatività. Se vi sembra una complessa, improbabile utopia, forse avete ragione. Ma è necessario provarci.
Inoltre, si può implementare qualche forma di resistenza tecnologica all’invasione dei contenuti generati da software: la piattaforma di streaming Deezer (non a caso europea, e quindi meno avvezza alla deregulation tipica dell’approccio americano) ha di recente inserito nei suoi algoritmi uno strumento di rilevamento dell’intelligenza artificiale, che segnala i brani che ritiene completamente frutto di AI generativa. Una volta che il brano viene segnalato, viene di conseguenza rimosso dalle raccomandazioni. L’idea sembra buona: in questo modo, la musica artificiale rimane a disposizione degli utenti e può comunque generare profitti, ma ai contenuti prodotti dall’uomo viene garantito un piccolo vantaggio. Peccato che gli stessi programmi che analizzano i brani siano una forma di intelligenza artificiale, e come tale siano soggetti a svarioni ed errori marchiani: i “falsi positivi”, insomma, sono dietro l’angolo. Perché le intelligenze artificiali, spesso, sono più artificiali che intelligenti. Ma questa è un’altra storia, sulla quale ci sarà occasione di tornare. Magari, nella prossima primavera dell’AI.
USA: mentre l’intelligenza artificiale entra nelle scuole emerge un paradosso
Tra le righe 22.04.2025, 15:00
Contenuto audio