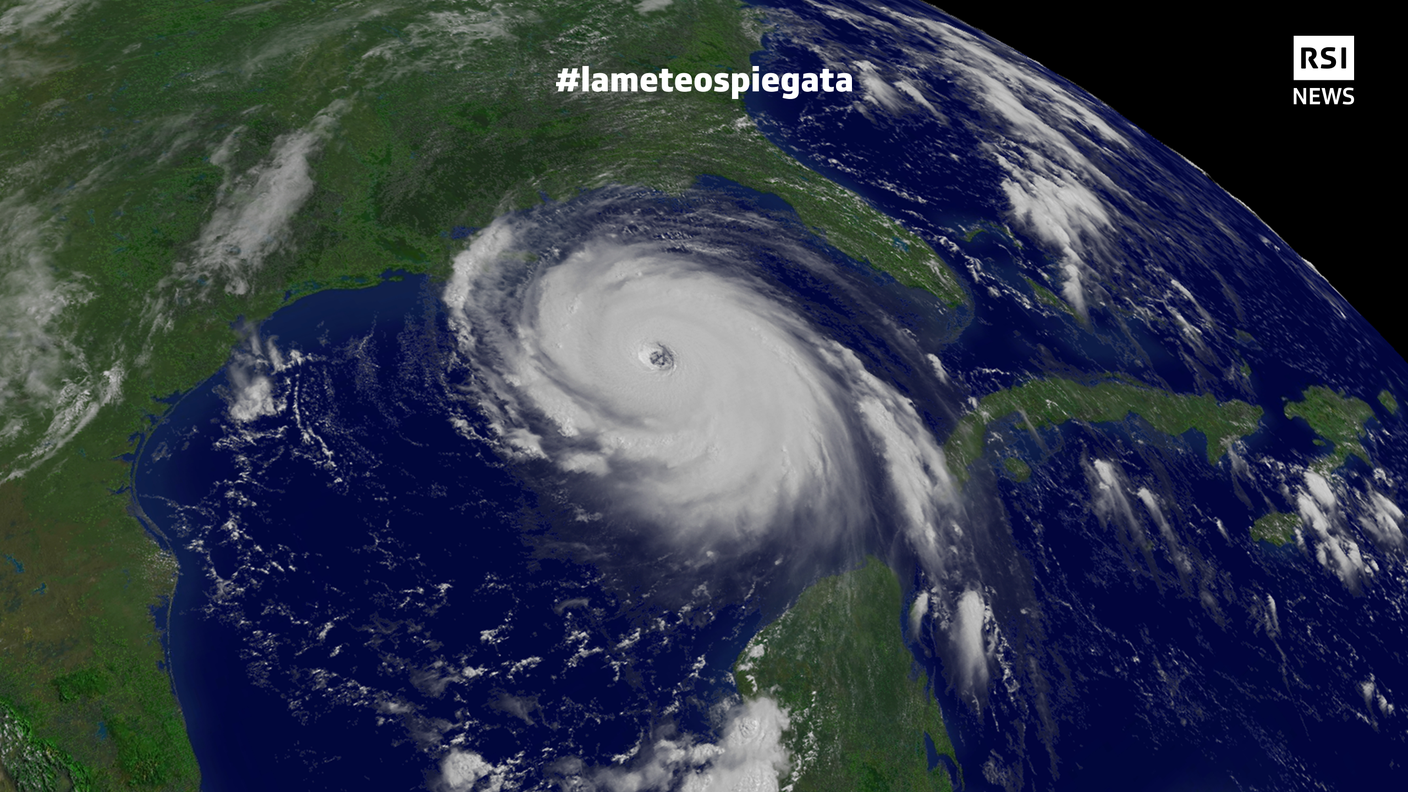“La nebbia agli irti colli, piovigginando sale…” Chi non ricorda questo attacco poetico? Senza scomodare Giosuè Carducci e la sua San Martino, si può senz’altro dire che è uno dei primi automatismi che scatta nella testa degli italofoni quando si parla di nebbia. Noi oggi però non vogliamo parlare di poesia, ma di meteorologia, come ogni mese nella rubrica RSINews #lameteospiegata.
La nebbia è infatti molto di più di una poesia, e gli amici sull’Altopiano svizzero e quelli più a sud nella Pianura Padana ne sanno certamente qualcosa. Sul versante sudalpino siamo un po’ più fortunati, ma il fenomeno esiste ovviamente anche qui. Per capirci qualcosa in più come sempre ci appoggeremo sull’esperienza del meteorologo di Locarno Monti Luca Nisi, a cui si aggiunge l’esperienza di Stefano Zanini, pure lui previsore per MeteoSvizzera e con alle spalle ben 17 anni di previsioni “nebbiose” a nord delle Alpi.
Che cos’è la nebbia?
Partiamo dal principio: la nebbia è un tipo particolare di nuvola, del tipo strato. “Tipicamente – spiega Luca Nisi – il banco di nebbia è lo strato nebuloso, che può toccare il terreno se si tratta appunto di nebbia. Quando invece è localizzato negli strati più bassi dell'atmosfera, ma non tocca il fondovalle o la pianura, ma ad esempio un versante, lo si chiama banco di nebbia alta. La nebbia è costituita da goccioline d'acqua liquida o da cristalli di ghiaccio, a dipendenza della temperatura, che sono sospesi in aria: sono infatti troppo leggeri per cadere verso il basso. A causa poi della diffusione della luce solare, sia che si tratti di goccioline d’acqua o cristalli di ghiaccio, la nebbia limita di molto la visibilità e crea all'osservatore un alone biancastro davanti agli occhi”. E la relazione che ne deriva è piuttosto scontata: maggiore è il numero delle goccioline presenti, “più densa sarà la nebbia e più limitata sarà la visibilità”.

Quando e perché si forma la nebbia e quando e perché si dissolve
La nebbia si può formare e dissolvere a causa della variazione di due parametri meteorologici: la temperatura dell'aria oppure la quantità di vapore acqueo, ovvero il valore di umidità assoluta dell'aria. “Il processo di formazione o dissoluzione, come accade spesso nella realtà, può avvenire anche per la variazione di entrambi i parametri (temperatura e umidità). Per quanto riguarda la variazione di temperatura, a livello fisico bisogna pensare che più l'aria si raffredda e meno vapore acqueo può essere presente in questo “pacchetto” di aria che stiamo considerando. E raffreddandosi, l'umidità relativa dell'aria aumenta. Per umidità relativa si intende la quantità d'acqua nell'aria presente sotto forma di vapore, comparata alla quantità massima di vapore acqueo che in questo pacchetto d'aria può essere presente. Raffreddandosi c'è insomma meno spazio - per così dire – a disposizione del vapore acqueo. Dal momento che raggiungiamo il 100% di umidità relativa, con quindi tutto lo spazio a disposizione del vapore acqueo occupato, ecco che l'aria comincia a condensare e il vapore inizia a essere visibile. Al contrario, se abbiamo già un'umidità relativa del 100% e c’è presenza di nebbia, se andiamo ad aumentare la temperatura dell'aria, di colpo quest’aria dispone di una maggiore quantità di vapore acqueo e le goccioline inizieranno a evaporare facendo dissolvere la nebbia.

Condensazione e formazione di un banco di nebbia alta sull'Alto Ticino
Il fenomeno come detto può però essere legato anche a un aumento o a una diminuzione dell’umidità. “Se pensiamo sempre al nostro ‘pacchetto’ di aria presente in una data località con una data umidità una data temperatura, il vento potrebbe ad esempio convogliare dell’aria decisamente più umida, andando anche in questo caso ad aumentare l'umidità relativa. Se si arriva al 100% il gioco è fatto ed ecco che comincia a formarsi la nebbia. Al contrario, potremmo avere della nebbia presente in un dato luogo e con l’arrivo del favonio, un vento tipicamente molto secco, potrebbe far evaporare le goccioline d’acqua e la nebbia si dissolve”.
Nebbia e foschia, una differenziazione da “vedere”
A fare da spartiacque nellacategorizzazione di nebbia e foschia è in particolare un parametro: la visibilità, ovvero la distanza massima alla quale un oggetto è ben visibile daun osservatore a occhio nudo. “Anche i meteorologi di Locarno Monti, a cadenza regolare in occasione dell’osservazione del cielo che viene fatta ogni 3 ore, stimano la visibilità atmosferica dal punto d’osservazione posto sul tetto del centro regionale sud di MeteoSvizzera. Si guardano proprio gli oggetti che abbiamo attorno e si tratta di una stima cheviene fatta in modo soggettivo, chiaramente non priva di errori. Negli aeroporti invece, sulle corte distanze abbiamo anche degli strumenti che stimano proprio la trasparenza dell’aria. In meteorologia possiamo poi dire che per definizione abbiamo nebbia quando la visibilità non supera i 1000 metri: insomma quando di una casa, di un albero o di qualcos’altro non sono visibili i bordi, oppure l’oggetto è visibile in modo molto offuscato, a una distanza minore di un chilometro. La nebbia si suddivide poi a sua volta in tre categorie fondate sulla visibilità: la nebbia spessa, quando la visibilità ècompresa tra 50 e 200 metri, la nebbia fitta con visibilità compresa tra 30 e50 metri e la nebbia densa, quando la visibilità si ferma ai 30 metri massimi. In alcuni casi, soprattutto in montagna e soprattutto in inverno, possiamo avere addirittura pochi metri di visibilità, che genera una sensazione quasi claustrofobica.

Forte inversione termica con caligine densa sul Ticino centrale e meridionale nel dicembre 2019
Se la visibilità invece è limitata, con un fenomeno di oscuramento presente, ma comunque superiore ai 1000 metri, parliamo di foschia, che è come una specie di nebbia molto rarefatta. “All'interno della foschia l'umidità relativa è spesso alta, ma non raggiunge il 100%. Di converso in meteorologia se la visibilità è superiore ai 15 chilometri e non abbiamo nessun effetto di oscuramento, l’atmosfera viene considerata limpida. Una soglia che cambia nell’aviazione: quando si riesce a vedere oltre i 5 chilometri l’atmosfera è già considerata limpida. La foschia si suddivide inoltre in due processi differenti, sia nella formazione sia nel risultato finale all'osservazione. La foschia umida è composta prevalentemente da goccioline d'acqua sospese che limitano la visibilità, come detto, tra 1 e 15 chilometri e l'umidità relativa è almeno del 75%. Se invece la visibilità è limitata allo stesso modo, ma l'aria è un po’ più secca, al di sotto del 75%, il fenomeno prende il nome di caligine: un tipo di foschia asciutta dove le piccole particelle che oscurano o rendono opaca l'atmosfera sono principalmente dovute a pulviscolo secco, causato da fumo, polveri o particelle varie a causa delle più svariate emissioni legate all’attività dell’uomo”.
Le tipologie di nebbia in base al processo di formazione
Abbiamo già visto che a livello macroscopico esistono due tipi di nebbia: quella alta e quella bassa, che tocca il suolo. Oltre alla visibilità, la nebbia viene però classificata anche in relazione alla sua formazione. “La prima tipologia che incontriamo è la nebbia da irraggiamento, che si forma generalmente dopo il tramonto, quando il suolo ha ceduto il calore all'atmosfera circostante tramite appunto l'irraggiamento. Un processo che avviene tipicamente in autunno e in inverno, quando con delle notti lunghe i bassi strati dell’atmosfera si raffreddano in modo importante. Raffreddandosi l’umidità relativa nell’aria aumenta e, quando raggiunge il 100%, vicino alla superficie terrestre inizia a formarsi uno strato di nebbia rarefatto e molto basso, anche poche decine di centimetri, che via via si innalza verso l'alto e, una volta superata la soglia dei due metri, iniziamo a parlare di nebbia vera e propria. L’arrivo del sole scalda poi la superficie di quest’aria che, tramite il rimescolamento, tenderà a dissolversi in maniera sempre più marcata. La nebbia da irraggiamento segue tendenzialmente il ciclo diurno.

La tipica nebbia da irraggiamento mattutina
Troviamo poi la nebbia da avvezione, che si forma quando arriva aria più mite rispetto a quella che abbiamo in un dato momento e luogo, con un apporto di umidità superiore. L’umidità relativa aumenta e se raggiungerà il 100% ecco che inizierà il processo di condensazione formando il banco di nebbia.

La nebbia da avvezione avvolge quasi completamente il noto Golden Gate Bridge di San Francisco
Abbiamo poi la nebbia da umidificazione, che è un po’ più localizzata ed è creata dall'aria fredda che transita su un oceano o un mare con acqua molto più calda. In Svizzera possiamo dire che questo effetto è molto limitato. A livello molto locale potrebbe succedere in prossimità di laghi particolarmente grandi, mentre nel Nord Europa capita più spesso con la discesa di aria artica sul mare soprattutto in autunno, quando il mare è ancora caldo. Come negli altri casi l’aria si raffredda vicino alla superficie del mare: in essa può essere quindi presente un minor quantitativo di vapore acqueo e quindi rapidamente inizia il processo di condensazione.

Nebbia da umidificazione fotografata in California, sul lago Almanor
C’è poi la nebbia frontale, che conosciamo invece bene anche a sud delle Alpi e in tutta la regione alpina. È la nebbia che si forma quando una precipitazione cade nell'aria secca dietro una nube: le goccioline liquide evaporano in vapore acqueo e si formano dei banchi di nebbia. Succede spesso quando abbiamo una perturbazione che raggiunge la regione alpina con un fronte caldo che si scontra con uno freddo.

Nebbia frontale fotografata in Svezia nel 2015
Proseguendo troviamo la nebbia che si congela, o nebbia sopraffusa. Succede quando le goccioline all'interno della nebbia sono allo stato liquido, ma si trovano in un'area dove la temperatura dell'aria è inferiore a zero gradi, anche di parecchio. Al contatto con la superficie o gli oggetti le goccioline congelano di istantaneamente si formano dei depositi di ghiaccio, chiamati anche galaverna oppure ghiaccio chiaro. È molto frequente sulle cime delle montagne, che sono spesso esposte anche a un debole vento che fa cozzare queste goccioline d'acqua sulla superficie.

Nebbia sopraffusa sul fiume Bow, in Canada
Infine abbiamo la nebbia ghiacciata o gelata, una tipologia molto rara, ma più frequente in montagna e in cui le goccioline sono congelate a mezz'aria. Le temperature devono essere solitamente inferiori a -30/-40 e è osservabile soprattutto nell'Artico, però in casi molto particolari la si può vedere anche su qualche cima della cresta alpina in inverno. È una sorta di precipitazione formata da aghi di ghiaccio che può causare una diminuzione della visibilità.

Un esempio di nebbia ghiacciata in un campo
Smog e inquinanti, gli aiutanti della nebbia
Tra inquinamento e nebbia esiste una doppia relazione che si manifesta soprattutto nel periodo autunnale-invernale, quando è presente spesso un’inversione termica, con aria più calda in montagna e più fredda e pesante nei bassi strati, dove vengono intrappolati anche gli inquinanti (di solito sotto i 2000/2500 metri). L'inversione termica può causare della nebbia e la nebbia stessa può andare anche a rinforzare l’inversionetermica. “Chiaramente potete immaginare che se le emissioni continuano e non c'è rimescolamento della massa d'aria per più giorni o addirittura, in casi estremi per più settimane, le concentrazioni di inquinanti continuano adaumentare. Si può quindi dire chela nebbia può peggiorare l'inquinamento atmosferico. Oltre a intrappolarlo negli strati più bassi, ne aumenta infatti anche la tossicità, in quanto la nebbia è anche in grado di disciogliere queste particelle o questi gas nelle goccioline, rendendoli più pericolosi per l'uomo e per la vita animale ingenerale”. E la seconda relazione? “Le emissioni possono fornire un numero maggiore di impurità, piccole particelle di aerosol che fungono anche da nuclei di condensazione, che vanno a stimolare e accelerare la formazione di nebbia”.
Un serbatoio d’acqua prezioso
Detto degli aspetti spesso negativi della nebbia (visibilità e inquinanti), è altrettanto vero che ce ne possono essere anche di positivi. “In particolare garantisce alla flora un apporto di umidità anche in assenza di precipitazioni, con le goccioline che possono andare a depositarsi sulle foglie o anche sul terreno. Se pensiamo ad esempio alla Pianura Padana, dove ci sono stati degli inverni caratterizzati da situazioni anticicloniche molto pronunciate – il 2022 è forse il miglior esempio – la nebbia, tipica proprio di queste situazioni, può portare comunque un’umidificazione del terreno e della flora e quindi mitigare, almeno in parte, eventuali condizioni siccitose importanti e prolungate”.

La nebbia che copre e avvolge il Piano di Magadino nel 2016
Uno dei peggiori nemici dei frequentatori della montagna
Chiva in montagna lo sa: la nebbia può essere più che insidiosa e può raggiungerti velocemente e quando meno te lo aspetti. C’è però anche molta differenza tra la nebbia estiva e quella invernale in quota: “Nella stagione calda è spesso causata dalla formazione di cumuli sui rilievi, quindi velocemente si può passare da una giornata di tempo ben soleggiato ad essere avvolti dalla nuvola e quindi concretamente all'interno della nebbia. Bisogna però dire che a causa del terreno tipicamente caldo, l'aria vicina al suolo può essere presente un maggior quantitativo di vapore acqueo e difficilmente il nostro banco di nebbia si “attacca” al terreno, permettendo comunque all'escursionista di avere alcune decine di metri di visibilità. Situazione decisamente differente per chi si trova invece su un ghiacciaio oppure trova queste condizioni d'inverno, quando il terreno freddo permette al banco, tipicamente sotto forma di strato e non più di cumulo e quindi già molto più denso a livello di goccioline in sospensione, di toccare praticamente il terreno. La visibilità è molto più limitata e in casi estremi anche a pochi metri, dando all'escursionista anche esperto una sensazione di smarrimento fino ad arrivare ai capogiri, perché praticamente il cervello non ha più punti di riferimento”.
Arolla, 6 gli alpinisti morti
Telegiornale 01.05.2018, 12:30
La nebbia alta, una questione molto svizzera e alpina
La nebbia alta è un fenomeno ben presente in Svizzera e Stefano Zanini, collega di Luca Nisi a Locarno Monti e previsore per ben 17 anni a Nord delle Alpi, conosce bene. “Solo da noi nella regione alpina, o nelle regioni con conformazioni montuose simili, la definiamo infatti così, ed è principalmente a causa di un motivo molto semplice: nel nostro territorio si può facilmente ‘sfuggire’ alla nebbia, salendo al di sopra del suo limite superiore ma restando con i piedi sempre ben piantati al suolo. Si può pensare ad esempio alla Svizzera interna e a quando c’è un limite superiore della nebbia sui 900 metri di altitudine: nelle Prealpi nei finesettimana o nei giorni festivi le cime sono stipate di gente, persone che scappano dal grigiore più in basso (che può persistere per giorni) per trovare il cielo terso e il sole al di sopra e il cosiddetto mare di nebbia sotto. Noi abbiamo la fortuna di poterlo fare proprio grazie alle montagne e da qui deriva il concetto di nebbia alta. Al contrario, in regioni pianeggianti non c’è modo di scappare alla nebbia e questa distinzione perde quindi di significato”.

Quando è possibilie sfuggire alla nebbia salendo di quota (senza essere alpinisti), si parla di nebbia alta
Meteosvizzera parla di nebbia alta in presenza di un limite superiore che permette ragionevolmente di salire sopra la nebbia: “Diciamo che nei bollettini meteorologici di solito si parla di nebbia alta fino a un limite superiore tra i 2000 e i 2400 metri, a dipendenza della regione e della facilità con cui si possono raggiungere queste quote. In Romandia ad esempio ci sono meno accessi e il limite massimo viene considerato a 2000 metri, mentre nella Svizzera tedesca – con montagne accessibili come il Säntis o il Pilatus – si sale con il limite anche fino a 2400 metri”.
L’Altopiano come una vasca da bagno: le zone più nebbiose in Svizzera
“Dobbiamo immaginarci l’Altopiano un po’ come una vasca da bagno: le Alpi in particolare in inverno producono aria fredda che poi dalle valli si riversa proprio qui e rimane intrappolata producendo appunto la nebbia. Questa è infatti la zona Svizzera più interessata dal fenomeno” ci dice ancora Zanini, “ma anche qui non tocca ovunque allo stesso modo”. La zona più nebbiosa è infatti da considerarsi quella che va dai piedi del Giura, passando per la zona dei tre laghi (Bienne, Neuchâtel e Morat), per poi risalire verso Soletta e Olten fino ad arrivare in Argovia. A questo ‘corridoio’ si aggiungono anche le zone più basse del nordest, intorno al lago di Costanza, come pure la valle della Reuss uscendo da Lucerna, soprattutto la zona del Rotsee. “Queste sono sicuramente le tre zone più toccate dalla nebbia in Svizzera, dove è più frequente e anche persistente”.

Classica nebbia "da Altopiano" a Oensingen, nel Canton Soletta
Su questo fronte, a differenza di quanto avevamo visto ad esempio per i fulmini, il Ticino, ma anche i Grigioni, sono tra le zone meno colpite dalla nebbia: “La conferma arriva anche dalla statistica sulle giornate di sole, il Ticino svetta infatti in questa classifica e – a differenza di quel che molti pensano – la differenza la fanno in maniera importante anche le giornate invernali, visto che Oltralpe sono molte quelle perse proprio a causa della nebbia”.
I periodi “svizzeri”: i mari persistenti e quelli che si dissolvono
Una delle grandi sfide quando si parla di nebbia non è solo prevedere quando si formerà, ma anche e soprattutto quando si dissolverà. E se è già emerso che il periodo più propizio alla nebbia è quello autunnale-invernale, un ulteriore periodizzazione viene fatta proprio grazie alla dissoluzione. “Si fa la distinzione fra il periodo dei mari di nebbia persistenti e quello dei mari di nebbia che si dissolvono nel corso della giornata – spiega ancora l’esperto Zanini –. In certe zone della Svizzera di fatto la nebbia può formarsi tutto l’anno, ma poi si dissolve più o meno rapidamente. E il periodo più persistente e ‘pesante’ va da fine ottobre circa, a inizio febbraio, con la maggior percentuale di mari di nebbia non dissolti tra metà novembre e metà dicembre. In senso più ampio la stagione della nebbia inizia in Svizzera a metà settembre, con le nebbie mattutine che iniziano a diventare più frequenti. In relazione a quanto dicevamo prima sulla nebbia alta, si può pure dire che più il limite superiore è alto e più sarà bassa la probabilità di dissoluzione. Un mare di nebbia con un ‘top’ ad esempio a 800 metri avrà molte più possibilità di dissolversi di un mare che arriva a 1500 metri o più”.
Quali i posti più nebbiosi al mondo? Una classifica quasi impossibile
Se in Svizzera come abbiamo visto è possibile definire in maniera piuttosto chiara quali siano le zone più nebbiose, allargando gli orizzonti a livello continentale e globale l’esercizio diventa praticamente impossibile. “Non è come con le precipitazioni o le temperature, dove abbiamo moltissime misura sistematiche: per la nebbia si hanno giusto quelli puntuali degli aeroporti o di determinate località, ma una vera statistica globale sistematica non c’è. Detto questo è chiaro che le zone più soggette a nebbia sono le vaste pianure. Vicino a noi c’è sicuramente la zona verso la Germania o a sud la Pianura Padana, un po’ più lontano anche la Polonia e in generale le vaste pianure dellEuropa orientale. Poi sul web si trova anche l’indicazione secondo la quale il posto più nebbioso al mondo dovrebbe – e sottolineo dovrebbe – essere Grand Banks, nella provincia canadese di Terranova dove si incontrano la calda corrente del Golfo con la più fredda corrente del Labrador, e dove la nebbia è praticamente quotidiana o comunque per un minimo di 200 giorni l’anno. Si può però anche presumere che il posto più nebbioso potrebbe essere una montagna, possibilmente vicino al mare. Insomma, è una classifica molto difficile da stilare”.
La previsione della nebbia: una vera sfida
La nebbia ha un aspetto statico e ama le situazioni stabili, sarà quindi facile da prevedere verrebbe da pensare… Niente di più sbagliato. “È difficile – prosegue Zanini –, anche se ci sono, come spesso accade in meteorologia, situazioni più facili e altre più difficili. Stabilire l’ora alla quale si forma la nebbia e quando si dissolverà, capire se si svilupperà dappertutto o solo a banchi e quale limite superiore avrà… sono tutte domande da valutare e alle quali fornire una risposta non è affatto facile, visto che come abbiamo visto sono molti i fattori che favoriscono o sfavoriscono la formazione e la dissoluzione della nebbia. Influiscono poi anche il tipo di massa d’aria (punto di rugiada), la stagione, la nuvolosità, il vento e tanti altri parametri. Si procede anche secondo molti principi empirici ricavati da analisi statistiche. Insomma si tratta di una previsione complessa, difficile e delicata, anche perché a dipendenza di dove si forma la nebbia può avere un impatto notevole, in particolare sul traffico aereo e, quando è particolarmente fitta, anche su quello stradale, un fenomeno più presente sulla Pianura Padana rispetto alla Svizzera, ma comunque possibile anche da noi”.
MeteoSvizzera non dirama delle allerte per la nebbia, ma su questo fronte si occupa delle previsioni specifiche per l’aviazione elvetica e in particolare per gli aeroporti, le TAF (Terminal aeronautical forecast), elaborate quotidianamente in “codice” aviatorio.
Un meteorologo nella nebbia: dal “Generale” inverno alle fregature
Stefano Zanini ha vissuto e lavorato, facendo previsioni, in Svizzera tedesca dal 1991 al 2008 e di nebbia ne ha vista parecchia… quali sono i ricordi più significativi e “offuscati” che si porta con sé da quando è rientrato sul versante sudalpino? “Il primo inverno che ho trascorso Oltralpe (’86-’87) fu anche l’ultimo dei tre grandi inverni che ha vissuto l’Europa uno dietro l’altro e, nel gennaio dell’87, è arrivata un'invasione di aria fredda molto marcata… quando sono sceso dal treno in stazione centrale c’erano 20 gradi sottozero, una cosa che oggi non riusciamo più a immaginarci. Dopo quest’aria fredda è arrivata anche una bella alta pressione al di sopra, intrappolando l’aria polare sotto. Il risultato: una cosa tipo 29 o 30 giorni consecutivi con nebbia alta e temperature sotto lo zero. Questo è stato il benvenuto e il mio primo inverno passato in Svizzera interna. Il sole mi mancava, ma amo il freddo e sono riuscito a non scappare (ride, ndr)”.

Il mare di nebbia sopra la regione zurighese osservato da uno stipato Uetliberg, il noto monte fuori Zurigo, nel gennaio 2020
La nebbia lo ha però tratto in inganno più di una volta anche in ambito professionale: “Noi facevamo anche il turno di notte a Zurigo e, in quel caso, la bozza di bollettino veniva redatta entro le 3 e 30, poi ci si dedicava alle previsioni per l’aviazione e infine alle 5.30 il bollettino veniva verificato e spedito. E più di una volta ti ritrovavi lì dopo aver previsto la nebbia, che avrebbe dovuto formarsi, a guardare fuori dalla finestra e di nebbia nemmeno l’ombra. Allora magari correggevi il tiro in possibili banchi di nebbia, e alle 6.30 mentre davi l’intervista ti accorgevi che iniziava a diventare un po’ grigio e, quando alle 7 finivi, iniziavi a sentire puzza di fregatura… e infatti arrivavi a casa a dormire e c’era già il coperchio totale e quando ti svegliavi a mezzogiorno o alla una era ancora lì, la classica fregatura. Succedeva ogni tanto e non si sa veramente perché spesso la nebbia, in particolare quella bassa, si formi spesso alle prime luci all’alba" racconta Zanini.
Nebbia e cambiamento climatico: quale relazione?
“Il cambiamento climatico porta con sé temperature più alte e abbiamo osservato contemporaneamente che la nebbia diminuisce e, anche se forse non è l’unico motivo, la relazione c’è ed è stata recentemente portata alla luce anche da uno studio di due ricercatori di Meteosvizzera” ci dice Stefano Zanini. A incidere, secondo la sua esperienza, è sicuramente anche la diminuzione della frequenza e della durata dei periodi freddi. “Ad esempio quando soffiava la bise gelida si avevano spesso giorni e giorni di nebbia alta, ora queste situazioni si vedono sempre meno. Stabilire le cause precise ed esatte della diminuzione non è però semplice, anche la maggior durata dei periodi con vento da ovest che spinge più a est le masse d’aria fredde di origine continentale può avere il suo ruolo. E allo stesso modo la minor quantità di neve e il terreno più caldo possono incidere. O ancora, pensando ad esempio alla Pianura Padana dove pure si sta osservando un’importante diminuzione della nebbia negli ultimi anni, le sempre più scarse precipitazioni autunnali, con il netto calo della frequenza del cosiddetto monsone autunnale… in passato c’era quindi più umidità che poteva favorire la formazione della nebbia. Insomma, ci sono ancora tante cose da capire, ma visti tutti questi fattori influenzati dal cambiamento climatico, si può senz’altro dire che in futuro ci sarà ancora meno nebbia” conclude Zanini.

Una visione condivisa anche dalle osservazioni del collega Luca Nisi: “Sia sulla Pianura Padana sia sulle pianure dell'Europa centro settentrionale, Altopiano svizzero compreso, effettivamente negli ultimi decenni si constata un calo della frequenza e dell'estensione delle nebbie, in maniera ancora più pronunciata sulla Pianura Padana. Una diminuzione riconducibile all'aumento della temperatura presente in ogni stagione, anche durante il periodo invernale, il quale fa sì che i laghi di aria fredda che si formano siano meno freddi rispetto al passato, favorendo un rimescolamento più rapido e importante tra gli strati bassi e quelli alti (più secchi) quando giunge il sole. È una tendenza confermata anche dai dati statistici e, almeno per quel che riguarda la sicurezza del traffico aereo e stradale, ha un risvolto positivo che va anche a favore della produzione di energia solare” conclude con una nota di ottimismo Luca Nisi.
Non c'è più la nebbia di una volta
RSI Info 24.10.2019, 16:59
L'intervista al climatologo Stephan Bader, RG delle 12.30 del 24.10.19
RSI Info 24.10.2019, 16:57
Contenuto audio

Meteo regionale
Meteo 31.10.2022, 12:40