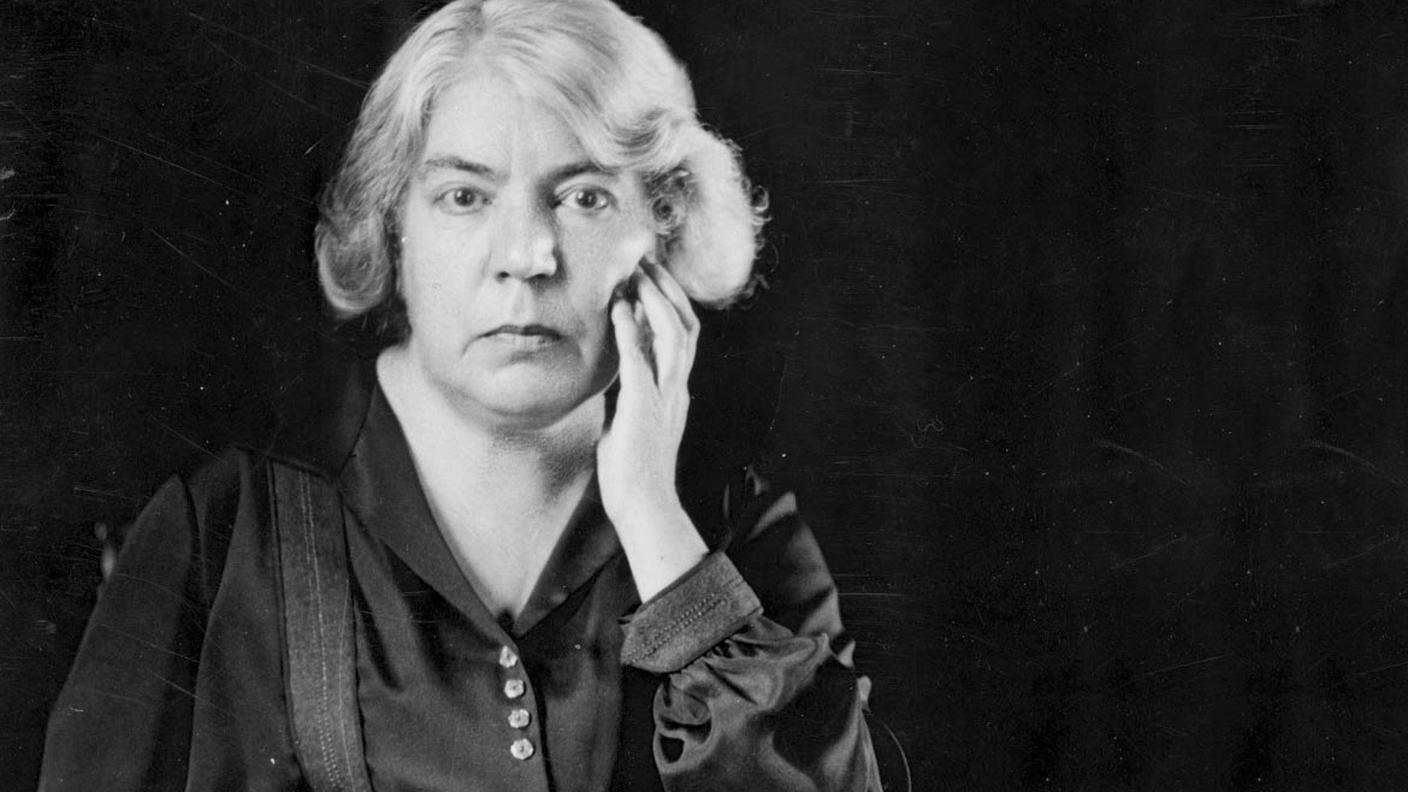L’inizio della grande stagione dell’Umanesimo – origine dell’età moderna – viene simbolicamente posto dagli studiosi in un gesto: quello con cui, il 7 gennaio 1374, appressandosi alla fine, il vecchio Francesco Petrarca da Arquà inviava in dono al giovane teologo Luigi Marsili, agostiniano fiorentino, destinato ad addottrinarsi in Sorbona, quell’esemplare delle Confessioni di sant’Agostino, che, ormai consunto dall’uso, i suoi occhi stanchi non decifravano più. Gesto volutamente carico di allusioni – scrive in proposito l’indimenticato maestro di studi su Umanesimo e Rinascimento, Eugenio Garin – perché quel libro indicava la via da seguire: la via dell’interiorità, ovvero la via di un rinnovamento religioso, capace di rompere gli schemi di una cultura Scolastica ormai priva di significato.
Il pensiero di Jacques Maritain
Alphaville 13.11.2024, 11:05
Contenuto audio
Fu così che proprio nel convento agostiniano di Santo Spirito, sacro alle Muse per i libri della propria biblioteca lasciati dal Boccaccio ai religiosi, che il Marsili trasferì a Firenze l’eredità petrarchesca, combattendo, in nome degli “antichi”, una dura battaglia per la rinascita di un autentica vita cristiana, non disgiunta da un fattivo impegno civile. Segno più evidente di questa rinascita, furono i convegni che radunarono a Santo Spirito, a ragionare delle cose “umane e divine”, uomini colti e popolani, uomini e donne, suscitando anche il sospetto e l’avversione della curia e di quanti accusarono il Marsili di leggerezza e mondanità, per «insegnar la scienza a donne e bambini, invece di meditarla in solitudine o con pochi dotti».
Molti secoli sono passati da quella luminosa, feconda stagione e sempre, ininterrottamente, dal Duecento ad oggi, il convento agostiniano di Santo Spirito, faro di fede e di cultura, con la splendida chiesa brunelleschiana, è rimasto nel suo sito storico, nel quartiere di Oltrarno, condividendo la buona e la cattiva sorte della sua gente.
Anonima Frottolisti, un nuovo tuffo nell’Umanesimo
La Recensione 22.01.2024, 10:35
Contenuto audio
Alla fine del secolo scorso, a partire dal 1979, i Colloqui di Santo Spirito sono rinati, per opera del priore, il teologo padre Gino Ciolini, riproponendo, in chiave moderna ed attuale le motivazioni degli antichi convegni del Marsili, intesi, come allora, non solo alle discipline della mente dell’uomo, ma anche a quella intelligentia fidei che è il duro e meritorio lavoro del credente. Nella splendida sala capitolare del convento per più di un ventennio si sono così avvicendate a parlare insigni personalità - filosofi, storici, teologi, scienziati, cattolici e di altre confessioni, laici – dando vita a una delle esperienze culturali più importanti della città di Firenze, e non solo, dato che gli incontri sono stati raccolti anno per anno ed editi nella Collana di un importante editore romano. Per ricordare i Convegni e padre Ciolini a venti anni dalla morte, il 28 marzo u.s. il filosofo Massimo Cacciari, in quella medesima sala capitolare che tante volte lo aveva visto presente, accanto all’amico priore, ha tenuto una splendida lezione sul tema squisitamente agostiniano «Intelligenza e spirito», in cui, partendo dalla filosofia del mondo classico, è giunto all’attualità dell’ intelligenza artificiale, con tutte le sue enormi possibilità e i suoi altrettanto grandi problemi.
Purtroppo però i tempi non sono propizi per Santo Spirito. Se la chiesa continua ad essere mèta affollata di turisti, richiamati anche dalla presenza di un mirabile crocifisso ligneo, recentemente riconosciuto opera del giovane Michelangiolo, il convento rischia la chiusura. Infatti l’ Esercito ha deciso di lasciare i locali dell’ex Distretto militare, occupati, con l’unità d’Italia, fin dalla metà dell’Ottocento e familiari a tutti i giovani maschi fiorentini ai tempi del servizio di leva obbligatorio, ma ora inutilizzati. Si tratta di un ampio spazio, che contiene importanti capolavori, come il chiostro dell’Ammannati e buona parte del grande Cenacolo, e che faceva parte organicamente del convento, sul cui chiostro, più piccolo, si affaccia. Questo spazio è stato ora concesso a un privato, che prevede di trasformare questa ala del complesso agostiniano in una “senior house”, cioè una residenza per anziani abbienti ed autonomi – ovvero, in pratica, un hotel di lusso. Ciò porterebbe ad una innaturale divisione di spazi, nati per essere uniti, ed alla impossibilità di una quieta permanenza della comunità religiosa. Niente di strano o di nuovo: da tempo gli edifici storici di Firenze, in particolare quelli ecclesiastici, sono oggetto dell’interesse di imprenditori del settore alberghiero – o, come oggi pudicamente si dice in inglese, di housing – data la straordinaria importanza della città nel panorama turistico internazionale - e, del resto, il fenomeno è favorito dalla progressiva rarefazione delle presenze religiose. La proposta degli agostiniani di Santo Spirito è invece quella di riunificare le due parti del convento per farne un centro di vita culturale, di ricerca, di consultazione e di studio, aperto a tutta la città e agli studenti, italiani e stranieri, cui riservare alcuni spazi come alloggio, senza rette da pagare. In loro sostegno si è espressa buona parte della cittadinanza, come pure il professor Cacciari, ma a tutt’oggi non sappiamo come la vicenda finirà.
Quello che comunque possiamo constatare è ancora una volta il prevalere dell’economia, in quello stravolgimento della gerarchia dei valori che contraddistingue la modernità, a partire dalla rivoluzione industriale. Al mondo classico, da Aristotele in poi, come pure a quello cristiano medievale, fino a tutto il Rinascimento, era infatti chiaro che la sfera economica deve essere subordinata a quella politica, e questa a quella morale, dal momento che l’elemento primario è il Bene comune, ed è da esso che devono derivare, ordinatamente, le diverse sfere. Una volta rimosso il concetto di Bene comune, sostituito con quello particolare, è chiaro che è l’economia a diventare l’elemento principale e a celebrare i suoi trionfi, come è oggi sotto gli occhi di tutti. Questo stravolgimento è comunque erroneo: nel caso specifico, la prosperità di Firenze, dovuta al turismo, dipende dalla messa a disposizione del pubblico dei suoi tesori di cultura del passato, per cui trasformare gli edifici storici in alberghi, sottraendoli alla fruizione comune, è come segare il ramo su cui si è seduti. Ma questo il consumismo, nella sua miopia, non lo capisce.
Massimo Cacciari ospite a Gli Incontri di Rete Uno
RSI Gli Incontri di Rete Uno 29.06.2024, 09:00