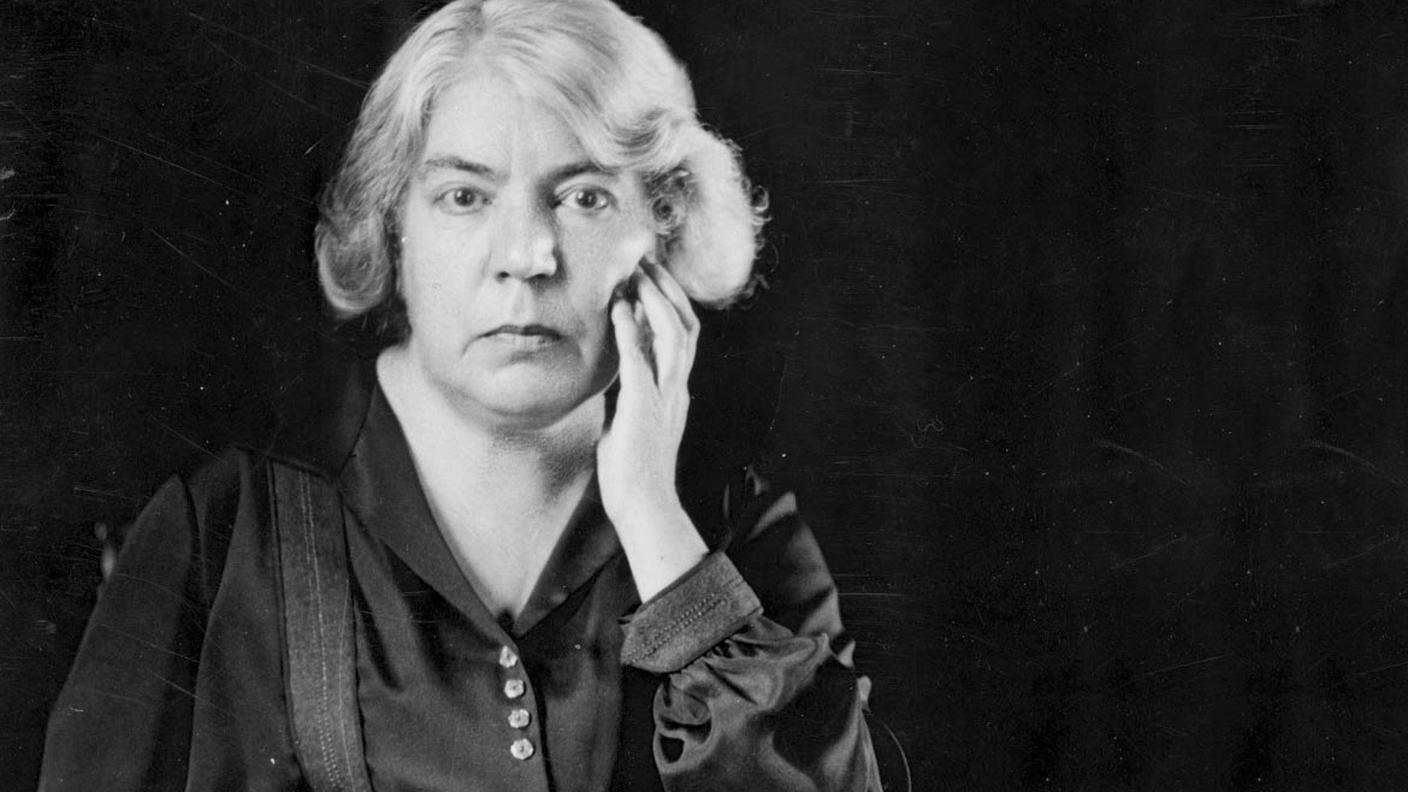Fiducia è una parola interessante. Tratta dal latino va a costituire innumerevoli concetti e vocaboli che qualificano le relazioni umane: da fede a confidente, da fiduciario a fidanzato, ogni volta assumendo sfumature e accezioni diverse. L’omologo vocabolo inglese, “trust”, ha acquisito nei secoli la medesima potenza simbolica, anche nelle sue contraddizioni. Fin dal famoso In God we trust, posto da subito sulle monete degli Stati Uniti (oggi sulle banconote da un dollaro) poi assunto a motto nazionale, bene interpreta la logica occidentale, che in fin dei conti ha trasformato la fede in Dio in fede in un sistema economico, politico e sociale centrato sull’individualismo liberista e liberale. Le conseguenze distorsive sono evidenti al punto che, nel mondo, il concetto di “antitrust” indica le modalità istituzionali con cui ci si difende da azioni e coalizioni economiche dominanti.
La rieducazione selvatica
Tra le righe 18.03.2025, 14:00
Contenuto audio
In questo singolare contesto, tuttavia, il concetto di fiducia continua (per ora) a esercitare nelle nostre vite e nelle nostre comunità un ruolo essenziale. Stratificato nei millenni, è posto a fondamento di ogni forma di relazione umana. Una sorta di mediazione fra i singoli, la comunità e il mondo circostante, secondo le aspirazioni, le abitudini, le credenze personali e le scelte da fare in funzione dei contesti. Da sempre, insomma, la fiducia (da dare e da ricevere) attiene all’individuo, alla sua libertà di pensiero ed è costitutiva della sua persona.
Una realtà che non consideriamo mai abbastanza. Intorno all’uomo e insieme all’uomo si è sviluppato un mondo intessuto di relazioni che si muove, vive, socializza, lavora, fa politica, fa economia, pensa religiosamente e progetta il futuro in virtù di ciò che chiamiamo fiducia. Se ogni mattina al momento di uscire di casa non avessimo la convinzione, sostanzialmente inconscia, che tutto ciò che consideriamo consuetudinario (pensiamo alla capacità di guida dei conducenti delle auto che incrociamo) continui a verificarsi secondo le nostre aspettative, probabilmente non metteremmo nemmeno un piede oltre la soglia. E anche il restare in poltrona si adombrerebbe di un’alea di rischio troppo elevata per poter essere accettata.
Lettera ai giovani, malgrado tutto
Laser 04.03.2025, 09:00
Contenuto audio
La fiducia è condizione essenziale per ogni nostro progetto o azione e quindi per la libera manifestazione della nostra persona. Allo stesso tempo, come abbiamo visto, in economia, ma anche in politica e nella religione, è manipolata al fine degli interessi di oligarchie, aziende, ideologie. Da poco pubblicato in italiano per Vita e Pensiero, un incisivo libro del filosofo svizzero Mark Hunyadi, Credere nella fiducia (pagine 120, euro 15) parte dai numerosi studi su questi temi per analizzare le conseguenze, sulle persone e sulle relazioni a tutti i livelli, generate dall’uso manipolatorio della fiducia messo in campo dalle logiche algoritmiche della tecnica digitale e dall’ideologia che le organizza.
Per Hunyadi intorno alla fiducia liberamente ricevuta e attribuita si costituisce il nostro rapporto col mondo e, come è naturale che sia per ogni nuovo avanzamento tecnologico, la «convivenza col digitale modifica questo habitat». La novità è che il digitale, ancor più con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, lo sta facendo in maniera rapida e pervasiva, sfruttando il coinvolgimento di ogni singolo individuo, pur lasciandolo sostanzialmente libero di scegliere. Con questo, ovviamente, non si dice niente di nuovo. Conosciamo bene quale sia il potere dei dati digitali, tanto che sono state sviluppate apposite norme a protezione della privacy. Ma il digitale ha un potere aggirante sostanzialmente incontrollabile e le conseguenze di questo potere non le consideriamo mai abbastanza. Soprattutto non le consideriamo in piena consapevolezza, altrimenti ci guarderemmo bene dall’alimentarle, concedendo la nostra fiducia con tanta superficialità e già sarebbero nati movimenti di resistenza e di protesta transnazionali.
Nei fatti ogni utente digitale considera poca cosa i dati che fornisce, ma alimentandosi di dati, le nuove tecnologie ne sono delle divoratrici universali, capaci di usarli per alimentare, a loro volta, con sempre maggiore precisione, la «soddisfazione libidica» degli utenti, generando sempre nuovi desideri, da soddisfare con sempre maggiore rapidità. Non solo desideri consumistici, ma anche relazionali, ideologici, istintuali, sentimentali, che conducono gli individui a collocarsi (con i loro stessi clic) in una sorta di bolla virtuale e autoreferenziale costituita da utenti che consumano, la pensano e si relazionano alla stessa maniera.
Vito Mancuso
Gli Incontri di Rete Uno 23.11.2024, 09:05
Contenuto audio
Sfruttati e contenti? Niente di male, forse, se serve a facilitare le tante incombenze quotidiane. Ma perché il fatto che questi sistemi algoritmici sfruttino per sfruttare sempre meglio non ci rende un po’ più avvertiti? Tanto più che generano potentati economici oligarchici, capaci di manipolazione politica in funzione della loro potenza, come ben ci mostrano i recenti fatti internazionali. Ma le vere domande che tendiamo a non farci sono altre, strettamente personali. Leggendo Hunyadi emergono limpidamente. La prima è strettamente logica e di principio: perché farsi sfruttare con tanta facilità e a volte fin nel proprio intimo, se poi tutti noi e la società in cui viviamo, siamo impegnati in battaglie contro ogni forma di asservimento e di sfruttamento: dell’ambiente, dei minori, delle donne, dei lavoratori, degli animali e via dicendo?
Altri interrogativi sorgono dal semplice ragionamento: il digitale globale trae la sua forza dalla rapida soddisfazione dei desideri in un contesto ideologico individualista per cui ogni desiderio diventa lecito e da soddisfare; l’individualismo identitario generato dalla moltiplicazione tecnologica dei diritti individuali e dei desideri da soddisfare è per sua natura autoreferenziale, prescinde dalla ricerca di fiducia sociale e di fiducia relazionale effettive, perché si muove in un habitat artificiale che le prevede implicitamente; i gruppi e le primazie identitarie che nascono in questo habitat hanno sempre meno bisogno della verità oggettiva, ma si alimentano di verità digitalmente artefatte. Basta frequentare i social e certi dibattiti televisivi, che si muovono con la stessa logica, per rendersene conto. Eppure, senza scomodare l’insegnamento evangelico, la storia recente ci ha dimostrato che non esiste libertà in contesti di verità mistificata. Così, le nostre storie personali, ci dicono che non esiste fiducia senza verità... E allora? Hunyadi non ha dubbi: è tempo di “resistenza” a questa sorta di divide et impera microdiffuso del pensiero digitale. Occorre tornare ostinatamente a ricostruire ciò che senza accorgercene abbiamo perduto: relazioni interpersonali di vita concreta, di comunicazione e di amore, cioè esperienze sociali fondate sulla fiducia.
“Credere nella fiducia”
Laser 18.03.2025, 09:00
Contenuto audio