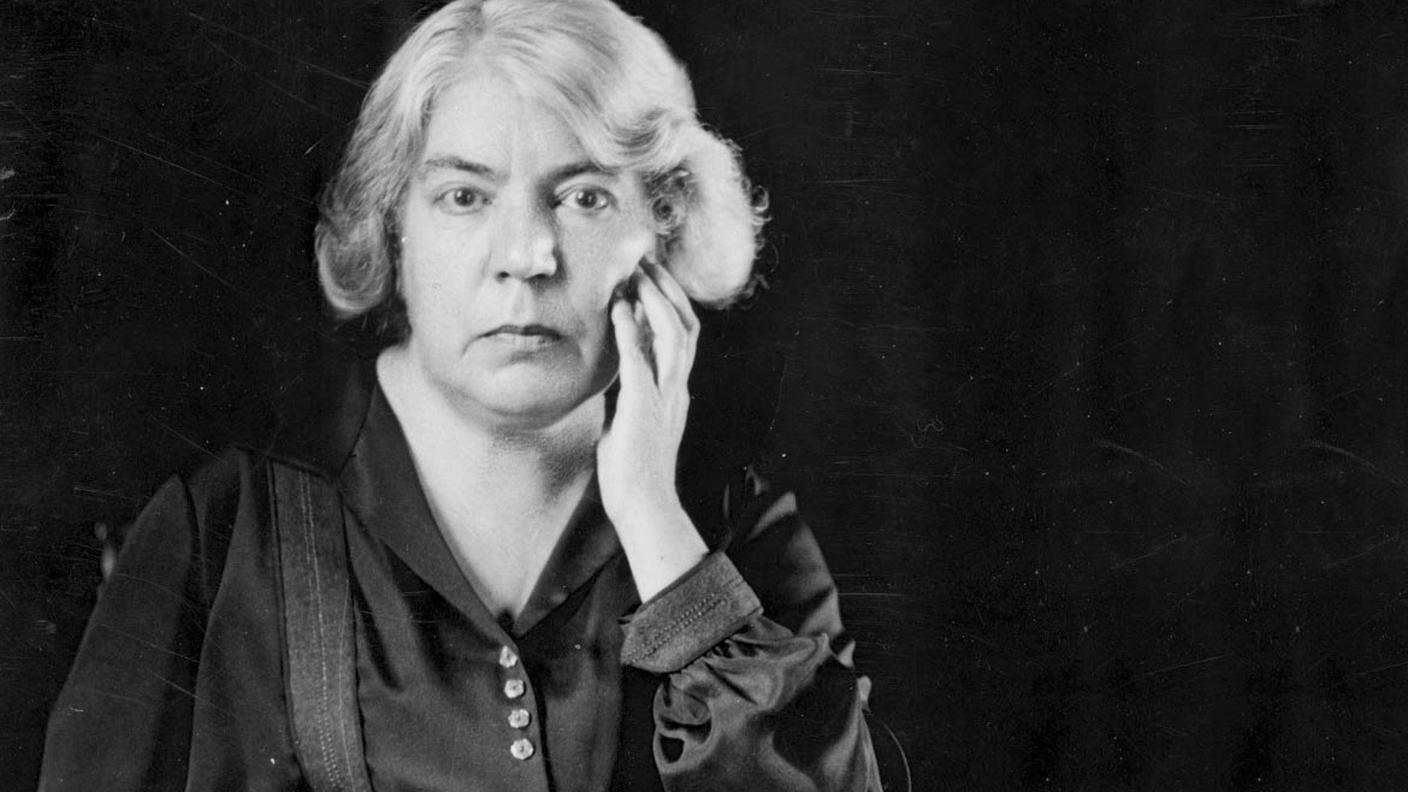Con la commemorazione dell’ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme, caratterizzata dalla benedizione e dalla processione coi rami di ulivo, è iniziata ieri, Domenica delle Palme, la Settimana Santa per i cristiani. Le relative celebrazioni entreranno invece nel vivo giovedì 17 aprile, nel cui pomeriggio avranno luogo la Messa in Coena Domini, la processione eucaristica verso la Cappella della Reposizione appositamente allestita e convenientemente ornata (il cosiddetto “sepolcro”), la spogliazione dell’altare, la rimozione delle croci. Ma non si può certo dimenticare come accanto ai riti liturgici del Triduo pasquale coesistano pur sempre, in varie parti del mondo, quelli con cui si esprimono da secoli la religiosità e la pietà popolare.
https://rsi.cue.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/La-Passione-per-le-strade-di-Mendrisio--1814585.html
Le molteplici manifestazioni, che accompagnano la solenne liturgia dell’Hebdomas Sancta latina e dellἉγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς bizantina, vedono infatti un forte ed emotivo coinvolgimento del popolo soprattutto nella contemplazione sia dei singoli episodi della passione di Cristo sia della sua morte. Si va così dalle visite alle sette chiese nelle Filippine alle sacre rappresentazioni in Messico, dalle grandiose processioni dei Pasos in Spagna – chiamati Tronos unicamente a Malaga – e in quasi tutti i Paesi latinoamericani a quelle dei Misteri o delle Vare in Italia (di cui 83 nella sola Sicilia). Lascito delle varie dominazioni ispaniche, tali manifestazioni presentano aspetti coreografici e spettacolari affini. Riprova ulteriore di quanto siano strettamente apparentate proprio a quelle spagnole, tra le quali sono universalmente note soprattutto le Settimane Sante di Siviglia – gemellata, fra l’altro, con quella di Caltanissetta –, Granada, Saragozza, Toledo, Valladolid, Zamora.
Ma a particolarmente commuovere in tali celebrazioni extraliturgiche è l’immagine di Maria che, vestita in gramaglie e recante nella mano destra un fazzoletto bianco oscillante al vento, è, pressoché ovunque, elemento caratterizzante delle processioni serotine del Venerdì Santo. Un’immagine, questa, a tal punto iconica ed evocativa da essere indicata con l’appellativo di Addolorata. Non è un caso che a essere chiamata in tal modo per antonomasia sia proprio Maria: colei, cioè, che il Venerdì Santo di quasi duemila anni fa, a differenza degli apostoli, fatta eccezione del solo Giovanni, stava «presso la croce» del figlio (Gv 19, 27), impietrita nel suo incredibile dolore di madre. Ed è il citato versetto giovanneo a costituire, in forma riadattata, l’incipit della celebre sequenza duecentesca che, tradizionalmente attribuita a Jacopone da Todi, viene cantata, inframmezzata ad altri inni e al lugubre suono delle marce funebri, durante quei cortei processionali.
Con lo Stabat Mater il devoto sentire attinge alte vette di intima e, al tempo stesso, corale commozione, che trova una sua peculiare espressione nei riti del Sabato Santo a Canosa di Puglia (BT). È intorno alle nove del mattino di detta ricorrenza – quest’anno cadrà il 19 aprile marzo –, che dalla chiesa cittadina dei Santi Francesco e Biagio si snoda la lunga teoria delle oltre trecento donne al seguito dell’imponente gruppo statuario in cartapesta e legno della Desolata. Disposte su più file e rigorosamente vestite a lutto, non poche delle quali scalze, hanno tutte il viso coperto da uno spesso velo nero e incedono, le braccia incrociate a catena, recitando il rosario e intonando le strofe dello Stava Maria dolente. Parafrasi tra le più belle e fortunate dello Stabat Mater, il cui autore, il dotto carmelitano Evasio Leone, ne pubblicò per la prima volta il testo nel 1798 in appendice alla sua traduzione delle Lamentazioni di Geremia adattate al gusto dell’italiana poesia, e della musica, e fornite d’osservazioni sul senso letterale, e spirituale (Torino, Stamperia Soffietti, pp. 75-79), questo raffinato Pianto di Maria dal gusto metastasiano viene qui eseguito secondo la struggente armonizzazione tardo-ottocentesca del clarinettista canosino Domenico Iannuzzi.
Il senso di struggimento e la forza compuntiva, promananti dalla visione delle donne velate che, cantando lo Stava Maria dolente sulle note della banda cittadina, “fanno compagnia” a Maria immersa nella sua ineguagliabile desolazione e afflizione per la morte di Gesù, è tale da colpire chiunque. In lei, plasticamente raffigurata nell’immagine della Desolata, appare simboleggiato il dolore di ogni donna e, in particolare, di ogni madre, che s’è vista morire un figlio o una figlia per malattia, incidenti vari o ingiustizie di ogni tipo. Che s’è vista morire un figlio o una figlia sotto le bombe, come le tante viventi in Ucraina, Palestina, Sudan e nei restanti cinquantatré Paesi segnati dagli orrori delle guerre. Che s’è vista morire un figlio o una figlia, affogati in mari percorsi su imbarcazioni di fortuna dopo aver lasciato per disperazione la terra natale. Che s’è vista morire un figlio o una figlia nell’inferno delle carceri e nella disumana abiezione dei benpensanti. Che s’è vista morire un figlio o una figlia, resasi la vita insopportabile, per mano propria o per altrui mano violenta.
A prescindere dalla fede di ognuno – la si può avere o meno, non è quanto qui interessa –, è impossibile non pensare a ognuna di queste donne e madri nel corso di una manifestazione come quella di Canosa o delle tante processioni con le immagini dell’Addolorata e del Cristo morto da un capo all’altro del mondo. Le loro lacrime, infatti, sono in un certo senso evocate da quelle di colei, che, avendole versate fuori Gerusalemme per un figlio amato, eppure ignominiosamente giustiziato con la morte di croce, ogni pianto di donna e di madre riassume, sintetizza, significa.

Il Papa a Piazza San Pietro
Telegiornale 13.04.2025, 12:30