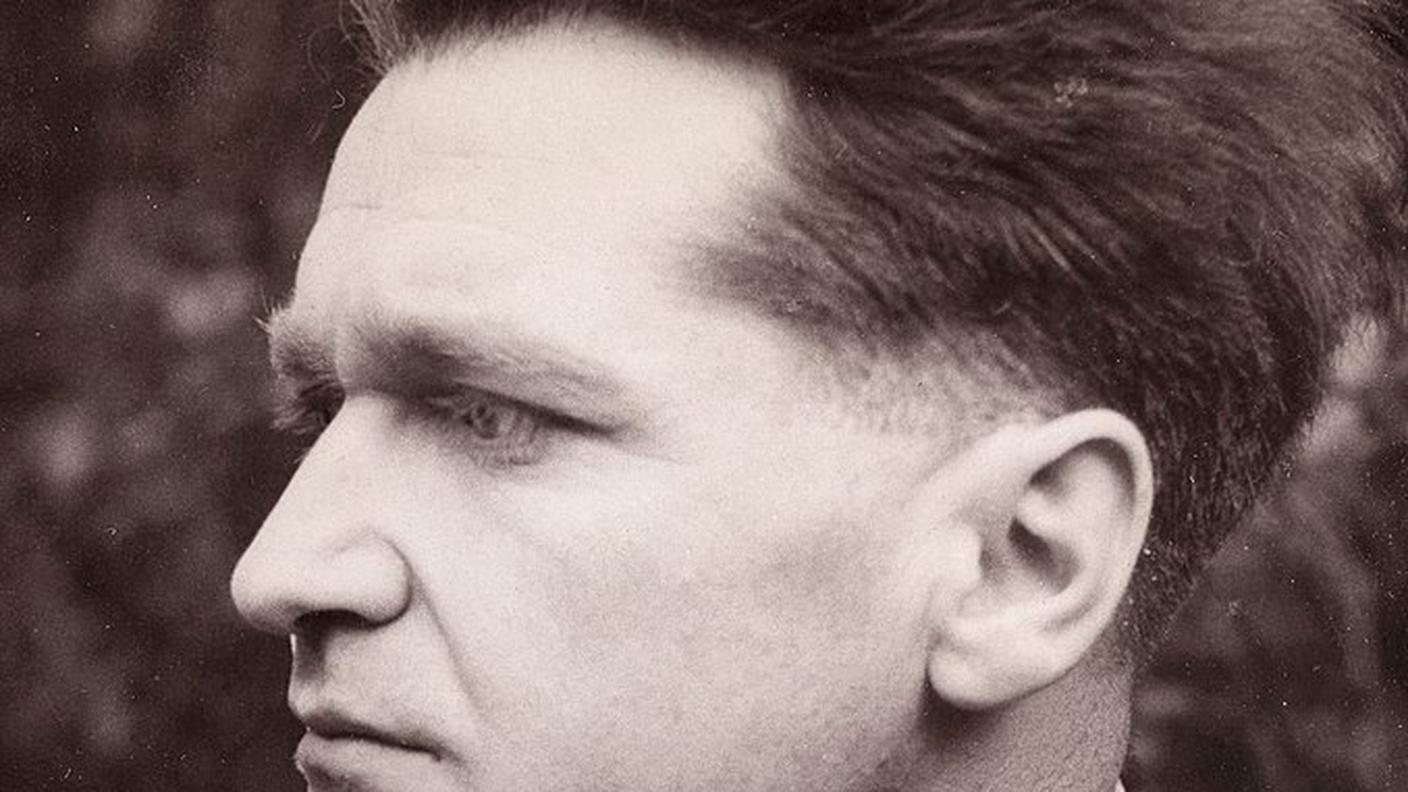«Solo un mostro può permettersi il lusso di vedere le cose così come sono, poiché il mostro è uscito dall’umano», scriveva il filosofo romeno Emil Cioran, pensatore notturno tormentato dall’insonnia e dal suo “demone”: la lucidità. Un dono e una maledizione insieme, riservata a pochi eletti–reietti, che rende la vita quasi intollerabile, priva di illusioni e di speranze. I più, sottolineava Cioran in un’intervista del 1973, non riescono a vedere le cose così come sono, nella loro intrinseca vacuità, e dunque agiscono: si cullano in ideali, fedi e miti; credono e sperano, mentono e si ingannano. «Io, poiché ritengo di aver visto, diciamo, in parte, le cose come sono, non ho agito più. Sono sempre rimasto ai margini degli atti», confidava a Christian Bussy nella citata intervista, dove pure dichiarava di amare Dostoevskij e di sentirsi in sintonia con l’uomo del “sottosuolo”.
L’autore di Al culmine della disperazione (1934) “è” il protagonista di Memorie dal sottosuolo (1864): l’uno, a ventidue anni, passeggia nelle strade deserte di Sibiu, in Transilvania, l’altro, ventiquattrenne, bazzica di notte sulla Prospettiva Nevskij, a San Pietroburgo. Coetanei ed affini, vagano per la città per cercare di sfuggire ai propri pensieri: «camminare vi impedisce di lambiccarvi con interrogativi senza risposta, mentre a letto si rimugina l’insolubile fino alla vertigine», scrive Cioran; «non passeggiavo affatto, bensì provavo innumerevoli tormenti, umiliazioni e travasi di bile», afferma l’uomo del sottosuolo. Entrambi fuggono inseguiti da una certezza: «essere troppo coscienti è una malattia, un’autentica, completa malattia». Gli uomini “d’azione”, come li definisce Dostoevskij, agiscono proprio perché sono ottusi e limitati e a causa della propria limitatezza credono che le loro azioni abbiano un senso; gli uomini “di pensiero”, al contrario, riflettono e, conseguentemente, non fanno nulla: «il diretto, legittimo, naturale frutto della coscienza è l’inerzia, ovvero il cosciente starsene seduto con le mani in mano».
Se l’uomo del sottosuolo si limita a notare la «pochezza» dei pensieri degli uomini d’azione, così come la «stupidità» delle loro occupazioni, Cioran arriva ad immaginare una vera e propria Apocalisse: qualora l’«inerzia consapevole» si impadronisse di tutti, compresa la «gente abbruttita che sgobba senza sapere un perché», nessuno più «si lascerebbe allettare da un’illusione o da un ideale». L’umanità tutta smetterebbe di adempiere ai suoi doveri e di soddisfare i suoi desideri, giacché li riterrebbe vani, e così tutti gli ideali sarebbero inutili, «le credenze bazzecole, l’arte una menzogna, e la filosofia uno scherzo». Sarebbe questo un mondo desiderabile? Quel che è certo è che «i più infelici sono coloro che non hanno diritto all’incoscienza». Questi sono forse più vicini alla verità, ma, nota l’alter ego dell’uomo del sottosuolo, «avere una coscienza sviluppata, sempre vigile, ridefinire senza tregua il proprio rapporto con il mondo» significa «essere perduti per la vita». «La conoscenza è una piaga, e la coscienza una ferita aperta nel cuore della vita», ammette infine Cioran in Insoddisfazione totale.
Chi è affetto da questa “malattia”, la lucida disillusione nei confronti di tutti gli ideali – di ordine morale, estetico, religioso e sociale – a cosa dovrebbe dunque aggrapparsi? «all’assurdo, all’inutilità assoluta, a qualcosa, cioè, che non ha alcuna consistenza, ma la cui finzione può creare un’illusione di vita», spiega Cioran, e sentenzia: «al culmine della disperazione, solo la passione dell’assurdo può rischiarare di una luce demoniaca il caos». La follia non sarebbe allora una fuga dalle miserie della vita? Affatto, perché, nota ancora il pensatore romeno, non c’è folle che non abbia sprazzi di lucidità. «Il presentimento della follia», scrive nell’omonimo frammento, «è reso più complesso dalla paura della lucidità nella follia, la paura dei momenti di ritorno in sé, in cui l’intuizione del disastro potrebbe essere così dolorosa da provocare una follia ancora più grave». Possiamo qui ravvisare la parabola di Don Chisciotte, personaggio letterario a cui Emil Cioran pare essere fortemente legato e a cui pure viene paragonato, nell’edizione Adelphi del 1998 di Al culmine della disperazione. Nel risvolto di copertina si legge infatti che l’autore, quale un «notturno Don Chisciotte», affronta «i giganteschi mulini a vento dell’essere universale e dell’esistenza umana menando fendenti che annientano il comune e borghese sentire con un sarcasmo ignaro del correttivo dell’ironia».
Una figura, quella dell’hidalgo mancego, che appare qua e là negli scritti di Cioran, da Finestra sul nulla (Adelphi 2022), opera postuma che raccoglie una serie di aforismi risalenti alla metà degli anni Quaranta, a Sommario di decomposizione (1949), di cui quest’anno ricorrono i 75 anni dalla pubblicazione. Don Chisciotte fa capolino in quattro passaggi di questi due testi, ove riprende quella riflessione su realismo e idealismo già accennata. «Il segreto della vita è riposto nella capacità di sperare», appunta Cioran, ed è per questo che «l’essere più benedetto mai concepito dall’immaginazione umana è sicuramente il Cavaliere dalla Triste Figura». Al contrario dell’antieroe cervantino, cocciuto demiurgo di mondi ideali, gli uomini sono incapaci sia di vedere la realtà qual è sia di ingannarsi stabilmente. «Le illusioni di cui non siamo stati capaci ci gettano giù per la china della dannazione», scrive Cioran in Finestra sul nulla. E ancora: «il bisogno di illusione e l’impossibilità di qualunque illusione ti trasformano in un Don Chisciotte cinico».
Qualche anno più avanti, nel suo Sommario di decomposizione, ribadirà la sua invidia per l’eroico sognatore: vivere significa «credere e sperare - mentire e mentirsi» e l’uomo non è che «polvere invaghita di fantasmi», perciò «la sua immagine assoluta, idealmente rassomigliante, si incarnerebbe in un Don Chisciotte visto da Eschilo»; idealmente, ribadisce Cioran, perché non tutti gli uomini riescono ad illudersi a tal punto: «la fecondità delle loro menzogne è variabile». Il mondo è un «mattatoio mediocre», dove «incrociare le braccia o sguainare la spada sono gesti egualmente vani»; imprese insensate e impossibili, giacché, «simili a Don Chisciotte sul letto di morte - al colmo della follia, estenuati -, abbiamo perduto la forza e l’illusione necessarie per affrontare le strade, i combattimenti e le sconfitte». Forse non a caso il cavaliere mancego muore nel momento stesso in cui rinuncia alla sua «follia lucidissima», come la definì Cesare Segre: fu saggio quando gridava a Sancho «pazzo sono, pazzo ho da essere» e fu folle quando dichiarò «io fui pazzo e ora rinsavisco». Chisciotte scelse di rinunciare all’inganno da lui stesso ordito ai danni degli stupidi baccellieri, curati e barbieri del suo tempo, mentre Cioran, «l’ultimo cavaliere del nulla», come lo definì Ulderico Munzi, non poté nemmeno accorgersi che la sua mente, una delle più lucide del nostro tempo, si spegneva. Era il 20 giugno del 1995: l’anti-profeta Cioran, annientato dalla malattia di Alzheimer, predisse la sua fine. «Per separarci dalle nostre pene, la nostra ultima risorsa è il delirio», scriveva nel frammento intitolato In onore della follia, dove pure si augurava che una «sorte benigna» lo liberasse dalla «ragione».
L’idiota
Alphaville 03.04.2024, 11:45