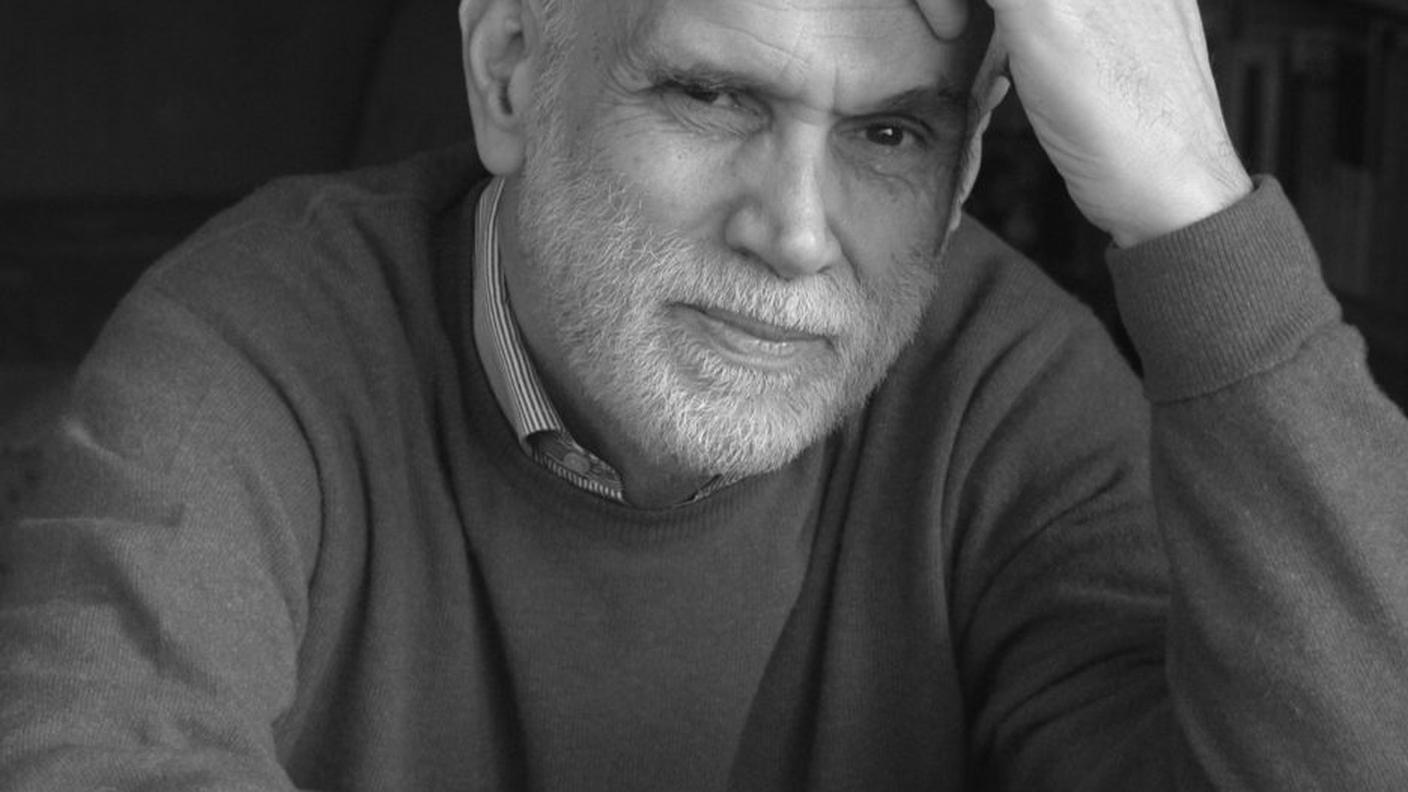La storia è impensabile a prescindere dalla geografia, diceva giustamente Immanuel Kant. Perché non c’è storia, e di conseguenza non c’è consapevolezza di sé stessi, «quando non si sappia in quale luogo una cosa sia accaduta e che cosa questo abbia comportato». Tuttavia, in ossequio a una sorta di regola della reciprocità, è ugualmente vero il contrario: anche la geografia è impensabile a prescindere dalla storia, se non altro perché le concrete decisioni politiche e gli eventi storici e culturali contribuiscono a ridisegnare e rimodellare, nel bene o nel male, la conformazione geografica di un paese.
Il giardino di Giorgio Bassani
RSI Cultura 05.01.2024, 09:02
Si tratta di un discorso che vale soprattutto per un paese come l’Italia, la cui “geografia” è quasi interamente il prodotto di eventi storici e di epoche culturali (laddove per “cultura” bisogna intendere la “Kultur” nel senso della parola tedesca, quindi la “civiltà” quale elemento che informa, sostanzia e caratterizza le concrete condizioni di vita) che hanno lasciato profonde tracce sul territorio. Una simile consapevolezza è stata espressa in maniera lucidissima e pressoché definitiva da uno dei grandi nomi della cultura italiana del Novecento, Carlo Levi, in un discorso tenuto al Senato della Repubblica nell’ottobre 1966. Levi era stato eletto senatore nel 1963 nella lista della Sinistra Indipendente e si era battuto per la tutela del territorio e dei beni culturali, soprattutto dopo una rovinosa frana che si era verificata ad Agrigento a causa del dilagante abusivismo edilizio. E’ alla sua iniziativa, tra l’altro, mossa anche dal ricordo del periodo di confino in Lucania nel 1935/36, che va ricondotta la salvezza dei “Sassi” di Matera.
Il paesaggio, aveva osservato Levi in occasione del disastro di Agrigento, non è mai un “semplice” paesaggio o uno sfondo intercambiabile: «E’ piuttosto la forma stessa della nostra vita, è il paesaggio della nostra esistenza, l’esistenza stessa in tutti i suoi aspetti, nella sua realtà, che è la su a storia. Non sono puri problemi estetici, né puri problemi giuridici, economici e sociali, ma tutti insieme, in una unità che sta prima delle determinazioni fino a un punto profondissimo, che è la ragione del nostro essere come popolo e come nazione civile». E’ anche da una simile consapevolezza, ai tempi tutt’altro che scontata e acquisita, che nel 1955 era nata “Italia Nostra”, con lo scopo specifico di salvaguardare i beni culturali, artistici e naturali. Tra i benemeriti e coraggiosi fondatori, oltre a Elena Croce e Umberto Zanotti Bianco, figurava anche Giorgio Bassani, che dal 1965 al 1980, nel periodo che segnò la sua massima popolarità come scrittore e romanziere, ne fu anche presidente.
Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi
RSI Cultura 26.08.2019, 12:20
Contenuto audio
Guardata inizialmente con diffidenza e sospetto dagli ambienti politici, dove veniva considerata una losca accolta di anime belle che si immischiavano in faccende (e soprattutto denari) altrui, negli anni della presidenza di Bassani l’associazione riuscì a ritagliarsi un ruolo e uno spazio ben preciso all’interno del dibattitto politico, sociale e culturale, dando vita a molte battaglie per la difesa e la tutela dell’ambiente e creando le basi per una coscienza ambientale (ma forse sarebbe più giusto dire civile) che in quegli anni era del tutto assente (l’Italia “civile” contro l’Italia “barbara”, secondo la penetrante definizione di Carlo Levi).
Per capire fino a che punto una simile coscienza fosse assente, può essere molto utile la lettura di un libro come “Roma fuggitiva” dello stesso Levi, con molte pagine dedicate ai cosiddetti “palazzinari” e alla speculazione edilizia che sul finire degli anni Cinquanta ha inferto molte e mai sanate ferite al paesaggio urbano della città (ha scritto Levi, profeticamente: «La più bella città del mondo rischia oggi di essere la più brutta tra le grandi città del mondo, pur contenendo il più gran numero di opere d’arte»). Erano del resto gli anni della “rapallizzazione” e poi della “riminizzazione” delle coste, depredate cementificate e sacrificate sull’altare del boom economico e del conseguente turismo di massa. I due termini, derivati dalle località balneari di Rapallo e Rimini, sono perfino entrati nel vocabolario della lingua italiana: «Cementificazione selvaggia o eccessivo sfruttamento turistico di un luogo, con conseguente degrado ambientale e paesaggistico dello stesso».
Riferendosi a “Italia Nostra” e operando una variazione sulle celebri parole dell’amatissimo Stendhal, Carlo Levi ne parlò come di un gruppo di «pochi benemeriti, quegli “happy few”, anzi -meglio- non quei pochi felici, ma quei pochi infelici che hanno, da soli, in questi anni, lottato e combattuto contro le forze che portavano e che portano alla perdita e alla degenerazione del nostro patrimonio artistico, e che con scarsi mezzi, con mezzi del tutto insufficienti, hanno condotto e portato innanzi una lotta di difesa spesso disperata, spesso ricca di delusioni, ma sempre nobile e coraggiosa». Se infatti l’Italia di oggi, malgrado quell’autentico abominio che furono all’epoca l’introduzione del credito fondiario e la cosiddetta “progettazione in concessione” riservata a taluni enti parassitari, e poi malgrado la corruzione, l’affarismo, la pretta ottusità, l’ignoranza, il familismo amorale e la sordida avidità di guadagno di intere generazioni di politicastri, non è ancora un paese completamente devastato sul piano ambientale e architettonico, il merito è da attribuirsi quasi esclusivamente a “Italia Nostra” e in particolare alla spiccata sensibilità, al gusto artistico e al coraggio civile di Giorgio Bassani.
Gli anni della presidenza di Bassani si possono interamente e proficuamente ripercorrere grazie a un libro davvero molto prezioso, “Italia da salvare”, che raccoglie tutti gli scritti che l’autore de “Il giardino dei Finzi-Contini”, proprio in qualità di presidente di “Italia Nostra”, ha espressamente dedicato alla salvaguardia artistica e ambientale della Penisola. Sprezzantemente (e ingiustamente) giudicato dagli avanguardisti dell’epoca un Proust in sedicesimo, tutto votato a una dolciastra e corriva rievocazione del “temps perdu” e comunque lontanissimo dalle miserie e contraddizioni della cosiddetta (e non meglio definibile) realtà “reale”, Bassani fu invece un presidente molto combattivo e talora apertamente polemico, che si scontrò a più riprese coi muri di gomma, i bizantinismi e il gattopardismo del potere politico (descritti in quegli stessi anni nel celebre quanto coraggioso film “Le mani sulla città”, di Francesco Rosi). Ma “Italia da salvare” è un libro imprescindibile anche per un altro motivo, perché permette di ricostruire la storia italiana del secondo dopoguerra a partire da un’angolatura molto particolare e in definitiva poco conosciuta, quella del patrimonio artistico, della sua difesa e tutela.
Lo spiega con estrema chiarezza lo stesso Bassani in un’intervista concessa nell’ottobre 1973 ad Alfredo Todisco (sincero ecologista della prima ora e scrittore di grande livello, oggi purtroppo dimenticato), quando osserva che l’Italia è «il Paese più importante al mondo, più dell’Inghilterra, della Francia, degli Stati Uniti. E questo perché l’Italia, mediante il pensiero critico rinascimentale, ha preparato il terreno al più grande trapasso culturale di tutti i tempi: il trapasso cioè dal mondo antico al mondo moderno. Senza il ripensamento critico del passato avvenuto nel Rinascimento, il mondo, che era antico, non sarebbe diventato moderno. Il patrimonio artistico italiano è la prova, la testimonianza puntuale, del processo spirituale che ha cambiato il profilo della civiltà. E’ per questo motivo che l’Italia, per me, ha un carattere “sacro”».
E’ precisamente in virtù di questa sacralità laica (la “sacertà” di Primo Levi) che Bassani, sempre nell’intervista con Todisco, spiega anche l’urgenza e la necessità di intervenire in difesa di un patrimonio unico al mondo: «Noi uscivamo dalla lotta antifascista, dalla Resistenza, e vedevamo la debolezza e la superficialità della democrazia italiana, e in più eravamo di fronte a quello che si stava preparando: il boom, la necessaria svolta industriale italiana. Il mondo industriale è di per sé democratico perché propone, postula un mondo di uguali, ma intuivamo proprio allora che già alla radice di questa democrazia, diciamo così industriale, c’era il pericolo che il nostro Paese fosse trasformato in un paese di oggetti, di consumatori e basta. E quindi alcuni di noi pensavano che avremmo dovuto resistere per una ventina d’anni, in attesa che una società migliore, più consapevole, non reificata, cominciasse ad esistere». Sono considerazioni non molto dissimili da quelle svolte da Carlo Levi circa un ventennio prima, nel 1950, ne “L’orologio”, un libro-meraviglia che oggi più che mai rimane uno strumento fondamentale per capire cosa sia stata l’Italia del secondo dopoguerra e la «struttura cancerosa» che l’ha in larga parte sfigurata.
La “condanna al brutto” (la definizione è sempre di Levi) è particolarmente devastante, perché implica e sottintende un “brutto” che «è brutto anche moralmente» e al quale è molto difficile sottrarsi. Malgrado le molte battaglie combattute e vinte per la tutela del territorio, l’attesa di una società migliore, più consapevole, non reificata e non ridotta a una massa informe di consumatori istupiditi dalle ubriacature pubblicitarie sembra ormai destinata a rimanere tale. Tutto questo non toglie che “Italia Nostra” sia riuscita a diffondere una consapevolezza che Bassani ha espresso in uno scritto del 1972, intitolato “Fragilità del territorio italiano”, con alcune considerazioni che hanno quasi il tono del manifesto programmatico: «La natura e la storia, in Italia, sono così tanto apparentate tra loro che sarebbe impossibile separarle. Il territorio nella sua configurazione naturale è praticamente inesistente; nel tempo, in tutto il Paese, la natura è stata rimodellata o quantomeno segnata dal lavoro dell’uomo. Questo equilibrio si è manifestato come tale solo nel momento in cui è iniziata la sua distruzione, prima sporadica e poi sistematica. Questa distruzione è cominciata nel decennio scorso in concomitanza con lo sviluppo industriale».
“Visitate l’Italia prima che gli Italiani la distruggano”, recitava uno slogan turistico, opportunamente ricordato da Bassani, in voga negli Stati Uniti negli anni Settanta. La questione che percorre le pagine di “Italia da salvare” può essere riassunta in un semplice e duplice “perché?”. Perché l’Italia non riesce a preservare adeguatamente il proprio patrimonio artistico e culturale? Perché è necessaria l’esistenza di un’associazione come “Italia Nostra”? Si potrebbe in verità aggiungere un terzo quesito, sollevato pressappoco negli stessi anni da Ennio Flaiano: Perché l’Italia ha la tendenza a «conservare con cura i propri escrementi»? Sollecitato da una puntuale domanda di Todisco, che gli chiede di riflettere sulla fine dell’umanesimo e sui guasti (attualissimi e sempre più irreparabili) di «una democrazia più nominale che reale», Bassani fornisce una risposta che riassume in poche righe interi decenni di miseria italiana, riprendendo il tema dell’“eterno fascismo” -definito da Piero Gobetti l’autentica “autobiografia della nazione”- e individuando le cause del malaffare e della cancrena che hanno fatto del Belpaese una repubblica dei datteri, o quasi.
L’Italia, diceva Carlo Levi, non ha più «un volto che ci somiglia». Ma allora una simile Italia può ancora essere salvata? E’ lecito nutrire più di un dubbio. Osserva infatti Bassani: «Il male più serio di cui soffre il nostro paese è l’inconsistenza dello Stato, non più risorto dal colpo mortale vibratogli dal fascismo nel 1922. I cattolici, protagonisti principali del potere dalla fine della guerra, non hanno avuto alcun interesse a riedificare un ente laico a cui essi non credono. I comunisti, dal canto loro, hanno osteggiato lo Stato per ragioni strategiche: hanno sempre visto in esso, non nei partiti, il vero strumento di una “prise du pouvoir” di stampo termidoriano. Morale: in Italia noi abbiamo governanti (in caccia di voti e di finanziamenti), ma non abbiamo uno Stato. Grazie a questo vuoto, il Paese è tutto diviso in baronie anarchiche, corporative, volte al loro interesse “particulare”». La conclusione, allora come oggi, non lascia scampo: «Enti locali, gruppi industriali, enti di gestione, sindacati, partiti tirano tutti l’acqua al proprio mulino: mercanteggiano e si vendono l’Italia a pezzi».
E’ il paese che Carlo Levi, nel 1964, con parole che interi decenni dopo sono sempre più profetiche, aveva magistralmente sintetizzato in questi termini: «Si tratta di un problema che riguarda, attraverso il patrimonio dell’arte e del paesaggio del nostro paese, l’esistenza stessa di ciascuno, l’esistenza stessa di uomini che ciascuno deve sentire in sé, che riguarda per ciascuno la sua individuazione storica, di essere cioè uomini con un passato e un futuro vivo nell’oggi, non dei puri esseri inesistenti in un presente senza forma». Sono parole verissime e piene di speranza in un’Italia ancora salvabile. Ma forse -se mai possibile- sono ancora più vere, perché prive di speranza (e in fondo maggiormente profetiche), le considerazioni svolte un anno prima da Ennio Flaiano al cospetto della sistematica devastazione della costa laziale, una delle tante, troppe cifre simboliche dell’Italia (allora e oggi) insalvabile: «La desolazione di certi luoghi si fa insostenibile. Spesso, l’idea di vivere in un paese che si va sgretolando nella laidezza ci avvilisce».