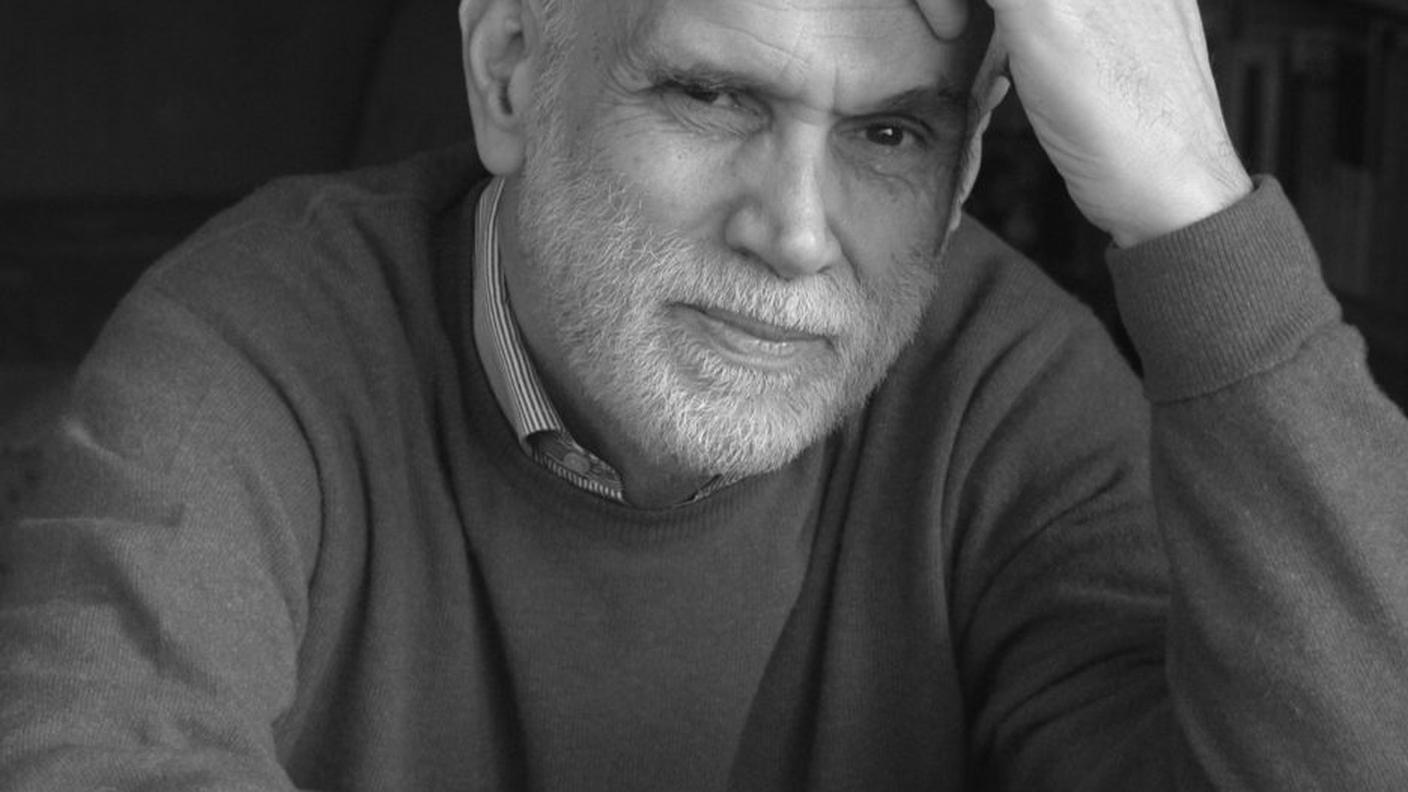In un certo senso aveva ragione Céline, quando affermava che di scrittori che abbiano “uno stile” ne nascono solo due o tre ogni secolo. E naturalmente, rimarcando che tutto il resto “non lo interessava”, uno di quei due o tre scrittori riteneva con fierezza fosse lui stesso.
Nessun dubbio: Céline è una delle rare voci che ha sconvolto la narrazione tradizionale da capo a piedi. E sicuramente è colui che più di molti altri ci ha ricordato come “narrare storie” non significhi necessariamente, anzi non significhi affatto, fare letteratura. Le storie essendo, secondo le sue stesse parole, disponibili “in ogni angolo della vita, in ogni commissariato, in ogni tribunale” – mentre la letteratura si presenta solo se accompagnata dallo stile e innervata dal sacrificio presupposto dallo stile.
Eppure non bisogna dimenticare che “assolutizzare” lo stile è un atteggiamento a suo modo fanatico. Non soltanto perché ridurre a due o tre scrittori per secolo il Pantheon degli autori provvisti di stile ha qualcosa di ideologicamente esaltato – il solo Novecento ne conta con ogni evidenza decine e decine – ma perché in letteratura lo stile non è mai dato una volta per tutte. E spesso sfugge dalla pagina anche degli scrittori che ne sono più solidamente provvisti. Certo, Hemingway ha uno stile, Céline ha uno stile, Garcia Marquez ha uno stile, Roth ha uno stile, ma non sempre tutto ciò che scrivono ne è pervaso, non sempre lo stile torna sotto il loro pieno controllo.
In questo senso parlare di Salman Rushdie significa in qualche misura domandarsi: quale marchio stilistico connota la sua prosa per poter dire che nessuno prima di lui ha scritto come lui? E in che senso, se proprio dobbiamo indicare un Olimpo dei pochi autori contemporanei provvisti di stile, egli appartiene al ristretto cenacolo dei maestri?
Tanto per cominciare facciamo astrazione dal “caso Rushdie”, dalla famigerata fatwa khomeinista che gli ha avvelenato la vita, da tutto ciò che egli rappresenta come “fenomeno” massmediatico. Una circostanza che sicuramente ha favorito la conoscenza delle sue opere, ma che con lo specifico narrativo di cui ci stiamo occupando non ha infine nulla a che fare.
Poiché Rushdie non è eminentemente grande perché ha osato denigrare la teocrazia iraniana o ha messo in scena personaggi e situazioni che solo un enorme coraggio può permettere di rappresentare a quel modo. Ma in primo luogo perché qualsiasi cosa egli abbia scritto, a partire da quel capolavoro che fu I figli della mezzanotte, fu scritto secondo timbri, ritmi, strutture e lessici che in una certa misura non hanno precedenti in nessun autore del suo tempo. E perché – come è tipico dei grandi artisti, in ogni ambito del mondo creativo – egli ha saputo inaugurare ciò che noi non abbiamo oggi difficoltà a definire “rushdiano”.
E che cos’è rushdiano, se prescindiamo dall’associare il termine al penoso “caso” che ne ha funestato l’esistenza? Rushdiano è quel registro narrativo attraverso il quale le modalità classiche della narrativa orale, soprattutto di quella comico-grottesca, si congiungono al romanzo picaresco inaugurato da Cervantes e al romanzo storico promosso tra i primi da Walter Scott.
Implica questo che rushdiano sarebbe un pastiche di generi, un calderone ribollente di modalità e stili già praticati in precedenza da altri? No, un approccio siffatto sarebbe assai riduttivo. In realtà Rushdie è Rushdie – l’opera di Rushdie è inconfondibilmente l’opera di Rushdie – perché in ogni sua pagina vibra l’assoluta originalità di chi tradizione e classicità, modernità e contemporaneità ha perfettamente interiorizzato e metamorfizzato in una propria lingua, in un proprio timbro e in una propria identità narrativa. Ovverossia, in un proprio stile.
Leggere Rushdie significa in effetti muoversi in un confine sottilissimo, eternamente intercambiabile, tra realtà e surrealtà, tra fedeltà alla Storia e sua caricaturizzazione, tra problematiche politiche, religiose e sociali e loro iperbolizzazione, tra adesione al tempo reale e sua dilatazione fantastica. Per cui non c’è una sola pagina, un solo libro, una sola tra le mille storie da lui narrate in cui non si abbia l’impressione che la letteratura non irrida il reale, non lo ridimensioni, non lo riconduca – soprattutto quanto assume le vesti o le sembianze del potere – alla sua dimensione comica o ridicola.
Parlare di “stile” nel suo caso significa di conseguenza parlare eminentemente di due aspetti altrettanto cruciali: la capacità di farsi beffe dell’ufficialità e della magniloquenza della Storia – tramutando, per così dire, ogni Storia maiuscola in una infinità di storie teatralizzate e satirizzate minuscole – e la sua straordinaria capacità di animare il linguaggio delle più intense coloriture che si possano immaginare nella cosiddetta “scrittura barocca”. Non però facendone uno stampino, come si suol dire, ma rinnovando di libro in libro la loro effervescenza.
Leggere uno qualsiasi dei romanzi di Rushdie non è dunque solo divertente, educativo nel senso della nostra “rivalsa di sudditi” nei confronti del potere istituito, ma è anche un affondo in quel mondo libero, profondamente libero, che costituisce la sua più intima poetica. Un mondo che non vuole legami, vincoli, obblighi, fanatismi, prigioni e carcerieri, ma solo quell’insondabile bellezza della libertà incondizionata che ogni suo paragrafo ci restituisce nel più carnevalesco e parossistico modus narrandi che si possa incontrare ai nostri giorni.
I grandi romanzi anglo-indiani: R.K. Narayan e Salman Rushdie
Laser 23.02.2021, 09:00
Contenuto audio