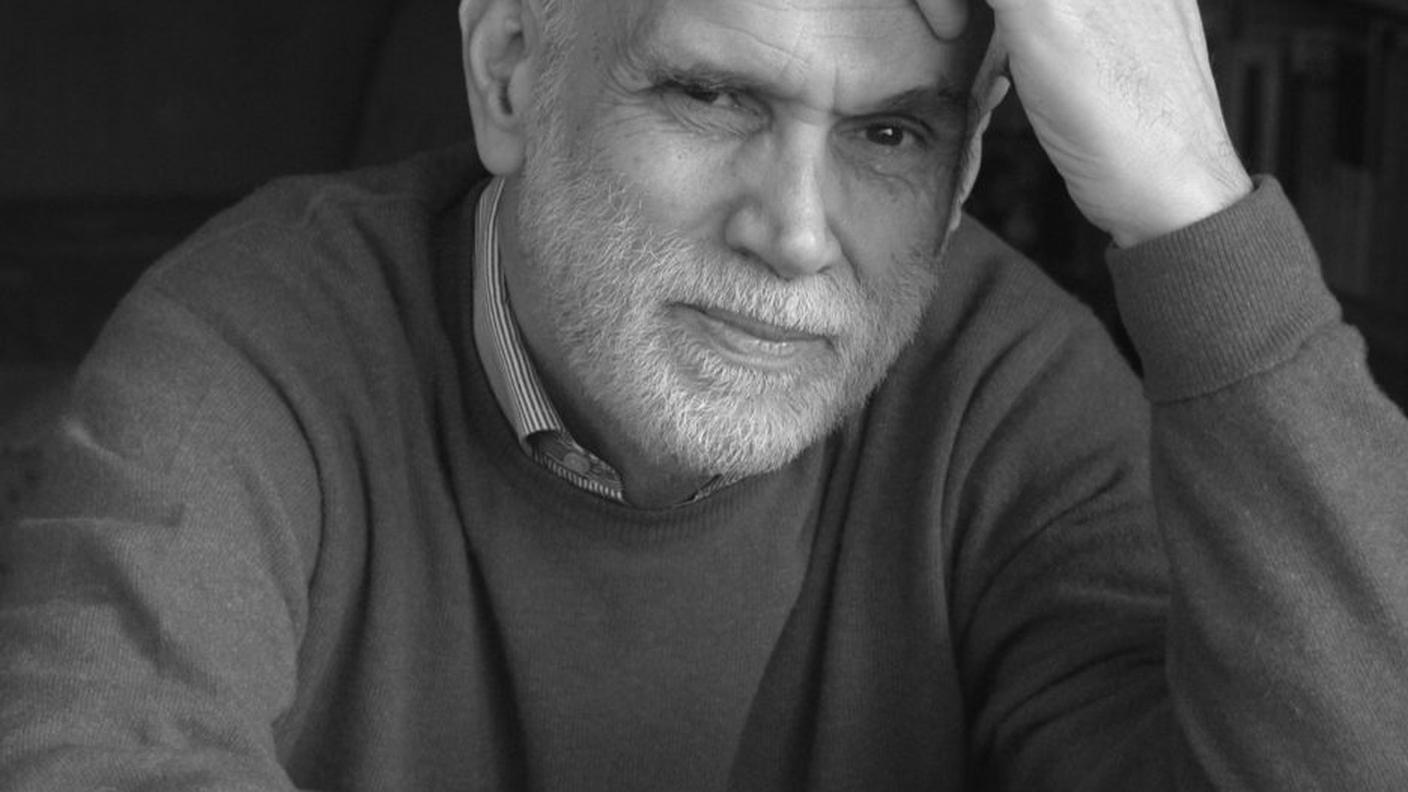Tommaso Landolfi (9 agosto 1908 – 8 luglio 1979) guida la fila dei grandi rimossi della letteratura italiana del Novecento. E questo nonostante la critica abbia fatto di tutto per sostenerlo, coronandolo di premi e riconoscimenti, sia in vita che post mortem. Ma, come disse Edoardo Sanguineti, autore di finissime esegesi landolfiane: “tutto è stato inutile. Uno come Gadda, che pure è molto più difficile, siamo riusciti a imporlo, abbiamo convinto il pubblico che è indispensabile leggerlo. Con Landolfi no, non ce l'abbiamo fatta". E il perché lo spiega ancora il noto esponente della neoavanguardia: "il vero problema di Landolfi con il grande pubblico è che la sua scrittura non è appassionante. Nel senso che non è la scrittura del romanzo, fluviale, abbandonata. Tutte le pagine del suo diarismo testimoniano di questa impossibilità di lasciarsi andare, di cedere a una parola diretta, incontrollata. C'è un inciampare nel dire, la frase appena detta è subito chiosata da se stessa e sottolinea una forte innaturalità dello scrivere. L' imbarazzo nasce proprio da qui: dal dover spiegare un'estetica che spesso occulta la necessità del dire. Il pubblico non ama simili occultamenti, e sospetta che dietro non ci sia nulla. Legge Dostoevskij e capisce che all'ombra di quei romanzi vive un personaggio tumultuoso: ma dietro Landolfi avverte la presenza di una paralisi, e ne ha paura".
Ecco smascherata la verità: Landolfi fa paura. Maneggiare i suoi libri è come maneggiare i libri di un personaggio malato, un personaggio che sembra nascondere la più buia delle nevrosi. Leggendo Landolfi, ad ogni riga, sorge il sospetto di avere a che fare con un letterato che disdegna la vita e che si trastulla a tessere un abile e funesto raggiro, una preziosa e perniciosa finzione.
Questo sospetto diventa ancor più inquietante se alla lettura si accompagna la visualizzazione dell’immagine che Landolfi scelse di accollarsi e di portarsi appresso nelle apparizioni pubbliche. Ovvero l’immagine di un personaggio freddo, pallido, beffardo, avvolto dentro un'aura di dandismo spettrale. Un personaggio irriducibilmente dedito al gioco d'azzardo, sarcastico nelle sue esternazioni, volubile nei suoi sentimenti, altalenante nel suo moto di incursioni e fughe dentro la realtà, infine misterioso nel suo rintanarsi nella casa-torre di Pico.
Gianfranco Contini, nel 1968, francobollò Landolfi con queste parole: "è il solo scrittore che abbia dedicato una minuziosa cura degna di un dandy romantico (come Byron o Baudelaire) alla costruzione del proprio personaggio: un personaggio notturno, di eccezionalità stravagante, dissipatore e inveterato giocatore; un personaggio che viene introdotto e anzi ostentato costantemente nell'opera... con condimenti di grottesco russo (nella scia dei Racconti di Pietroburgo di Gogol) e di fantasia surrealista, o più esattamente dei lontani precursori del surrealismo (dal marchese di Sade a Lautréamont)".
Vita, scrittura e fortuna critica
RSI Cultura 13.06.2019, 09:55
Contenuto audio
A questa immagine di scrittore notturno e stravagante hanno concorso tanto la vita quanto la scrittura. Iniziamo dagli aneddoti che animano la sua biografia: Tommaso, Tom per gli amici delle Giubbe Rosse (Renato Poggioli, Carlo Bo, Eugenio Montale, Mario Luzi, Carlo Emilio Gadda... e tutto il meglio della stagione fiorentina), era visto come un uomo scontento e nauseato. Aveva e coltivava il disgusto, lo schifo della vita, ch’egli descriveva come qualcosa di molle, untuoso, appiccicaticcio, insensato, inutile e compromissorio. Contro questa realtà, Landolfi eresse una difesa ludica, ovvero decise di prendersene gioco, in modo irriverente, dileggiando gli amici (Luzi racconta del rancore di Gadda, quando seppe che Landolfi l'aveva definito “professore impazzito”) e votandosi all’azzardo, pur sapendo quanto esso fosse capriccioso e bendato (ma non per questo meno vero e allettante della vita stessa).
E l’azzardo non fu solo a perdere, anzi. Landolfi vinse grandi somme ai casinò, somme che poi scialacquò in vestiti, scarpe, cappelli, guanti, sciarpe, camicie, cappotti e cappottini di primissima qualità. Per non parlare poi dell’altra sua follia: l’amore per le motociclette. Per chi volesse approfondire la vita del dandy in cachemire che svolazzava per la via Cassia sulla sua rombante Northon si consiglia la lettura dell’amorevole biografia che la figlia Idolina ha inserito nel primo volume dell'opera omnia da lei curata (Tommaso Landolfi, Opere 1937-1959, Rizzoli): quarantacinque pagine in cui la vita di Tommaso viene descritta in dettaglio, sulla scorta di tracce minime: una cartolina, una ricevuta, un biglietto ferroviario. "L'ho fatto per sfatare troppe cose riferite senza ragione su di lui", ha detto Idolina all’indomani della pubblicazione. "Per mostrare come la sua leggenda sia l'invenzione di gente gretta e meschina che non riesce a non invidiare e a non giudicare assurdo uno che coltiva la libertà di perdere enormi cifre al gioco, di non comprarsi una casa, di non avere ideali di carriera, di fama, di denaro. Dico la gente, ma penso anche a tutti i suoi amici accademici, gente strapagata per scrivere due righe".
Tanto elusiva, dandy e sconcertante è stata la vita di Landolfi, quanto misteriosa, barocca e folgorante è stata la sua scrittura. Anche qui, tra le pagine dei suoi testi, Tommaso non fece altro che divertirsi e giocare con le parole. Arte come gioco, come finzione, come artificio. Del resto, Landolfi apparteneva d’istinto alla razza dei Borges e dei Calvino, ovvero di coloro che hanno cercato di giustapporre alla complessità del reale un’uguale se non maggiore complessità della finzione, celebrando la superiorità morale e conoscitiva di quest’ultima.
Le traduzioni, l'opera teatrale e lo slavismo
RSI Cultura 13.06.2019, 10:02
Contenuto audio
Landolfi con la lingua sapeva fare di tutto: riprodurre mimeticamente la sintassi della lingua parlata oppure rivitalizzare, con piglio neoavanguardistico, le parole più arcaiche della lingua italiana (uno dei Racconti impossibili è tutto costruito con vocaboli desueti). Mirabile traduttore dal russo, spirito scettico e inquieto di fronte a una realtà sfuggente e crudele, Landolfi fu un cesellatore del linguaggio (linguaggio con cui condivideva un senso di fallimento e sconfitta: tanto Landolfi quanto il suo linguaggio non hanno mai voluto afferrare la realtà, consapevoli di quanto essa fosse evanescente, arbitraria, costantemente in balia del caso e della morte).
Dai racconti onirico-grotteschi di gioventù (raccolti nei volumi Dialogo dei massimi sistemi, il Mar delle blatte e altre storie, La spada) alla trilogia fantastica della maturità (La pietra lunare, Racconto d'autunno e Cancroregina), dai racconti fantastici degli ultimi anni di vita ai tre diari, vette della sua arte (La bière du pécheur, Rien va, Des mois), l'opera landolfiana è stata etichettata in vari modi: «l’opera di un ottocentista eccentrico in ritardo», «di un gotico kafkiano», «di un manierista stravagante dall’intelligenza abbrunata e contorta». Ma forse la definizione che meglio lo contraddistingue è quella di «inesausto sperimentatore», di scrittore che si volge alla scrittura consapevole della sua impotenza, della sua mancanza, del suo carattere residuale, e proprio per questo vi si dispone indagandone tutto il suo potenziale creativo e generativo.
In questo senso la voce di Landolfi (beffarda, lamentosa, immorale e sarcastica) rivela l’impossibilità di una parola totalizzante e risolutiva, e smaschera il nulla di un’esistenza straziata e mai pienamente vissuta. Tanto che si potrebbe dire che l’intera produzione landolfiana graviti attorno a due temi fondamentali: l'evanescenza della realtà e la paralisi della parola. Due temi che apparentano Landolfi da un lato al surrealismo (con cui condivide l’assunto dell’illusorietà del reale) dall’altro con Kafka (con cui spartisce i temi dell’assurdo e del caso), e che lo pongono come precursore di Borges (lo scrittore argentino che farà del tema dal caso, dall'imprevedibilità fantastica e labirintica del mondo, l’asse portante della sua opera narrativa).