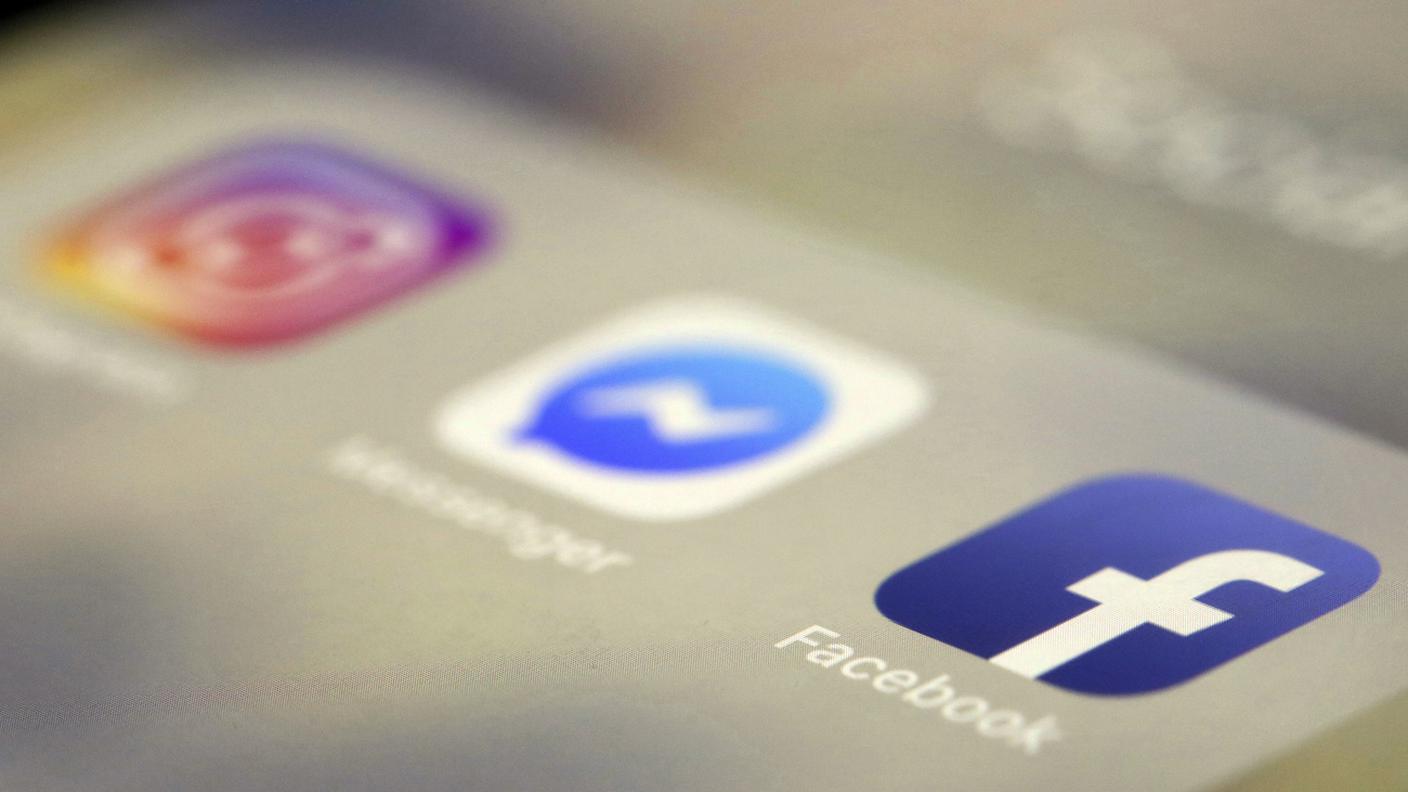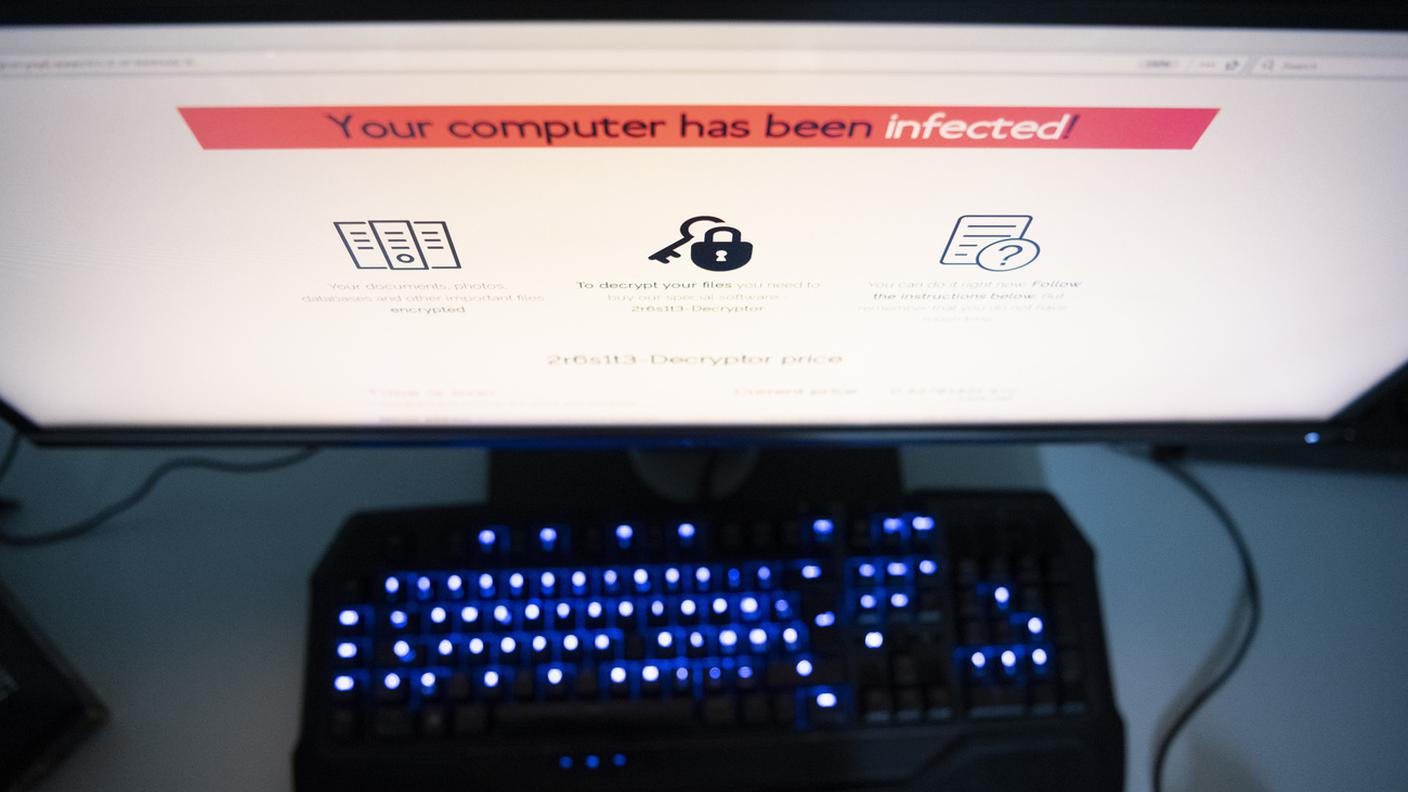A metà degli anni ‘90, mentre i telefoni cellulari stavano conquistando il mondo, Beat Hasler decise di chiamarsi fuori. Quarantenne all’epoca, Hasler era il direttore del settore giovanile del club di calcio locale a Langenthal. “Era una cosa importante, 300 ragazzi. I genitori volevano sempre contattarmi per qualcosa. Sapevo che se avessi preso un cellulare, non avrei mai avuto pace. Così non l’ho preso” spiega a SWI swissinfo.ch.
Per tre decenni, mentre i Nokia 3210 diventavano iPhone, Hasler ha resistito. Né il suo lavoro nel settore bancario e amministrativo, né i suoi amici o la famiglia sono riusciti a distoglierlo dal suo obiettivo: l’autodeterminazione e la libertà dalla “assurda pretesa di essere sempre disponibili”.
Nel 2025, Hasler fa parte di una specie rara: persone che preferiscono vivere il più possibile offline, o che almeno non vogliono portarsi il mondo online in tasca.
Stress sul lavoro, “sciocchezze” online
La posizione di Hasler non è apertamente politica. Tra i dibattiti più ampi in Svizzera sul diritto di rimanere offline, ad esempio, lui non direbbe necessariamente che la vita analogica debba essere protetta come tale, “sarebbe un po’ un’utopia”.
A livello personale, non ha avuto molti problemi negli ultimi 30 anni. Un’eccezione: per evitare il banking online, sta attualmente passando a una filiale regionale più piccola con servizio clienti di persona. Tuttavia, in generale, “è sempre riuscito a cavarsela bene”.
Hasler, che ora ha 70 anni ed è in pensione, si preoccupa comunque di come alcuni aspetti della digitalizzazione influenzino la società. Un esempio è il maggiore stress sul lavoro. Con le email in tasca, pensa ci sia una pressione a essere costantemente produttivi.
Un altro esempio è la quantità di tempo che le persone trascorrono sui social media, dove ritiene ci sia una quantità enorme di sciocchezze. “L’autocontrollo è crollato. Prima di WhatsApp o dei social media, dovevi insultare qualcuno direttamente o esprimere la tua opinione. Quando si può semplicemente scriverlo, le inibizioni scompaiono”. Per le notizie e gli affari correnti, Hasler preferisce i suoi due quotidiani.
Hasler, che si occupa regolarmente dei suoi tre nipoti, si preoccupa che i giovani che sono costantemente online rischiano di essere risucchiati in un “mondo parallelo”. Lo inquieta che, mentre gran parte di ciò che è scritto online “non è realtà”, disinformazione, fantasia e deepfake possano diventare normali dopo una certa esposizione. È quindi favorevole a regole per proteggere i bambini: “Ad esempio, vietare gli smartphone nelle scuole o stabilire un limite di età di 16 anni per possederne uno”.
Su questo punto, Hasler non è solo: secondo un sondaggio dello scorso anno, l’82% degli svizzeri è favorevole al divieto degli smartphone nelle scuole. Il Consiglio federale si è detto aperto alla possibilità di vietare i social media a chi ha meno di 16 anni, sull’esempio dell’Australia.
https://rsi.cue.rsi.ch/info/svizzera/La-libert%C3%A0-dell%E2%80%99algoritmo-il-nodo-irrisolto-dei-social--2504017.html
In generale, mentre Hasler ritiene che le sue opinioni siano marginali in una società ossessionata dalla tecnologia, potrebbero non essere così marginali come pensa.
Per quanto riguarda i bambini, si discute in tutto in tutto il mondo dell’influenza degli smartphone sulla salute mentale e anche l’OMS ha espresso i suoi timori. Inoltre, il ruolo dei social media e dell’intelligenza artificiale nel favorire la disinformazione e il populismo è una preoccupazione comune nelle democrazie. Anche perché l’accesso a internet tramite dispositivi mobili è praticamente universale.
Connessi al mondo naturale
La fuga dalla connessione costante ha portato a un aumento delle vendite dei “dumb phone”, telefoni cellulari con funzionalità essenziali, limitate a chiamate, messaggio e, a volte, qualche altra funzione basilare.
Tra chi ne ha acquistato uno c’è Bettina Dyttrich, una giornalista della Wochenzeitung. La 45enne spiega che non le è mai piaciuto parlare al telefono, nemmeno da bambina. In seguito, si è resa conto che per lei era importante non essere costantemente raggiungibile. Alla fine, pochi anni fa, ha fatto una “concessione” agli amici: un semplice telefono offline.
Dyttrich esclude però lo smartphone e vede l’arrivo dei dispositivi digitali portatili come una rivoluzione più grande della stressa nascita del web a cui non vuole prendere parte. “Per me, internet significa andare a casa o in ufficio, sedersi e accendere il computer”, dice. “Con questo posso convivere. Ciò con cui non posso convivere è quando è sull’autobus, in camera da letto, ovunque”.
Come persona “nervosa”, Dyttrich afferma che il costante flusso di informazioni può essere destabilizzante. Per sentirsi equilibrata e svolgere il suo lavoro, deve essere in grado di concentrarsi ed essere in contatto con la natura. “Ho bisogno di acqua, alberi, montagne, animali, persone. Non capisco come gli altri possano accontentarsi di un’immagine online di queste cose” dice.
E come Hasler, i cui istinti privati informano le sue opinioni sulla tecnologia e la società, i timori di Dyttrich non sono solo personali. Innanzitutto, si preoccupa delle conseguenze della perdita di contatto delle persone con il mondo naturale. La biodiversità si sta riducendo, eppure allo stesso tempo molte persone non sono nemmeno consapevoli dell’esistenza di certe specie. “Non si sente la mancanza dell’uccello di cui non si conosceva l’esistenza”, afferma.
Nel regno digitale apparentemente infinito, è anche facile dimenticare i limiti naturali - che possono essere “estesi, ma non completamente eliminati”. In un sistema economico che incoraggia un consumo sempre maggiore, anche online, teme che le persone vedano sempre meno questi limiti.
Una critica non analogica
“Il problema non è la tecnologia”, afferma Marcello Vitali-Rosati. Il filosofo dell’Università di Montreal è una sorta di mago della tecnologia, avendo assemblato il suo computer da zero utilizzando hardware e software operativo indipendenti. “Il punto è che le tecnologie sono sempre più nelle mani di aziende private”, sostiene. E gli Stati, come “clienti”, ne sono sempre più dipendenti. Per questa ragione, non possiede uno smartphone.
Per il filosofo, la situazione sta diventando sempre più antidemocratica. Essere costretti a utilizzare software privati per accedere ai servizi pubblici, ad esempio scaricando un’app che funziona solo con i sistemi operativi dei giganti tecnologici, è come “tenere una riunione pubblica in un McDonald’s”, afferma.
“L’idea di democrazia è che le persone prendano decisioni. Le persone dovrebbero essere i proprietari e i decisori riguardo alla tecnologia che utilizzano. Questo non è solo un problema simbolico, è una questione di autorità”.
Sconnettersi o studiare?
Le idee per un futuro digitale più democratico non mancano: piattaforme di social media di proprietà pubblica, per esempio, o il controllo individuale dei propri dati. Tuttavia, è difficile trovare opzioni concrete, afferma Vitali-Rosati, perché “le istituzioni democratiche non ci stanno riflettendo abbastanza”. Gli Stati usano la scusa che “tutti hanno comunque un telefono” per affidarsi all’infrastruttura esistente delle Big Tech, aggiunge.
Secondo lui, la risposta dovrebbe essere duplice. In primo luogo, ritiene che gli Stati dovrebbero potenziare le competenze di alfabetizzazione digitale, in modo che i cittadini possano prendere decisioni informate su ciò che vogliono o non vogliono fare online. In secondo luogo, dovremmo abbandonare l’idea che ciò che è più efficiente sia naturalmente migliore; a volte è utile trovare “bug” nei meccanismi ben oliati della nostra esistenza digitale, afferma.
Per Vitali-Rosati, non avere uno smartphone è un esempio di bug benefico. Le complessità quotidiane che ne derivano, ad esempio, comunicare con la madre in Italia senza usare WhatsApp, possono essere istruttive, spiega. “Ti fa riflettere - devi analizzare la situazione, capire la posta in gioco e scoprire se c’è un altro modo di fare le cose. E per questo, devi capire meglio la tecnologia. Migliora l’alfabetizzazione digitale; questa è una parte importante per me”.
Siri, quell’amico sempre in ascolto
Setteventi 20.03.2025, 07:20
Contenuto audio