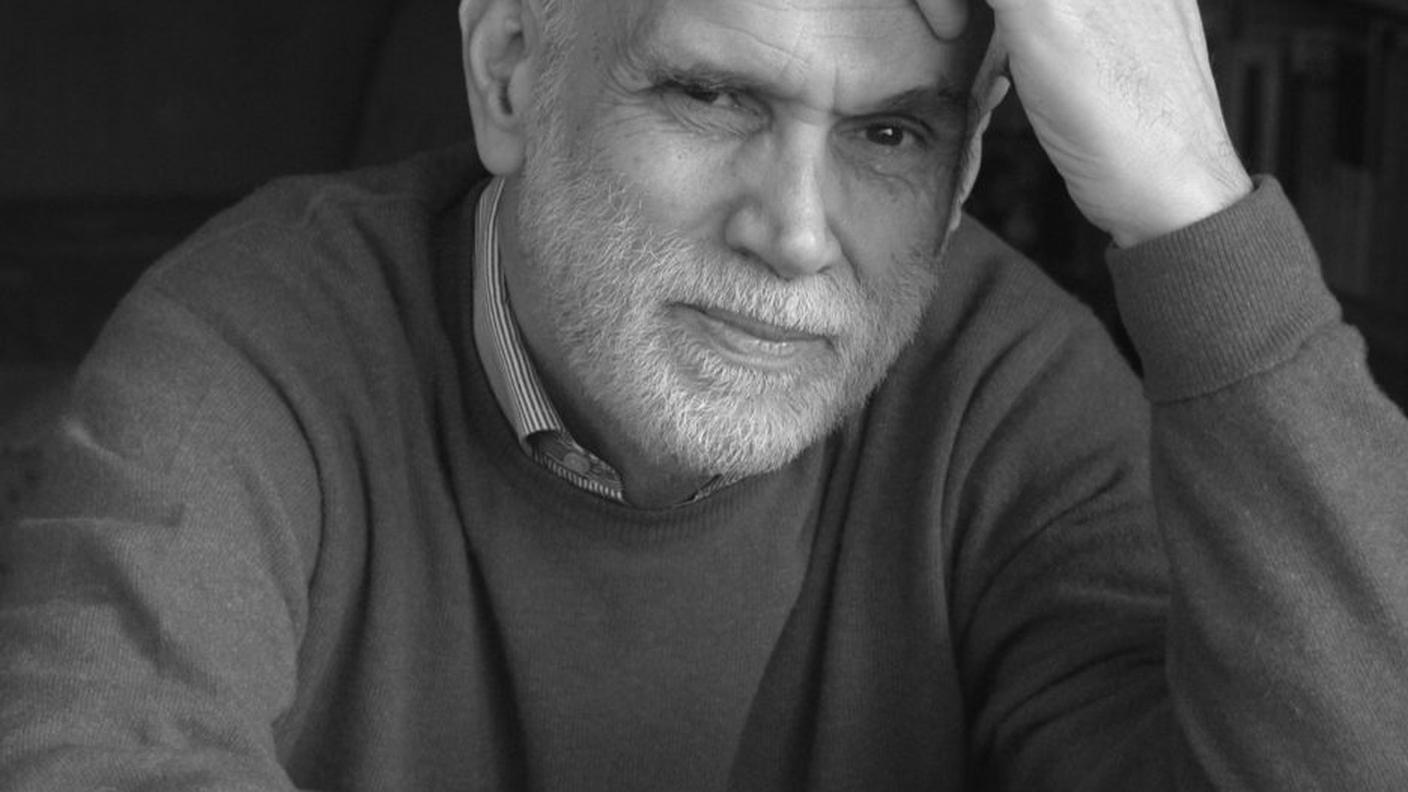Le “affinità elettive” intese come attrazione degli opposti, diceva giustamente Goethe, che sulla loro più intima essenza ha modellato un magnifico quanto disorientante romanzo, sono un fenomeno misterioso. Ma forse è proprio per questo motivo che esprimono taluni tratti di fondo della condizione umana, soprattutto una certa sua dimensione enigmatica, sfuggente, non immediatamente riconducibile alle comode e pacificanti categorie della ragione, della verità o almeno della verosimiglianza. Stefan Zweig e Joseph Roth costituiscono un tipico esempio di affinità elettiva, perché è piuttosto difficile immaginare due caratteri così distanti l’uno dall’altro, ma anche così vicini.
https://www.rsi.ch/s/1793967
Stefan Zweig, nato nel 1881, era un tipico enfant gâté della ricca borghesia viennese, mentre Joseph Roth, nato nel 1894 a Brody in Galizia, proveniva dalle zone periferiche in territorio polacco, a nord dell’impero austroungarico. Profondamente diversi sia per provenienza sociale e geografica, sia come narratori e letterati, ma uniti dalla comune origine ebraica e in seguito da un destino di esilio e sventura, Zweig e Roth vissero infatti un profondo rapporto di amicizia testimoniato da quasi duecentosettanta lettere che coprono un arco di undici anni, dal 1927 al 1938, e sono state pubblicate per la prima volta in edizione originale nel 2012 con un titolo ricavato da un passo di una lettera di Roth: Jede Freundschaft mit mir ist verderblich («Ogni amicizia con me è rovinosa»).
Sull’amicizia tra Roth e Zweig, che ha inizio nell’autunno 1927, circa un decennio dopo il crollo della monarchia asburgica, quando entrambi stanno vivendo un periodo di grande creatività e sono all’apice del successo letterario (Zweig era già allora uno degli autori di lingua tedesca maggiormente tradotti, insieme a Hermann Hesse e Thomas Mann; Roth era un narratore e cronista molto letto e apprezzato, richiestissimo dai quotidiani e dalle riviste), incombe fin da subito il presagio di quanto accadrà negli anni successivi. E’ un presagio che in un primo frangente sembra limitarsi al solo contesto letterario, ma in realtà ha radici più profonde, come emerge dalla bellissima e sofferta lettera che Zweig indirizza a Roth il 17 gennaio 1929: «Il mio atteggiamento nei confronti della letteratura è molto singolare. Ho cominciato a scrivere quando ero giovane, così, per ambizione, obbedendo a una giocosa pulsione spirituale. Non ho mai pensato di farne una professione. Non ho né le capacità, né l’inclinazione, né la predisposizione a vestire i panni del pontefice massimo e dell’aruspice letterario».
C’è soprattutto un passo molto rivelatore, perché spiega l’atteggiamento di Zweig negli anni a seguire: «Mi sento pressato, tormentato e turbato dal carico di obblighi e responsabilità, l’ammasso di corrispondenza e di carta stampata mi dà la nausea. Non viviamo più in quei tempi felici, quando gli scrittori potevano tacere anche per dieci anni. Al giorno d’oggi, la cattiva memoria delle persone pretende la continuità della produzione, pretende che il rubinetto resti sempre aperto».
Questa sfiducia nei confronti della letteratura e della sua funzione è il primo sintomo di uno scetticismo molto più ampio, che nell’evolversi del rapporto epistolare diventerà un lucido pessimismo nei confronti del corso delle cose e si trasformerà da ultimo in disperazione, conducendo sia Zweig che Roth, anche se per vie differenti, dapprima sull’orlo dell’abisso e poi nel medesimo baratro dell’autodistruzione. Scrive infatti Zweig in conclusione della lettera, con un’immagine che verrà poi ripresa da Gottfried Benn: «La vita vera è la doppia vita. Solo da anonimi si vede realmente il mondo». Col passare degli anni, e soprattutto con la salita al potere del nazismo in Germania, il presagio assume connotazioni sempre più oscure e minacciose. Entrambi sono costretti alla fuga e all’esilio.
Stefan Zweig: successo, esilio, addio alla vita (1./2)
Laser 23.11.2020, 10:00
Contenuto audio
Stefan Zweig: successo, esilio, addio alla vita (2./2)
Laser 24.11.2020, 10:00
Contenuto audio
L’eterno nomade Joseph Roth sceglie Parigi, la capitale europea dell’emigrazione, dove vivrà faticosamente, passando da un albergo e da un bistrot all’altro, per morire infine a soli 45 anni, il 27 maggio 1939, annientato come in un lento suicidio dall’abuso di sostanze alcoliche: «Ecco quel che sono: cattivo, sbronzo, ma in gamba», ha scritto alcune settimane prima di morire, sotto un disegno che lo ritrae appoggiato al banco di un bistrot e con in mano l’immancabile bicchiere di Pernod. Ci saranno anche alcuni incontri – in particolare a Ostenda, in Belgio, nell’estate 1936, nella leggendaria “estate dell’amicizia” rievocata negli scorsi anni in un bel libro di Volker Weidermann – nel corso dei quali il più anziano, paterno e soccorrevole Zweig tenterà di fornire aiuto all’amico, anche sul piano economico.
https://www.rsi.ch/s/903056
Ma ogni tentativo si rivelerà vano, perché la fuga di Joseph Roth, come dice il titolo del suo romanzo maggiormente autobiografico, è veramente una “fuga senza fine”: «Non ho quello che si suol definire un carattere “letterariamente” stabile – aveva scritto in una lettera del 1929 –. Ma è in assoluto che io non sono stabile. E’ da quando avevo diciott’anni che non vivo più in un’abitazione privata, al massimo ho trascorso una settimana come ospite da amici. Tutto ciò che possiedo sono tre valige».
La confessione più amara è tuttavia contenuta in una lettera dell’aprile 1933 – nel frattempo, come inviato del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine, Roth ha avuto anche modo di vedere coi propri occhi l’Italia fascista –, quando la canaglia hitleriana si è già impossessata della Germania e la peste bruna rischia di diffondersi per l’Europa: «Tutti noi abbiamo sopravvalutato il mondo. Io stesso l’ho sopravvalutato, io che sono il più pessimista dei pessimisti. Il mondo è molto, ma molto idiota, il mondo è bestiale. In una stalla di buoi c’è più intelligenza. Tutto: l’umanità, la civilizzazione, l’Europa, perfino il cattolicesimo, in una stalla di buoi c’è più intelligenza».
Un altro passo estremamente significativo, perché sottolinea in maniera chiarissima la vicina lontananza tra Roth e Zweig e chiarisce almeno in parte la controversa conversione dell’ebreo Roth al cattolicesimo, è infine contenuto nella lettera inviata dall’Hotel Foyot di Parigi nel luglio 1935: «Non credo nell’“umanità”, in cui non ho mai creduto, ma credo in Dio e nel fatto che l’umanità, verso la quale Lui non esercita alcuna grazia, non è altro che un letamaio. Tuttavia, spero nella Sua grazia. Lei non ha capito, perché credeva nell’“umanità”. Alla fine, l’amicizia è la vera patria. E lei può star sicuro che le resterò fedele più di chiunque altro».
Queste considerazioni del saturnino e disincantato Roth vanno a toccare un nervo scoperto, perché il pacifista e umanista Zweig continuò a coltivare speranze e illusioni contrarie a ogni evidenza, che gli vennero aspramente rimproverate anche da un altro esule come Klaus Mann e si profilano in particolare da una lettera del novembre 1933: «Bisogna imparare a vivere soli e nell’odio. Eppure io non risponderò all’odio con l’odio».
A differenza del nomade Roth, di stanza a Parigi, Zweig abbandonò l’Europa continentale e scelse inizialmente l’Inghilterra, ma allo scoppio del secondo conflitto mondiale fu costretto a stabilirsi dapprima negli Stati Uniti e infine in Brasile, dove si suicidò insieme alla seconda moglie Lotte Altmann il 23 febbraio 1942. Nell’ultima lettera indirizzata a Roth, datata dicembre 1938 e rimasta senza risposta, aveva espresso un augurio e insieme un timore. Il primo venne smentito, il secondo trovò purtroppo una drammatica conferma: «La saluto di cuore, con l’augurio che il nuovo anno, malgrado tutto, non sia peggiore di quello che sta per finire».
«Questo tempo, che si nutre di così tanto sangue, e così anemico di forza spirituale. Si conservi! E restiamo insieme, noi pochi!», dice una delle ultime lettere di Roth. Ma le cose andranno diversamente. Così lontani e così vicini, Joseph Roth e Stefan Zweig, perché entrambi hanno elevato la concreta dimensione dell’esilio a metafora (il “lontano da dove” di una vecchia storiella ebraica) e hanno vissuto in prima persona l’utopia del radicamento in una lontananza da un centro (un “dove”) che non esiste, ma che pure si configura quale coordinata imprescindibile. Ma soprattutto così lontani e così vicini nella ricerca di una salvezza impossibile, perché entrambi hanno vissuto il contrasto tipicamente ebraico ma latamente umano tra la vita e la Legge, il silenzio di Dio e il lacerante quesito relativo alla sua esistenza, i dubitosi raggiungimenti ma soprattutto le disperanti e irredente – perché irredimibili – miserie degli uomini.
Per definire la loro parabola umana non ci sono quindi parole più esatte (e purtroppo più attuali) di quelle che lo stesso Zweig, tre anni prima di metterle personalmente e tragicamente in pratica, aveva pronunciato nel discorso funebre per il compagno di fuga, esilio e sventura: «La colpa della sua fine è di questa nostra epoca ingiusta e scellerata, che spinge gli individui più puri a un livello tale di disperazione che, per odio contro questo mondo, non trovano altra salvezza che quella di annientarsi». Sono infatti parole che richiamano il breve scritto con la dicitura in portoghese declaração, “dichiarazione”, trovato accanto al suo letto di morte.
Parole di un umanista che prende congedo da un mondo inumano e che forse, rivolgendosi ai tanti amici ancora viventi ma dispersi chissà dove, pensa all’amico che non c’è più, perché lo ha preceduto nel grande baratro: «Il mondo della mia lingua è tramontato e l’Europa, la mia patria spirituale, ha annientato se stessa. Ritengo quindi che la cosa migliore sia abbandonare per tempo e con dignità una vita per la quale il lavoro spirituale ha sempre rappresentato la massima gioia, e la libertà personale il massimo bene che sia dato godere su questa terra. Saluto tutti i miei amici! Che sia loro concesso, dopo la lunga notte, di rivedere l’aurora! Io, troppo impaziente, ho scelto di precederli».