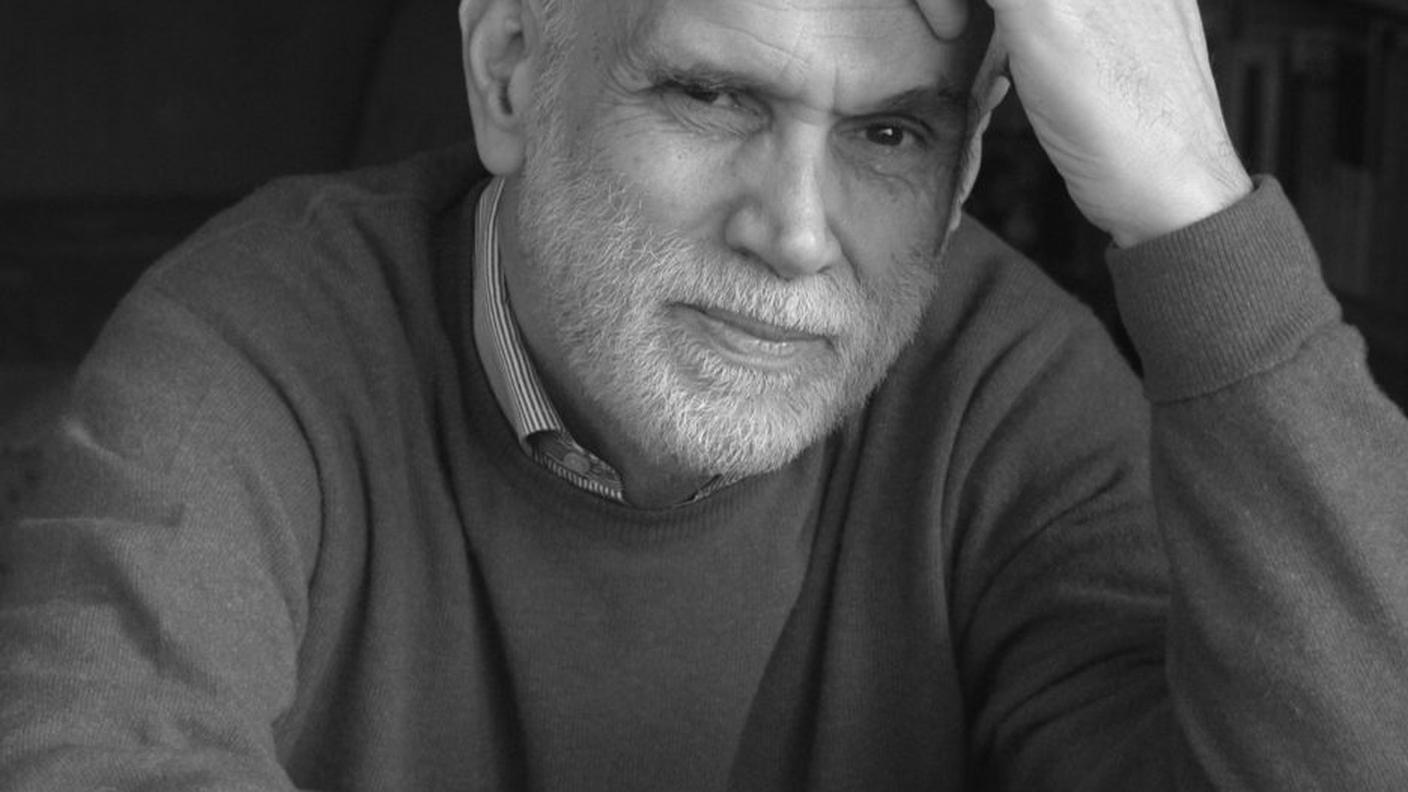Forse ha ereditato dal nonno, descritto nelle prime pagine del romanzo-confessione Le Furie, una spietatezza che nasceva dalla pietà, sicuramente ha vissuto nella costante percezione di trovarsi «in un mondo dove non vi sono più anime ma soltanto significati, non più persone ma potenze, traiettorie, allegorie, ragioni, furie, speranze senza volto». Un mondo che ha descritto, sviscerato, ricreato e reinventato nella scrittura, sempre nel miraggio che quelle speranze potessero infine avere un volto, ma anche nell’amara e dolente consapevolezza della vanità e inconsistenza di un simile miraggio. A mezzo secolo dalla morte, è anche questa la fondamentale e ineludibile eredità che si può ricavare dalla sua vicenda umana e poetica.
Archivi del '900: Guido Piovene
Diderot 03.04.2019, 17:05
Contenuto audio
Guido Piovene è stato con ogni evidenza lo scrittore più internazionale e cosmopolita di un preciso scorcio del Novecento letterario italiano, dai primi anni Cinquanta fino alla morte avvenuta il 12 novembre 1974 a Londra, dove si trovava come inviato per Il Giornale, che aveva fondato soltanto alcuni mesi prima insieme a Indro Montanelli. Narratore più per la necessità di chiarirsi a se stesso che non per intima vocazione e talento nativo, Piovene è stato soprattutto un cronista di razza, insieme al concittadino Goffredo Parise e Dino Buzzati tra i migliori dell’epoca, elegantissimo nelle scelte lessicali e più in generale nello stile, colto e raffinato, che immancabilmente elevava l’urgenza della cronaca allo spicco simbolico, nonché a una più ampia e differenziata visione e lettura della realtà.
Come cronista e reporter ha viaggiato moltissimo, non solo in Italia (il suo Viaggio in Italia, pubblicato nel 1957, rimane uno strumento imprescindibile per capire gli anni della ricostruzione e del boom economico, che hanno trasformato con troppa velocità un paese prevalentemente rurale in una nazione industrializzata), ma anche negli Stati Uniti, raccontati nel De America, in vari racconti e nell’abbozzo del Romanzo americano, nella Russia sovietica, in Medio Oriente, in Sudamerica, in Germania e nella Francia degli anni Sessanta, alla quale ha dedicato il bellissimo Madame La France.
Eppure per capire a fondo la sua opera bisogna partire dal luogo natio, che non è mai una semplice coordinata geografica, come ricordava giustamente Max Frisch parlando dell’odiamata Zurigo, ma piuttosto una sorta di fatalità biologica, in taluni casi un destino vischioso e gelatinoso, al quale è impossibile sfuggire. Piovene era infatti originario del cosiddetto Veneto “profondo”, più precisamente di quella Vicenza (dove era nato il 27 luglio 1907) ben poco palladiana ma anzi retriva, claustrofobica e “bianca” (nel senso di fortemente cattolica e tra i cosiddetti “feudi” del partito democratico cristiano, nel secondo dopoguerra), che tornerà poi in molte pagine del già ricordato Parise e in tempi più recenti negli scritti dello sfortunato e ipersensibile Vitaliano Trevisan, che è arrivato perfino a tracciare una specie di topografia dell’orrore della città – «una prospettiva palladiana di facciata» – e dei suoi dintorni, disegnando un baratro nel quale si è infine volontariamente gettato.
Non è un caso che lo stesso Trevisan, nei riferimenti bibliografici posti in calce al suo romanzo più disperatamente vicentino, I quindicimila passi, abbia espressamente citato Le Furie, che è il romanzo più vicentino di Piovene (così come Il prete bello, che riprende temi e suggestioni di Altre voci, altre stanze di Truman Capote, è il romanzo più vicentino di Parise). Esattamente come in Parise e Trevisan, Vicenza è presente dappertutto nell’opera di Piovene, anche quando non viene nemmeno nominata, perché costituisce un termine di paragone, si vorrebbe quasi dire un reagente chimico.
https://www.rsi.ch/s/1813889
Le origini vicentine (le «ereditate fatalità», secondo la definizione di Parise) permettono ad esempio di inquadrare in maniera adeguata alcune considerazioni contenute nel romanzo-saggio Verità e menzogna, pubblicato postumo nel 1975. All’epoca erano state praticamente ignorate oppure derubricate come espressione di un pessimismo del tutto anacronistico (si era pur sempre nel periodo dei grandi conflitti ideologici, veri o presunti), con l’unica eccezione costituita dal suo compagno di tristezze e malinconie Guido Ceronetti. Ma oggi, ormai esaurite le residue speranze nelle “magnifiche sorti” e nell’utopia illuministica à la Voltaire (l’idea di una società laica, pluralistica e avviata verso una crescita equilibrata e razionale), ci appaiono sotto ben altra luce.
Piovene afferma infatti una verità tanto indigesta da risultare quasi intollerabile: la democrazia delle società avanzate, accanto a molti indiscutibili meriti, ha il tragico demerito consistente nel fomentare l’angoscia, «perché ingrandisce a dismisura la nebbia enorme di persone di cui facciamo parte. Sono sue le trovate difensive più fortunate: l’uomo che rompe le catene, la sua rivolta, la liberazione, l’ascesa verso un grande futuro, il trionfo. Mentre procede però verso questo trionfo, la sensazione che ha di sé è di un essere sempre più meschino e avvilito della sua inesistenza».
L’origine nemmeno troppo remota di simili considerazioni è facilmente individuabile nelle impressioni ricavate durante il viaggio nell’Italia degli anni Cinquanta. E’ la verità dell’angoscia democratica, che Piovene ha riproposto e variamente declinato anche nelle opere narrative (in particolare Le Furie e Le stelle fredde) e in uno scritto a mezza via tra l’autobiografia e il saggio come il controverso La coda di paglia, del 1962, che in sostanza costituisce la preparazione a Le Furie, uscito l’anno successivo, dove gli stessi temi sono svolti in chiave romanzesca.
Il comunista Piovene (il “conte rosso”, come veniva sprezzantemente definito negli ambienti di destra) compie infatti un viaggio nella memoria personale (che coincide con alcuni luoghi specifici di Vicenza e dei dintorni, puntualmente descritti nel romanzo) e confessa le colpe del proprio passato: l’adesione alle menzogne del regime fascista quando lavorava per il Corriere della Sera, gli articoli che sostenevano la causa franchista durante la guerra civile spagnola e infine la recensione elogiativa di un libello antisemita di Telesio Interlandi, che gli costò l’amicizia con l’amico antifascista Eugenio Colorni (Ernesto, nella finzione letteraria). Tutte queste colpe, anche a distanza di decenni, continuano a inseguirlo e tormentarlo come le Furie della mitologia classica, che nell’iconografia appaiono quali dee vendicatrici alate, con serpenti al posto dei capelli e sangue che sgocciola dagli occhi. Sono le persecutrici degli uomini ingiusti, non solo in vita ma anche dopo la morte.
Le Furie non è il romanzo di un narratore puro e per molti versi è un’opera imperfetta e non completamente risolta, però rimane un libro di una devastante e insidiosa spietatezza, nel quale l’autoanalisi e il furore della verità (una verità tardiva, ma pur sempre una verità) sembrano rivoltarsi contro l’autore, aprendo continuamente nuovi abissi. Nel capitolo conclusivo, ambientato sul colle San Gottardo nella zona dei Monti Berici, l’io-narrante alias Piovene instaura perfino un dialogo con Cristo, «seduto su un sasso ad una svolta», e gli si rivolge in questi termini: «Insegnavi, nel mondo che era tuo, a salvare l’anima. In questo dove vivo è necessario farla, e nessuno sa come farla prima di esserci riuscito. So che si può essere gazze, piante acquatiche, spettri di persone esistite e non esistite, sassi, sguardi inutilmente lucidi galleggianti sul vuoto, e continuare a fingere di chiamarsi uomini. Il mondo delle anime decomposto emette servitù, terrori, rimorsi, staccati dal loro soggetto, che tornano su di lui, emissari sempre più stupidi di un mondo incomprensibile, non più volti ma assilli».
Date simili premesse, un lieto fine è semplicemente impensabile, perché le Furie non sono un semplice aspetto della vita ma corrispondono alla vita stessa, come emerge chiaramente nelle righe finali: «Subirò ancora l’ossessione dei mostri, nella paura delle catastrofi astratte che non verranno mai e nell’aria sospetta di un avvento in sospeso. Sento però che il mondo assorbe, consuma, dissolve le mie aure, le priva di ogni verità. Cosa rimane nel fondo? Non più le mie paure, ma l’anima profetica del mondo che sogna le cose future».
Mai come in queste righe, ma più in generale in tutto il romanzo, le speranze non hanno volto: Vicenza è il mondo e il mondo è Vicenza. Il primo a capirlo, non a caso, è stato il vicentino Parise, che ha parlato della “vicentinità” quale «endemica malattia dell’animo» e ha sintetizzato con parole molto penetranti il senso più profondo del romanzo-confessione dell’amico: «Questo groviglio interiore che non si esprime mai, coperto com’è dalla coltre delle false forme, questo pasticcio di cose improbabili per virtù di farnetico».
https://www.rsi.ch/s/1805988
Resta da chiedersi cosa rimane della vasta produzione di Piovene a cinquant’anni dalla morte. Forse non tutto, perché alcune opere narrative ci appaiono oggettivamente piuttosto lontane e datate, ma ciò che rimane è davvero fondamentale e imprescindibile. Non si può prescindere, infatti, da La coda di paglia e Le Furie, ma in definitiva non si può prescindere nemmeno da un romanzo come Le stelle fredde, pubblicato nel 1970, che sul piano squisitamente narrativo non è all’altezza de Le Furie, ma si addentra se mai possibile in abissi ancora più inospitali.
Lo spunto, almeno all’apparenza, è svolto prevalentemente in chiave saggistica, con inserti narrativi che rimandano alla struttura del racconto (capitoli molto brevi, dialoghi di poche battute e frasi apodittiche, simili a staccati musicali) più che a quella del romanzo. Abbandonato dalla donna che ama, il protagonista lascia la città e si trasferisce in campagna, in una casa ereditata dai genitori, dove però viene sospettato dell’omicidio di un abitante del luogo, forse a causa di antichi rancori. Per sottrarsi agli interrogatori, il protagonista abbandona la casa e si nasconde non lontano, in un luogo solitario tra le colline, dove fa due stranissimi incontri: un poliziotto filosofo e un personaggio che si rivela essere nientemeno che il fantasma di Dostoevskij.
Si potrebbe dire che Le stelle fredde è la continuazione de Le Furie con altri mezzi, in altri ambienti e con altri personaggi, ma l’approdo è lo stesso. Sollecitato dal serratissimo dialogo col fantasma di Dostoevskij, che merita di essere annoverato tra le pagine più belle di Piovene, il protagonista comincia a riflettere seriamente sulla propria vita, cosa che fino a quel momento non aveva mai fatto, trascinato e sommerso da un quotidianità senza scopo e senza scampo. Il fantasma di Dostoevskij gli ha infatti rivelato una sconvolgente verità: il mondo dei morti è l’immagine speculare del mondo dei vivi, che in realtà non sono vivi, perché sono semplici astrazioni, cose e non persone. Tutto è quindi un paesaggio di morte, ma è in un simile paesaggio che si compie la vita.
La fantasia di Piovene riesce a tradurre una simile verità in un’immagine di straordinario impatto: il protagonista vede se stesso nel mezzo di una sterminata quantità di persone (vive o morte?) che procedono stancamente verso una meta che non esiste, sempre alla stessa ora, nello stesso paesaggio e nella stessa stagione, in una luce giallastra e in un silenzio quasi assoluto, rotto soltanto dai latrati di alcuni cani che però non si vedono. Durante il cammino, le persone parlano tra di loro e si chiedono in quale posto siano mai finite. Ma non ci sono risposte, e intanto, l’una dopo l’altra, le persone sbiadiscono e scompaiono. E’ quasi inutile dire che c’è molta “vicentinità” anche in queste pagine e nei suoi “estri fiabeschi” (come li ha felicemente definiti Andrea Zanzotto), che presentano molte impensate analogie con Il prete bello di Parise: perché tutto è “fiaba”, ma tutto è anche “realtà”, e quindi insensatezza illusione e dolore, mentre la “vita” con le sue “speranze senza volto” è sempre da qualche altra parte, o forse in nessun luogo
Non si può prescindere, infine, dal primo grande reportage del dopoguerra, il viaggio in Italia, durato più di tre anni (dal maggio 1953 all’ottobre 1956), trasmesso originariamente alla radio e poi raccolto in volume. Un viaggio da Bolzano alla Sicilia, dalle Alpi all’estremo sud, nel corso del quale Piovene è riuscito a far emergere quella sorta di italianità eterna, se così la si può definire, già individuata più di un secolo prima da Stendhal. Un viaggio peraltro attualissimo, perché in settant’anni è cambiato tutto, ma in sostanza non è cambiato nulla.
Soltanto due o tre cose sono davvero cambiate dai tempi di Piovene: il paesaggio è stato sciaguratamente deturpato e cementificato, le città ormai si somigliano tutte, il tipo socio-antropologico si è uniformato, la politica si è ridotta a una meschina commedia delle urne. Uno dei primi a capirlo, circa tre decenni dopo Piovene, è stato Guido Ceronetti, anch’egli autore di un viaggio in Italia che tra infiniti disincanti tristezze e arrabbiature si è risolto infine nella «risposta del disprezzo muto, come parola estrema».
«Un’impresa senza precedenti dalla quale scaturì un libro senza precedenti, scrupoloso come un censimento, fedele come una fotografia, circonstanziato come un atto d’accusa. I guai, i nodi di quell’Italia di quasi quarant’anni fa sono alla fine gli stessi di ora, cioè di questi nostri giorni, convulsi e tormentati», ha scritto Oreste Del Buono in occasione di una ristampa del 1992, con parole che oltre trent’anni dopo sono sempre validissime.
Aveva ragione il suo collega e amico Montanelli quando scrisse che il Viaggio in Italia (ma alla presente altezza cronologica e con la giusta distanza critica si possono aggiungere anche La coda di paglia, Le Furie e Le stelle fredde) «dovrebbe essere testo d’obbligo nelle scuole italiane, tali sono la profondità e la nitidezza della sua sonda nelle pieghe e nelle piaghe del nostro Paese». Il cosmopolita, inattuale e irregolare Piovene ha consegnato a futura memoria l’attualissima verità – non solo italiana – delle “speranze senza volto”, di un presente sempre più opaco e una società sempre più lacerata, sfilacciata, nettamente divisa in quelli che Heinrich Böll aveva ironicamente definito “Sapienti” e “Residui”, chi prende le decisioni e chi le subisce.
Una verità molto amara, dietro la quale non si può fare a meno di avvertire il celebre ammonimento di Umberto Saba, che sognava la “calda vita” e invece, come Piovene, ha vissuto le “speranze senza volto” sotto le “stelle fredde”: «Gli esseri più pericolosi, più dannosi agli altri non sono le canaglie coscienti, i cinici, i mentitori volontari, ma gli oscuri, i confusi, i falsi sentimentali, quelli che fanno il male e credono di fare il bene, e ignorano i veri motivi delle loro azioni, che perciò sfuggono dalle loro mani e mettono il mondo a soqquadro».