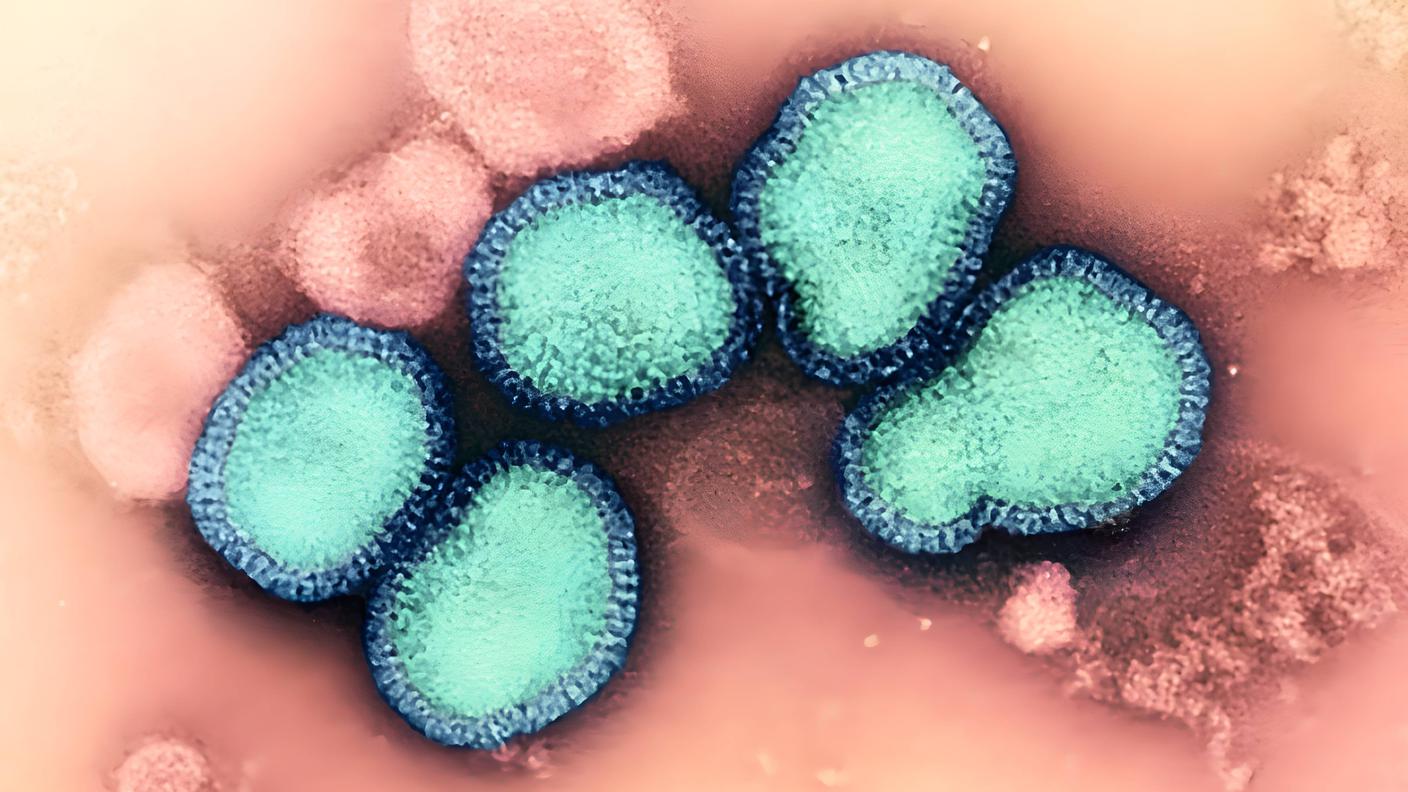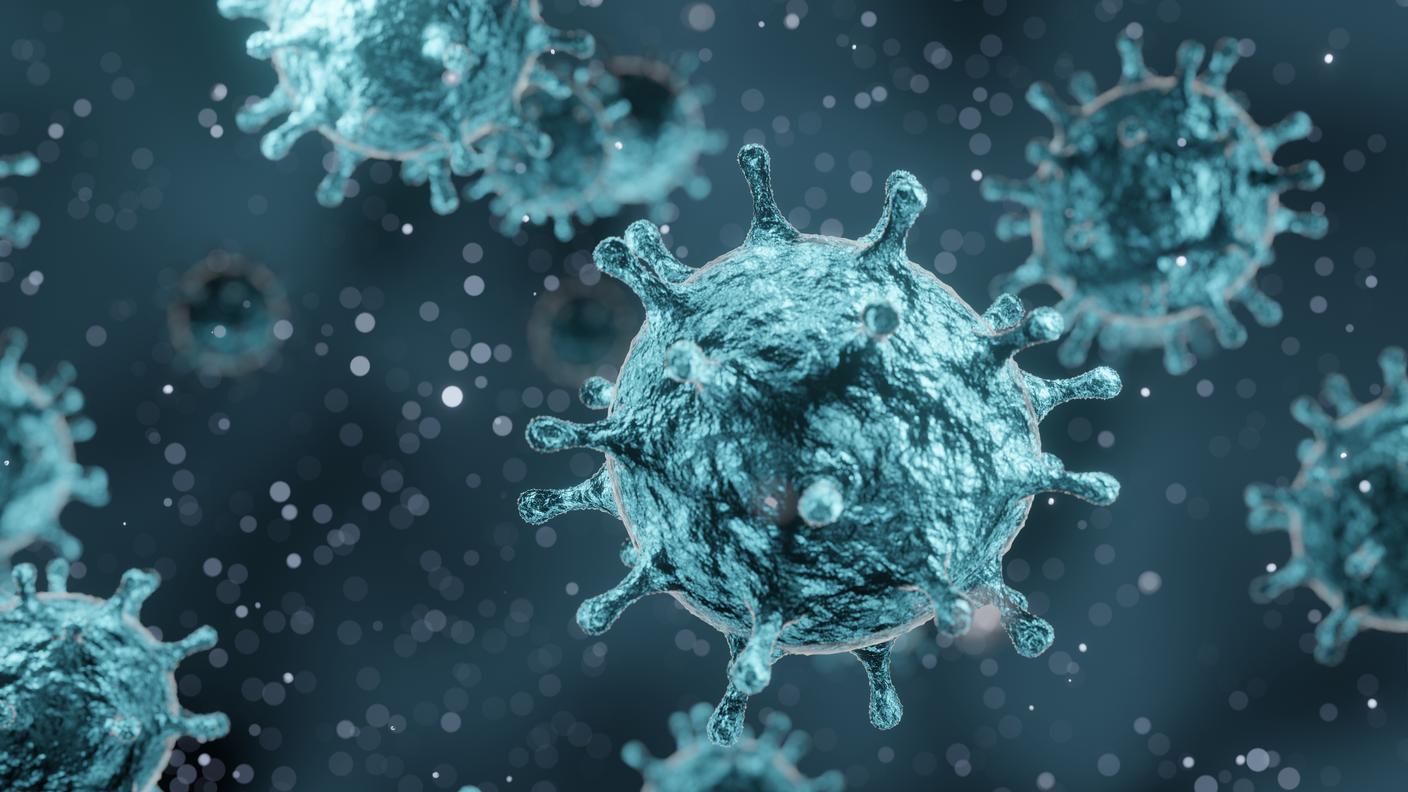Lo scoppio della pandemia di coronavirus ha segnato un prima e un dopo nella vita di tutti. E a dimostrazione di ciò vi sono alcuni termini che, se prima facevano parte di un immaginario lontano da noi, oggi sono diventati di uso comune. Pensiamo, ad esempio, alle parole “quarantena” e “isolamento”: la storia di questi termini è molto più antica di quello che potremmo pensare.
Per scoprire l’origine queste parole dobbiamo tornare indietro di qualche tempo, fino al XIV secolo. È questo uno dei periodi più bui della storia europea. Nel 1347 si diffonde rapidamente la Peste Nera causata dal batterio Yersinia pestis. Il batterio arriva in Europa dall’Asia centrale tramite le pulci dei topi che si trovano sulle navi che fanno tappa a Genova. Da qui si la malattia diffonde rapidamente dando origine a una successione di morti che fino al 1351 ha ridotto di più di un terzo la popolazione europea, uccidendo circa venticinque milioni di persone con un tasso di mortalità tra il 30% e il 75%.
Trionfo della Morte, 1446 ca., Galleria regionale di Palazzo Abatellis, Palermo.
Non sapendo come gestire questo morbo, gli uomini medievali provano rimedi di vario genere, talvolta alquanto stravaganti, come l’applicazione di alcuni animali – polli o serpenti – sulle parti del corpo infette. Le bestie avrebbero dovuto liberare il corpo dell’appestato dalla malattia attirandola su di loro. Ma, oltre a questi rimedi arcaici, viene utilizzato anche il distanziamento sociale ed è in questo ambito che nascono i termini di “quarantena” e “isolamento” nell’accezione che conosciamo oggi.
Venezia, in quel periodo, ha come fulcro della sua economia il commercio e per questo, con l’avvento della peste, inizia ad adottare misure estremamente rigide. Nel 1347 il doge della città marittima impedisce l’attracco alle navi che hanno a bordo persone potenzialmente infette e dal 1423 fa loro trascorrere un periodo di segregazione sull’isola di Santa Maria di Nazareth, oggi chiamata “Lazzaretto Vecchio”. È proprio qui che nasce il termine “isolamento”, dal momento che le persone venivano lasciate su quest’isola per essere curate e la loro permanenza durava finché guarivano dal morbo o ne morivano. E assieme all’isolamento nasce anche il termine “lazzaretto”, probabilmente dall’incrocio di “Nazareth”, il nome dell’isola degli appestati, e “Lazzaro”, il nome di un’isola vicina in cui venivano ricoverati i lebbrosi. I due nomi si sarebbero sovrapposti fino ad arrivare alla parola di uso comune “lazzaretto” (nazareth > nazareto > lazareto > lazzaretto).
Antono Visentini, Isola del Lazzaretto Vecchio, XII sec.
Il termine “quarantena”, invece, trarrebbe le sue origini dal latino: è da questa lingua che deriva il suffisso italiano “-ena” (dal latino “-eni”) che, aggiunto al numero quaranta gli dà il significato di “quaranta per volta”. In italiano, inizialmente, la parola viene usata in ambito religioso col significato di “periodo di quaranta giorni” ed era in uso per le pratiche devozionali, liturgiche o penitenziali. Sembrerebbe che sia solo dal XV secolo che la parola inizi ad essere utilizzata in ambito medico per indicare un periodo di isolamento sanitario di quaranta giorni. Questo utilizzo lo si ritrova, ad esempio, a Venezia. Nel 1468 viene deciso che chi vuole entrare nella città, visto il pericolo sempre presente della peste, deve trascorrere un periodo di quarantena, quindi quaranta giorni di isolamento da passare sull’isola del Lazzaretto Nuovo che, data la sua maggiore superficie, sostituisce l’isola Lazzaretto Vecchio. Nel corso del tempo, “quarantena” perde il significato specifico di “periodo di quaranta giorni” venendo a indicare anche periodi di altra durata, ma assume il significato di periodo di isolamento, come lo conosciamo e lo abbiamo vissuto anche noi.
Invece, molti secoli più tardi viene coniata un’altra parola che ha pervaso i dialoghi tra le persone durante la pandemia: il “vaccino”. Per capire dove trae le sue origini bisogna spostarsi alla fine del XVIII secolo, quando il medico Edward Jenner scopre come immunizzare le persone dal vaiolo. Il medico britannico scopre che le persone che si ammalano di vaiolo bovino contraggono una forma di malattia meno grave rispetto a quella umana e comincia ad inoculare i batteri del vaiolo bovino nei pazienti che, così facendo, non si ammalano più della variante umana. Da quel momento, la parola “vaccino”, che ha le sue radici nel derivato latino di vacca “vaccinus”, viene impiegato con l’accezione che gli diamo noi oggi in campo medico.
Amsterdam, 1949. Popolazione in attesa del vaccino contro il vaiolo.
A cinque anni dalla pandemia di coronavirus possiamo dire che anche questo capitolo, così come quelli che vi abbiamo raccontato, è entrato a far parte degli avvenimenti storici che si studieranno in futuro. E se il tema delle malattie e di come l’uomo, con il suo ingegno, sia riuscito a superare questi momenti di crisi ha stuzzicato il vostro interesse, il Giardino di Albert ripercorre le tappe salienti di questa storia nella puntata “La storia dell’igiene”.