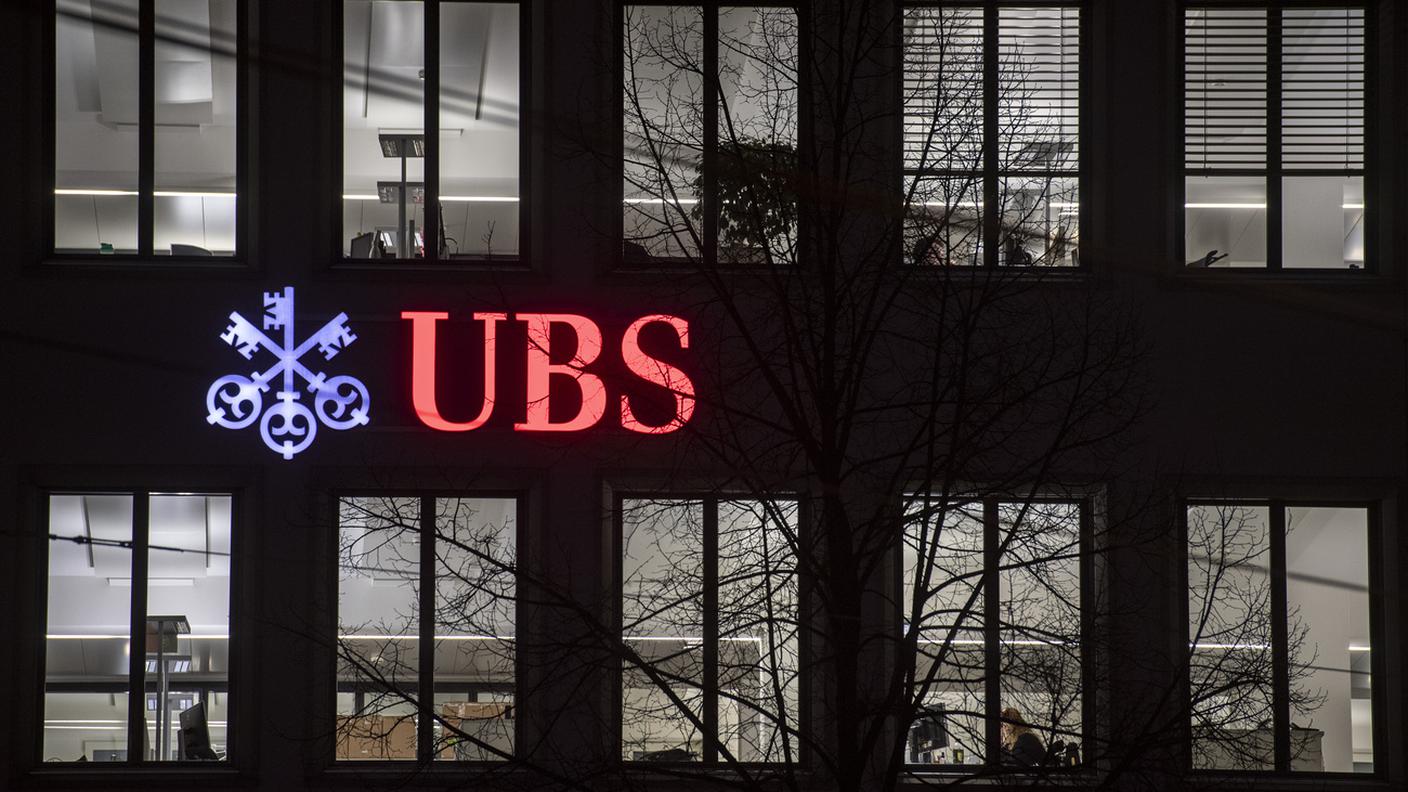Preventivi, tagli, finanze sane, spesa pubblica, austerità, investimenti pubblici, freno ai disavanzi, parametri di Maastricht, manovre di rientro… Sono tutte parole che sentiamo quasi quotidianamente, dalla politica, dagli economisti e da altri attori pubblici e privati. E sono tutte parole legate a doppio filo al concetto di debito pubblico.
- Perché il debito pubblico della Svizzera è così basso? - tvsvizzera
https://www.tvsvizzera.it/tvs/qui-svizzera/perch%C3%A9-il-debito-pubblico-della-svizzera-%C3%A8-cos%C3%AC-basso-/48854498#:~:text=A%20fine%202019%2C%20dunque%20alla,salito%20al%2027%2C6%25
Lo si è visto in tempi recenti a Berna con l’approvazione del preventivo della Confederazione, e a discussioni simili assisteremo da domani in Gran Consiglio a Bellinzona, con il preventivo della discordia, quello del 2024 non ancora approvato. Come pure è di venerdì la notizia che la Germania si ritroverà con un deficit di finanziamento di 40 miliardi di euro entro il 2025 e che sta provocando una spaccatura nel governo di Olaf Scholz, che vorrebbe sospendere il freno al debito in questo momento difficile, ma che incontra la più ferma opposizione del “suo” ministro delle finanze, il liberale Christian Lindner. Freno al debito, o ai disavanzi che dir si voglia, che anche in Svizzera e in Ticino è iscritto nella Costituzione.
Intervista a Christian Vitta - 60 Minuti del 14.11.2023
RSI Info 14.11.2023, 22:22
Eppure, negli ultimi anni segnati da diverse crisi (pandemica, energetica e geopolitica), tanto a Bruxelles quanto a Washington, non è mancata un’inversione di rotta con piani multimiliardari di stimoli pubblici implementati “a debito”. Anche in Svizzera durante la pandemia si sono spesi parecchi miliardi. Ma nel mondo germanico e dei Paesi “frugali” del Nord Europa si è presto tornati a voler tenere appunto a freno la crescita del debito (con la differenza che in Svizzera e in altri Paesi del nord l’economia va decisamene meglio di quella tedesca). E anche in Ticino è questa la visione dominante, basti pensare alle parole pronunciate dal presidente del PLRT Alessandro Speziali, riportate dai quotidiani, che al comitato cantonale di giovedì, proprio parlando di debito pubblico, ha messo in guardia dal rischio di “meridionalizzazione” dello Stato.
https://rsi.cue.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Gran-Consiglio-presentati-oltre-60-emendamenti--2057941.html
https://rsi.cue.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/La-piazza-alza-la-voce-contro-il-preventivo--2046510.html
Noi abbiamo voluto cercare di capirne di più, a tutti i livelli, con un’approfondita intervista a Sergio Rossi, professore di macroeconomia e politica monetaria all’Università di Friburgo. Una visione di stampo keynesiano, che in alcuni aspetti si discosta da quella di “maggioranza”, ma che – considerando che la scienza economica è una branca delle scienze sociali, quindi non esatta – va ad ampliare la dialettica alla base di tutti gli ambiti scientifici.
Sergio Rossi
Professor Rossi, partiamo da una breve spiegazione tecnica per capirci meglio: che cosa sono il debito pubblico e il tasso di indebitamento di uno Stato?
Il debito pubblico è quello che anno dopo anno lo Stato non riesce a pagare tramite le imposte che raccoglie, per cui si deve indebitare per finanziare la spesa in disavanzo e anno dopo anno questo disavanzo pubblico si accumula e diventa un debito pubblico. Il tasso di indebitamento è, rispetto alla spesa pubblica totale, quanto lo Stato si deve indebitare. Se raccoglie imposte nella misura dell’80% di quanto lo Stato spende, il tasso di indebitamento è del 20%. Se ne raccoglie il 90, il tasso di indebitamento del 10%. Dunque è un po’ il peso, come si dice spesso, del debito pubblico sulle prossime generazioni fiscali. Se lo Stato investe per costruire un nuovo ospedale, questo viene finanziato – correttamente - a debito e l’ospedale verrà pagato dalle prossime generazioni fiscali, che pure approfitteranno del servizio – tramite le loro imposte.
Il tasso di indebitamento, anche per essere maggiormente raffrontabile a livello internazionale, è spesso epresso anche in relazione al Prodotto interno lordo di un Paese. In questo senso la Svizzera ha un tasso d’indebitamento, a fine 2022, pari al 15,6% del PIL, a cui però vanno aggiunti i debiti pubblici cantonali e comunali. Risultato, sempre a fine 2022: 27,6%. Come giudica questo livello di indebitamento?
Si tratta di un livello di indebitamento pubblico molto basso rispetto agli altri Paesi europei, e anche a quelli fuori dall’Europa, pensiamo agli Stati Uniti o al Giappone. Oltretutto si tratta di un tipo di debito pubblico che permette all’economia svizzera, di avere un tasso di crescita dell’economia, ma anche di sviluppo per la popolazione, molto interessante. Anche perché senza debito pubblico l’economia rallenta. Lo abbiamo visto durante i periodi 2020/2021 e fino a inizio 2022: lo Stato era un partner indispensabile per l’economia privata. Quando l’economia va male, lo Stato deve rilanciare le attività economiche indebitandosi, ma per attività poi che fanno del bene anche alla popolazione.
In Ticino (dato 2021) abbiamo circa 2,2 miliardi di debito e un PIL vicino ai 30 miliardi, che vuol dire un tasso di indebitamento di circa il 7,5%. Come lo giudica a livello intercantonale? (Dati 2020: GE: 45,4%/ZH; 15%/BS: 11,7%/ZG: 6,9%/VD: 1,8%, fonte: studio comparativo istituto CREA e Canton Vaud)
Indubbiamente il Cantone Ticino è meno concorrenziale dal punto di vista del debito pubblico rispetto ad altri cantoni (soprattutto quelli svizzero tedeschi, ma non tutti, ndr), ma proprio perché il Ticino ha una realtà economica particolare, così come una realtà geografica particolare: siamo un cantone di frontiera e abbiamo la barriera fisica del San Gottardo, oltre ad essere una minoranza linguistica. Le ragioni sono quindi molteplici. Chiaramente l’economia ticinese non è così attraente come lo è quella del Canton Zurigo o del Canton Zugo, per fare solo due esempi, e può dunque attrarre meno capitali, stranieri o anche da altri cantoni, per cui lo Stato deve fare uno sforzo maggiore. Anche perché purtroppo in Canton Ticino molte persone che lavorano non hanno uno stipendio che permette loro di vivere e arrivare a fine mese. Lo Stato si deve pertanto far carico – tramite i contribuenti - pagando una parte di quello che dovrebbero pagare le aziende ai loro collaboratori. Anche questo pesa poi sulle finanze pubbliche e a fine anno sul debito che lo Stato accumula per finanziare la propria spesa pubblica.
La Germania, tra i grandi Paesi occidentali considerato il più virtuoso e sempre preso a modello in ottica di debito pubblico, ha un tasso di indebitamento del 59,8%. Guardando questo semplice raffronto a due (CH-DE), a livello tecnico, lo spazio di manovra teorico di spesa e investimento appare parecchio ampio, prima di toccare livelli allarmanti. È così?
La Svizzera dispone assolutamente di un margine di manovra per l’indebitamento pubblico a vantaggio di tutta la collettività. Il caso della Germania è emblematico: il rapporto debito pubblico/PIL è molto superiore a quello della Svizzera e oltretutto la Germania ha cercato di ridurre il debito riducendo anche gli aiuti alle persone bisognose. Dopo la riunificazione delle due Germanie si è cercato di essere competitivi verso le economie asiatiche e si è ridotto il costo unitario del lavoro anche per poter esportare maggiormente. Non solo ha ridotto gli stipendi, ma ad esempio anche i sussidi per i disoccupati e dell’aiuto sociale, per cercare di stimolare le persone a lavorare. Però in Germania c’è un problema, come in altri Paesi europei: la domanda nel mercato dei prodotti è carente proprio perché le imprese hanno ridotto il livello salariale. E la pressione al ribasso sugli stipendi ha portato le persone a dover far capo all’aiuto sociale o ad avere dei piccoli lavoretti con cui però non si arriva a fine mese. Il debito pubblico deve comunque finanziare una spesa dello Stato perché altrimenti le persone o si rivoltano contro lo Stato, e lo vediamo bene anche in questi mesi, oppure devono partire o rischiano di fare la fame. La Svizzera ha adottato il freno all’indebitamento anche perché da noi, come in Germania e in generale nel mondo germanico a maggioranza protestante, la parola debito, in tedesco Schuld, vuol dire che qualcuno ha commesso un peccato e deve pagarne le conseguenze. Però purtroppo spesso i politici dimenticano che se lo Stato non si indebita, se dunque non c’è un aumento del debito pubblico, saranno i privati a doversi indebitare. E la crisi dei subprime e del credito privato negli Stati Uniti del 2006, diventata poi crisi finanziaria globale nel 2008, è lì a dimostrare che questa a lungo termine non è una strada percorribile. Se lo Stato non può indebitarsi perché c’è un freno all’indebitamento, l’economia rallenta e rischia di cadere in recessione e la Germania non è tanto lontana da questo scenario.
Come si spiega quindi che Paesi come la Francia (98%), l’Italia (134%), gli Stati Uniti (125%) e il Giappone con addirittura il 260% non siano ancora falliti? Come riescono questi Stati a finanziare questo debito e quando è accettabile un livello alto? E qual è a suo modo di vedere un livello corretto oltre il quale non andare?
Questa è una grande domanda. Chiaramente se lo Stato si deve indebitare perché non può o non vuole raccogliere abbastanza imposte per finanziare la propria spesa, questo debito pubblico consiste nell’emettere e vendere obbligazioni pubbliche nei mercati finanziari. Gli Stati Uniti, ma anche altri Paesi che lei ha menzionato, la Francia, l’Italia e non da ultimo il Giappone, per pagare la spesa pubblica in disavanzo si devono indebitare e per farlo devono emettere e vendere obbligazioni nei mercati finanziari. C’è quindi una ricchezza privata in questi Paesi, o anche nel resto del mondo globalizzato, che viene spesa per acquistare questi titoli di debito pubblico che poi danno degli interessi più o meno elevati. Nell’emblematico caso italiano, i contribuenti pagano delle imposte allo Stato, che le usa anche per pagare gli interessi a chi ha acquistato le proprie obbligazioni pubbliche. Così sono però le persone più ricche a trarre vantaggio dalla situazione, perché sono loro che hanno un patrimonio finanziario e che decidono di acquistare le obbligazioni dello Stato. La ricchezza va quindi verso chi già ne possiede molta a discapito del bene comune, visto che una parte sempre maggiore delle risorse raccolte va a pagare gli interessi a scapito delle prestazioni che lo Stato italiano eroga (istruzioni, sanità, trasporti ecc.), e di conseguenza a discapito della coesione sociale.
Per quanto riguarda invece la soglia ideale, in realtà non ce n’è una oltre la quale il rapporto fra il debito pubblico e il PIL diventa problematico. Nel Trattato di Maastricht di inizio anni ‘90 con cui poi si è creata la moneta europea, si era stabilito che gli Stati devono ridurre entro il 60% del PIL il loro debito pubblico perché altrimenti non possono far parte della zona euro oppure devono pagare delle sanzioni e quant’altro. Però questo rapporto del 60% fra debito pubblico e PIL è arbitrario, un’immaginazione degli economisti del pensiero dominante e non ha alcun fondamento scientifico. Io mi posso indebitare a giusta ragione per costruire una casa oppure a cattiva ragione per acquistare il pane che altrimenti non riesco a mangiare. Insomma, più che dal livello e dalle soglie, dipende dall’oggetto del debito pubblico. Il debito pubblico è sano e buono, lo diceva anche Mario Draghi qualche anno fa, quando serve a finanziare degli investimenti che lo Stato fa a vantaggio della collettività. Mentre c’è un debito pubblico cattivo, come anche quello privato cattivo, quando serve solo a finanziare la spesa corrente, che invece va finanziata con le imposte.
Parametri di Maastricht che restano in teoria validi, ma che sono stati decisamente flessibilizzati nell’ultimo Patto di stabilità UE proprio per evitare l’austerità e perché nella realtà raramente sono stati rispettati da tutti. Anzi, con le crisi degli ultimi anni si è assistito a piani di investimenti pubblici miliardari tanto a Bruxelles quanto a Washington come misure anticicliche. Tra i paletti di Maastricht c’era anche il rapporto massimo del 3% tra il deficit (disavanzo annuale) e il PIL. Un paletto che somiglia molto al freno all’indebitamento svizzero, così come a quello ticinese, da noi ancora pienamente in vigore. Secondo lei ha senso avere finanze impeccabili, ma non investire in tempi di crisi e anzi procedere con austerità e tagli?
No, non ha assolutamente senso. Lo Stato deve guardare come va l’economia e la società e le prospettive per i prossimi 2 o 3 anni. Se queste prospettive e la situazione attuale sono poco rosee, lo Stato si deve indebitare, ma con dei progetti intelligenti che vanno poi a far crescere l’attività economica e a far star meglio la popolazione residente. Chiaramente, di riflesso, lo Stato deve accantonare delle riserve quando l’economia va bene, mettere fieno in cascina come si dice. Però spesso i politici si dimenticano che quando l’economia va bene devono raccogliere le imposte per ripagare il debito pubblico che si era acceso quando l’economia andava male. È questa asimmetria del comportamento dei politici al governo che pone un problema: quando l’economia va davvero male, lo abbiamo visto durante la pandemia, anche i politici di destra dicono che lo Stato deve aiutare, soprattutto le aziende bisognose. Poi però, quando l’economia riparte, gli stessi politici dicono al governo che bisogna ridurre il carico fiscale, altrimenti i ricchi contribuenti se ne vanno. Però se riduciamo le aliquote d’imposta, chiaramente le risorse fiscali diminuiranno e non si potranno ripagare i debiti pubblici accesi quando l’economia andava male. Per farla breve, per rispettare quanto appena detto, quando l’economia riparte le aliquote fiscali non vanno toccate.
A livello svizzero e ticinese la volontà di contenere il debito pubblico sembra però ampiamente condivisa a livello politico. Seppur in Ticino da sinistra (PS) sia stato proposto un congelamento del freno ai disavanzi, ma temporaneamente per due anni, l’assunto dei conti pubblici che devono essere perfettamente in ordine e l’avversione al debito, e quindi il sostegno al “freno”, sembra interiorizzato e non viene praticamente messo in discussione, tantomeno a Berna. Basti pensare che a livello nazionale questo strumento fu accettato alle urne nel 2001 con l’85% dei consensi. Come se lo spiega?
Il problema risale alla fine degli anni ‘80 del secolo scorso, quando nelle principali università, soprattutto nordamericane, si è fatto tabula rasa degli economisti cosiddetti eterodossi che avevano un pensiero diverso da quello dominante. A quel tempo la finanza pubblica americana aveva i propri problemi, ma anche in Europa, pensiamo ancora al caso italiano… Pertanto si dava la colpa allo Stato spendaccione dicendo ‘meno Stato e più mercato farà del bene a tutti’. E anche sul piano accademico si sono prodotti degli studi parascientifici o pseudoscientifici dove si pretendeva di dimostrare che lo Stato è un ostacolo all’attività economica, che è un peso morto che va dunque ridimensionato. Questi studi sono stati criticati da economisti non del pensiero dominante, che però col passare delle generazioni sono morti o sono andati in pensione e sono stati ignorati. E spesso e volentieri gli economisti accademici leggono solo i lavori di ricerca pubblicati negli ultimi anni e non quelli dei decenni passati, meno ‘allineati’. Ma a livello scientifico non si ragiona a maggioranza, serve una dialettica, uno spirito critico, un pensiero alternativo. E lo vediamo oggi: senza debito pubblico l’economia privata rallenta e sprofonda in recessione quando c’è una crisi pandemica, una crisi finanziaria o una crisi geopolitica come in questi anni. Per cui bisogna ripensare l’insegnamento della scienza economica come scienza sociale, ma anche comportamentale, dove il ruolo dello Stato e la natura della moneta vanno studiate a fondo per capire che senza Stato l’economia di mercato non può vivere a lungo, come senza Stato le imprese non possono fare degli utili. Il paradosso keynesiano dice che se lo Stato si indebita, questo non va a discapito dell’economia, ma va a vantaggio delle imprese. Perché se lo Stato si indebita vuol dire che spende maggiormente, e questa spesa va a finire nel circuito economico. Dunque, presto o tardi le imprese ne raccoglieranno i frutti. E producendo maggiori utili, potranno investire maggiormente, aumentando gli stipendi e l’occupazione sul territorio nazionale. Nella realtà però, visto che gli stipendi sono fermi al palo a cui si aggiungono i rincari, il potere d’acquisto dei lavoratori è sceso. Anche perché spesso le imprese parcheggiano gli utili nei mercati finanziari dai quali sperano di raccogliere dei rendimenti a vantaggio di chi possiede le loro azioni, compresi i loro manager, ma senza investire in maniera produttiva. Viene poi a mancare l’innovazione tecnologica che permette di essere competitive nell’economia globale e per cercare di restare competitive, come nel caso della Germania, fanno una pressione al ribasso sugli stipendi. E si innesca un circolo vizioso: calo degli stipendi e del potere d’acquisto, calo delle vendite, licenziamenti.
Un’ultima domanda: ora i tassi d’interesse, seppur ridiscesi un po’, sono decisamente più alti del recente passato. Fino a due anni fa erano a livelli irrisori se non addirittura negativi. Eppure, restando in Ticino, a parte qualche rarissima proposta – l’ex presidente PLRT e già Consigliere nazionale Rocco Cattaneo, nel 2015 quando il tasso d’indebitamento ticinese era al 10% (ora circa 7%) e quello svizzero al 35% (ora 27,6%) - invocava per il Ticino un “Piano Marshall” di investimenti pubblici da 2 miliardi – non si è proceduto in questo senso. Perché?
Certamente nell’era dei tassi d’interesse negativi terminata un paio d’anni fa in Svizzera, sarebbe stato intelligente, non solo interessante, per lo Stato investire in progetti che poi permettevano, per esempio, di avere una transizione ecologica in tempi ragionevoli, nell’interesse collettivo. Però a quel tempo mancava sia la volontà politica sia la capacità di investire, perché un investimento non è come acquistare un’automobile. Un investimento va programmato, va discusso sul piano politico, c’è la possibilità di referendum e quant’altro, per cui i tempi si allungano e quando magari l’investimento è finalmente approvato, i tassi di interesse sono già lievitati. Bisognerebbe sempre avere nel cassetto dello Stato dei progetti di investimenti da attuare, soprattutto quando i tassi di interesse si riducono. E soprattutto, direi a maggior ragione, quando l’economia va male. Quando l’economia va bene lo Stato può rallentare la spesa pubblica, gli investimenti, ma anche quella corrente, perché tanto l’economia privata gioca il proprio ruolo. Però bisogna comunque tener presente che l’investimento pubblico è qualcosa di positivo per l’insieme della collettività e fa bene alle imprese e ai privati. Se costruisco un tunnel autostradale o una scuola pubblica, le imprese ne traggono vantaggio perché sono loro a costruirli.
- Studio comparativo Istituto Crea - UNIL (francese)
https://geneve-attractive.ch/sites/default/files/source/docs/crea_attractivite_geneve_rapport_20230503.pdf

Ticino: tra tagli, Preventivo e revisione della spesa
SEIDISERA 30.01.2024, 18:19
Contenuto audio

Preventivo 2024, firmato il rapporto di maggioranza
Il Quotidiano 23.01.2024, 19:00

Preventivo 24, le reazioni della minoranza
Il Quotidiano 23.01.2024, 19:00